Archivio
L’evasione di Franca Salerno e Maria Pia Vianale
Prendo da Infoaut questo racconto dell’evasione di Franca e Maria Pia.
Proprio oggi, proprio ora, appena rientrata dai funerali di Franca Salerno. Funerali di cui ancora non riesco a scrivere…
CIAO FRANCA
I primi mesi del 1977 furono caratterizzati, in tutta Italia, da numerose rivolte all’interno delle carceri e da un consistente numero di evasioni da parte di militanti politici. Tra queste si annovera quella di Franca Salerno e Maria Pia Vianale, militanti dei Nuclei Armati Proletari, avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 Gennaio; grazie ad un’azione coordinata tra l’interno e l’esterno dell’edificio, le due militanti riuscirono infatti ad evadere dal carcere femminile di Pozzuoli in cui erano rinchiuse in attesa del processo. Il progetto di fuga comprendeva inizialmente anche la terza compagna di cella delle due Nappiste, Rosaria Sansica, la quale decise però di rinunciare perché aveva ottenuto qualche tempo prima la libertà provvisoria per motivi di salute.
In quel periodo l’azione dei NAP era rivolta soprattutto alla liberazione dei militanti arrestati e a far sì che i processi in cui erano coinvolti non potessero aprirsi (obiettivo che veniva perseguito creando difficoltà a formare la giuria popolare e tramite una serie di proclami e ricusazioni volti a vanificare l’intero procedimento processuale), motivo per cui l’evasione fu programmata in concomitanza con il primo processo ai NAP che si stava svolgendo a Napoli, in cui erano imputate anche Franca Salerno e Maria Pia Vianale. Questa linea d’azione venne tra l’altro ribadita nel comunicato diffuso dall’organizzazione subito dopo la fuga dal carcere di Pozzuoli, in cui si legge: “La nostra libertà come è dovere di ogni rivoluzionario ce la riprenderemo da soli evadendo. Dalle carceri dai ghetti dove ci costringe la società borghese usciremo con le nostre forze. L’evasione è un momento della nostra lotta alla repressione di Stato”. Il ciclo di evasioni e rivolte mise in difficoltà le autorità carcerarie che, nel caso di Pozzuoli, licenziarono il Direttore del carcere nel tentativo di ricondurre a una negligenza della direzione quella che in realtà era un’azione politica su scala nazionale che non poteva non destare preoccupazione in chi quotidianamente si affannava a garantire un ordine ormai ampiamente compromesso.
Il 24 Gennaio, in sede processuale, la fuga delle due Nappiste venne rivendicata tramite la lettura del seguente comunicato:“Sabato 22 Gennaio, alle ore 4, l’organizzazione comunista combattente NAP ha attaccato il carcere-lager di Pozzuoli. L’azione tendente alla liberazione delle compagne Franca Salerno e Maria Pia Vianale, militanti dell’organizzazione, si è sviluppata con un attacco coordinato interno-esterno ed ha raggiunto in pieno l’obiettivo fissato…il terreno reale dello scontro si sviluppa ora totalmente all’esterno dell’aula…è solo sulla parola d’ordine “portare attacco al cuore dello Stato” che si supera la parzialità delle esperienze di lotta armata e si ricompone l’unità della classe delle sue avanguardie armate nel partito combattente”.Il processo si protrasse fino al 16 Febbraio, data nella quale la Corte inflisse 289 anni e 11 mesi di carcere a 22 nappisti (nonostante molti degli imputati si fossero dichiarati non appartenenti all’organizzazione).
 Al dato delle condanne va però affiancato il percepibile clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni che permeò l’aula per l’intera istruttoria: l’evasione di Franca Salerno e Maria Pia Vianale, infatti, non aveva certo contribuito a ristabilire la certezza dell’ordine e della legge. Le due militanti, sfuggite alle condanne di Febbraio, furono però nuovamente catturate il 1 Luglio, a Roma, assieme ad Antonio Lo Muscio, che rimase ucciso durante l’arresto in seguito ad una pallottola sparata a bruciapelo dalla polizia che lo raggiunse alla testa mentre si trovava già a terra.
Al dato delle condanne va però affiancato il percepibile clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni che permeò l’aula per l’intera istruttoria: l’evasione di Franca Salerno e Maria Pia Vianale, infatti, non aveva certo contribuito a ristabilire la certezza dell’ordine e della legge. Le due militanti, sfuggite alle condanne di Febbraio, furono però nuovamente catturate il 1 Luglio, a Roma, assieme ad Antonio Lo Muscio, che rimase ucciso durante l’arresto in seguito ad una pallottola sparata a bruciapelo dalla polizia che lo raggiunse alla testa mentre si trovava già a terra.
Il clima di tensione, di “caccia all’uomo” e di violenza gratuita da parte degli agenti che caratterizzò le circostanze del loro arresto (nonché altri episodi) è ben descritto in un’intervista rilasciata da Franca Salerno alcuni anni dopo: “Sì, loro ti cercano, ti pedinano e quando ti catturano ti massacrano di botte. Per quei tempi era normale. Gridavano: “Ammazziamole, facciamole fuori”. Se non ci fosse stata la gente a guardare dalle finestre sarebbe stata un’esecuzione. A Pia hanno sparato perché si era mossa. Ricordo i loro occhi, dentro c’era rabbia e eccitazione; erano fuori di sè perché eravamo donne. Averci prese, per loro, era una vittoria anche dal punto di vista maschile“.
Una vecchia intervista con Franca Salerno
Ciao Anto’
Ciao Franca, cuore nostro
I funerali di Franca Salerno
La copertina con la stella
E’ morta Franca Salerno, storica militante dei Nap (via Insorgenze)
Importante questo articolo, importante i racconti che ci regala, i piccoli pezzi di vita di Franca che ci fa ascoltare.
Le parole di Nicola e poi di Sante, il racconto di quell’urlo a Badu e Carros che diceva che il cucciolo della compagna detenuta nel braccio di fronte di quel maledetto carcere stava male…
insomma, un articolo importante che ci racconta piccoli pezzi di quella piccolissima grande donna che è stata Franca Salerno, militante dei Nap, madre del nostro Antonio.
Ciao Franca
via Insorgenze
Intervista a Paolo Persichetti sul caso Cesare Battisti e sulla politica italiana rispetto agli anni di piombo
via Insorgenze
Mario Libero, Tutti/e Liber@: Presidio a piazzale Clodio
Il 23 dicembre 2010 si è tenuta la prima udienza del processo a Mario e gli altri e le altre compagne arrestati\e durante la rivolta precaria e studentesca di Piazza del Popolo dello scorso 14 dicembre 2010. Il processo è stato rinviato al 24 gennaio per dare la possibilità alla difesa di acquisire ulteriori prove testimoniali , videoregistrazioni e fotografie; al contempo i giudici hanno respinto la libertà provvisoria a Mario, motivando capziosamente la permanenza in Italia – indicando in particolare la giornata di lotta a Palermo e Milano – di un “ clima di tensione sociale”, onde per cui Mario rimane agli arresti intanto fino al 24 gennaio.
I giudici per fortuna hanno però deciso di respingere l’assurda richiesta avanzata da ALEMAGNO per la costituzione di parte civile del Comune di Roma , in quanto a Mario non è addossata nessuna “lesione dell’arredo urbano”.
Ai numerosi compagni/e presenti – studenti, lavoratori, amici degli imputati – l’atteggiamento dei giudici non è apparso né sereno, né
imparziale , costoro sono sembrati partecipi e schierati con il clima fazioso e colpevolista voluto dal governo da subito e all’indomani del 14
dicembre. All’oggi – dopo una settimana di prove documentali e testimoniali ripetutamente apparse in TV , sui quotidiani e periodici – è ormai noto alla cittadinanza che gli arrestati sono stati rastrellati a caso, con il titolo abusivo e generico del reato di “ resistenza in concorso”.
Per il resto , è fallito anche il tentativo di dividere i manifestanti in “ buoni e cattivi” sia per la compattezza del movimento , sia per la
consapevolezza di larga parte della società di riconoscere alla protesta e alla condizione diffusa della precarietà motivazioni valide e concrete, che vanno ascoltate e avviate a soluzione, piuttosto che ignorate e/o represse.
L’accanimento giudiziario non ha ragion d’essere, men che mai l’assunzione sussidiata della politica: il trasformarsi in arbitri del conflitto non compete alla magistratura , tantomeno far pendere l’ago della bilancia dalla parte dei forcaioli, trasformando in capri espiatori gli arrestati del movimento solo per soddisfare i propositi di vendetta di una classe politica inadempiente e corrotte.
Tenere ulteriormente agli arresti domiciliari Mario è un abuso, una iniqua punizione, una pena affligente ancor prima della sentenza: è l’ennesima l’amara constazione di quanto dispotismo alberghi ancora nelle istituzioni, soprattutto tra coloro che dimentichi del dettato
costituzionale e della dichiarazione dei diritti dell’uomo, abusano del codice penale per perseguitare il conflitto e i suoi protagonisti.
Vogliamo Mario libero ! Vogliamo che il Movimento tutto si schieri a sua difesa e non solo le poche decine di compagne e compagni presenti ai precedenti presidi svolti a piazzale Clodio.
Mario è uno di noi, lo rivendichiamo come un nostro compagno e non può e non deve pagare per tutte e tutti: a Piazza del Popolo eravamo in decine di migliaia a difenderci dalla violenza delle Forze del Disordine !
PER L’AUTORGANIZZAZIONE SOCIALE
PER L’AUTOGESTIONE DELLE LOTTE
LUNEDI 24 GENNAIO ORE 9.30
PRESIDIO A PIAZZALE CLODIO
CSOA “MACCHIA ROSSA” MAGLIANA
A questo LINK una corrispondenza di questa mattina dai microfoni di Radio Onda Rossa
Intervista a Ferrara…ecco come il PC convinceva i giurati del primo processo BR
Rivelazioni – Giuliano Ferarra: «Li convincemmo noi. Cossiga, Pecchioli, Berlinguer, Caselli e Violante sapevano»
In questa intervista Giuliano Ferrara, oggi direttore del Foglio ma all’epoca importante dirigente della federazione torinese del Pci, riempie dei tasselli importanti che consentono di ricostruire il sistema della giustizia d’eccezione messa in piedi a parire dalla fine degli anni 70 per combattere l’azione delle formazioni della sinistra rivoluzionaria che conducevano la loro offensiva armata nelle fabbriche e nei quartieri delle periferie urbane. Oltre ad aver incontrato i giurati popolari sorteggiati per comporre la giuria, egli afferma anche di avere fatto delle riunioni politiche, sempre nelle sedi del Pci, con il magistrato Giancarlo Caselli che aveva condotto l’inchiesta contro le Brigate rosse, per concordare una comune strategia antiterrorismo.Una circostanza che trova conferma in una precedente intervista rilasciata da Saverio Vertone sul Corriere della sera dell’11 dicembre 1994: «I rapporti di Caselli con il Pci erano strettissimi, fino a divenire più avanti nel tempo, statuari, organizzativi. Partecipava alle riunioni dei comitati federali. Forse, ma non ne sono certo, prendeva anche la parola alle riunioni di segreteria: discuteva di politica, naturalmente. Però non dimentichiamoci che allora discutere di politica significava affrontare il problema dell’emergenza terrorismo. Caselli era il rappresentante dell’ “intransigenza democratica”, teorizzava la supplenza della magistratura d’inanzi al cedimento degli organismi pubblici. Io e Ferrara concordavamo con lui sulla necessità di mantenere una linea dura»
di Paolo Persichetti
Questa intervista è apparsa in versione ridotta su Il Riformista del 10 novembre 2010 e in versione integrale su Gli Altri del 12 novembre 2010

Dopo due anni costellati da rinvii, il 9 marzo 1978 si apre a Torino il processo al cosiddetto “nucleo storico delle Brigate rosse”. 46 imputati di cui 11 detenuti. Alla prima udienza – racconta Adelaide Aglietta, allora segretaria del partito radicale, nel suo, Diario di una giurata popolare al processo delle Brigate rosse, Milano libri edizioni 1979 – «scopro con mio enorme stupore che un giurato depone una rivoltella: accerterò nei mesi seguenti che anche altri girano costantemente armati». Il quotidiano torinese La Stampa descrive minuziosamente le imponenti misure di sicurezza: 4 mila uomini in assetto di guerra, teste di cuoio, tiratori scelti sui tetti intorno alla caserma Lamarmora trasformata in aula Bunker, novecento uomini addetti alle scorte. Nell’aula – ricorda sempre Aglietta – «la regia è perfetta: due persone su tre sono agenti in borghese camuffati per mimare l’intera scala sociale, dall’imbianchino all’impiegato, al signore borghese con loden e Repubblica sotto il braccio, al giovane finto estremista». Sarà il primo dei maxi-processi contro la lotta armata, dopo una maxi-inchiesta condotta dal giudice istruttore torinese Giancarlo Caselli che aveva accorpato, suscitando polemiche e accuse di forzatura, tre differenti filoni d’indagine svolti in città diverse. Il primo rinvio (maggio 1976) c’era stato perché gli imputati con un gesto a sorpresa avevano revocato i difensori. Ribaltando i ruoli nel processo da accusati si erano proclamati accusatori dello “Stato imperialista delle multinazionali” e innovando la tradizione del “processo rottura” annunciavano l’inizio del processo guerriglia, gettando così nello scompiglio l’intera macchina processuale. Il secondo rinvio è dell’anno successivo, dopo l’uccisione, il 28 aprile 1977, del presidente dell’ordine degli avvocati di Torino Fulvio Croce che aveva assunto la difesa d’ufficio nonostante la volontà contraria degli imputati. Il 3 maggio 1977 solo 4 degli 8 giudici popolari avevano accettato la nomina. Per arrivare a comporre l’intera giuria ci vollero ancora un anno e 40 estrazioni. 210 furono i rifiuti tra gli avvocati per le nomine d’ufficio. Il sorteggio, la fiction sceneggiata da Giovanni Fasanella (a proprosito: quando verranno chiamati dei veri storici a fornire consulenze invece dei soliti imprenditori della dietrologia giornalistica?) andata in onda su Raiuno non racconta però la storia di questi giurati embedded. Per saperne qualcosa di più ho incontrato Giuliano Ferrara, oggi direttore del Foglio ma all’epoca attivissimo responsabile delle fabbriche per la federazione torinese del Pci. In un libro di Maurizio Caprara, Lavoro riservato. I cassetti segreti del Pci, Feltrinelli 1997, aveva rivelato che tra i suoi incarichi di allora c’erano state anche «alcune riunioni con giurati del maxiprocesso contro i brigatisti per convincerli a non rinunciare all’incarico».
 Ferrara, davvero il Pci ti ha dato un incarico del genere?
Ferrara, davvero il Pci ti ha dato un incarico del genere?
Bisogna ricostruire il contesto, il clima che si viveva a Torino. Parliamo di anni in cui ogni settimana c’era un omicidio, una gambizzazione, un incendio in una fabbrica, un arresto, la scoperta di un covo. Insomma una situazione molto drammatica, intensa, spettacolare. Era una sorte di guerra civile dispiegata. Io mi occupavo delle fabbriche, della Fiat, di operai, del sindacato, poi ero nella segreteria della Federazione. La società torinese era intrisa di questo problema. Allora quando ci fu la questione del processo alle Br la città si bloccò, nel senso che tutto il processo si bloccò intorno al fatto che non si trovavano i giurati per la paura. Era una cosa devastante per noi. Voleva dire proprio che c’era una resa e allora ci muovemmo per trovare questi giurati.
Come?
Beh, quando venivamo a sapere che c’era qualcuno scelto ma che non voleva, allora intervenivamo. Nella società operaia ci sono delle relazioni parentali, amicali. Il partito era molto ramificato, era molto presente, ci veniva detto ed io andavo come responsabile dell’antiterrorismo.
La legge dice che i giurati non possono essere influenzati.
Certo che era una forzatura, una cosa totalmente non garantista, da emergenzialismo devastante. Per questo era un lavoro che facevamo segretamente, riservatamente. Però sentivo che avevo una forte giustificazione etica. D’altra parte facemmo anche il questionario antiterrorismo con la domanda numero 5 che invitava alla delazione. Insomma c’era una crisi dello Stato evidente che poi diventò parossistica durante il processo Moro, tra l’altro le date coincidono. Lo Stato era debole e flebile il progetto del compromesso storico. Però non ci fu nessuna germanizzazione, come si diceva all’epoca. Non c’è mai stata alcuna Stammheim. L’unica cosa è stata via Fracchia, l’eccidio della direzione della colonna genovese delle Br.
Ma così difendevate la legalità con l’illegalità?
Noi eravamo una specie di controterrorismo. Un giorno mio padre me lo disse, “ma tu sei un controterrorista”. Contrariamente a quanti consideravano il terrorismo un fenomeno isolato, minoritario, totalmente avulso dalle lotte sociali, che era poi la versione di comodo di una parte del Pci, ritenevo già allora il terrorismo una cosa molto seria. Un partito armato con un progetto socialmente sostenuto da ragioni forti, da movimenti di massa, da situazioni nuove nella fabbrica, da una dottrina. La fabbrica non era più solo un luogo dello sfruttamento, che è un rapporto matematico, era il luogo dell’oppressione. La volontà di impedire quel processo di oppressione ha creato Il fenomeno del terrorismo politico di matrice marxista in tutta Europa, Raf e Brigate rosse. Se tu riconosci questo allora capisci le ragioni di quell’atto. Se fossero stati soltanto delle pattuglie scollegate dalla società non ce ne sarebbe stato bisogno.
Ma se la lotta armata nasceva dall’oppressione non sarebbe stata più opportuna una risposta politica? Le vostre scelte sembrano confermare invece quanto dicevano i prigionieri delle Br: “il processo messo in scena non è giustizia ma un atto di guerra”.
Sì, ma lo Stato di diritto doveva essere salvato. Io sono marxista, dietro l’involucro formale dello Stato di diritto c’è la sostanza, cioè la forza.
Più che Marx mi sembra il discorso di Carl Schmitt.
Ovviamente non nego il formalismo giuridico di cui c’è bisogno, dico che è un involucro, poi dentro c’è un contenuto, una sostanza, i rapporti sociali.
Caselli nel rinvio a giudizio aveva definito le Br una nuova forma di criminalità sprovvista di contenuti politici.
Questa idea del terrorismo come di una pattuglia di persone separate dal contesto sociale italiano è sbagliatissima. Sei mesi prima di via Fracchia, quelli che dormivano lì e che erano nella direzione strategica delle Br, erano avanguardie operaie di fabbrica. Il terrorismo non era criminalità organizzata. Era azione politica che andava al cuore dello Stato, quindi se ti identificavi, se ti immedesimavi con lo Stato, a differenza di Sciascia che se la passava bene dicendo che non stava né con gli uni né con gli altri, non potevi agire altrimenti. Noi ci identificavamo e facevamo quello che consideravamo il nostro dovere. Certo ci voleva anche una certa dose di fanatismo allora per fare cose di questo genere.
Ma le Br non hanno mai fatto minacce dirette ai giurati popolari. Lo testimonia Adelaide Aglietta e le inchieste successive non hanno mai fornito una sola prova che ci fosse stata anche solo l’idea di colpire un giurato.
La percezione era che chi combatteva una battaglia legale contro le Brigate rosse rischiava. Era evidente che c’era un conflitto condotto con argomentazioni molto suggestive, perché le Br dicevano: “mica spariamo a voi, noi spariamo alla vostra funzione”. Quindi alla funzione del secondino, alla funzione dell’avvocato Croce, a tutte le tutele corporative, al capo reparto. Chiunque dovesse svolgere un certo ruolo era minacciato, a prescindere da minacce effettive.
 Dove avvenivano questi incontri?
Dove avvenivano questi incontri?
Nelle sedi del partito. Mi ricordo una riunione a Lingotto. Adesso sembra chissà che cosa, ma tutto era fatto con una certa eleganza, mica dicevamo “dovete entrare a far parte della giuria e dargli l’ergastolo”. Facevamo un’opera di persuasione. Una specie di antidoto contro la paura. Spiegavamo che partecipare ad una giuria è un dovere civico, che se non si arrivava a costituire questa giuria la città e un pezzo importante dell’Italia sarebbero cadute in uno stato di ripiegamento di fronte ad una offensiva violenta che semina lutti, che crea problemi. Davamo il nostro suggerimento e poi naturalmente offrivamo una mano, al di là della mano che dava lo Stato. Lo Stato offriva una sua protezione, noi potevamo aggiungere anche la nostra.
Che tipo di protezione?
Per esempio case. Chiedevamo: “Dicci quali sono i tuoi problemi, se hai paura. Sappi che noi ci siamo”.
Fornivate anche armi?
No, non mi risulta. Può essere che questo consiglio sia venuto dalle forze di polizia. Il ministero dell’Interno suggeriva spesso di armarsi. Lo disse anche a me ed io comprai una rivoltella, presi il porto d’armi.
Tra le persone incontrate c’è stato qualcuno che alla fine ha detto no?
Sì, moltissime persone. Anzi ricordo più sconfitte che risultati.
Si trattava di una iniziativa autonoma della federazione di Torino oppure c’era stata una indicazione dalla sezione problemi dello Stato diretta da Pecchioli?
Certo la direzione era informata. Ma era una iniziativa nostra. In quel clima non c’era niente di più ovvio che fare questo.
Il rapporto con Pecchioli come era?
Pecchioli era torinese, era stato partigiano, era legatissimo a tutte le forze reali del partito. Veniva spesso, si fermava. In federazione c’era ancora la generazione della Resistenza divisa in due: quelli che tifavano per i terroristi, che pure c’erano, non dico quelli come Lazagna, ma quelli che dicevano “lasciateli fare i giovani, è inutile fare appelli accorati, hanno ragione loro”. Quando cacciarono Lama dall’università erano tutti contenti, alla camera del lavoro e alla Fiom. E poi c’era l’altra generazione resistenziale, quella più dottrinale, quella più ortodossa, che invece diceva “No, questi sono un pericolo”, gli amendoliani, insomma quelli più legati ad una tradizionale posizione d’apparato.
 E le istituzioni? Il presidente della corte d’Assise Barbaro era al corrente di questa vostra attività?
E le istituzioni? Il presidente della corte d’Assise Barbaro era al corrente di questa vostra attività?
Non te lo so dire.
Giancarlo Caselli?
Penso che lo sapesse. Caselli e Violante facevano le riunioni con noi.
Il ministro degli Interni Francesco Cossiga era informato?
Sì, Cossiga era in stretto rapporto con Pecchioli, dunque sapeva. Almeno sette-otto persone, da Berlinguer in giù, avevano sicuramente notizia che il Pci a Torino si era attivato per cercare di comporre questa giuria.
Oggi, a distanza di oltre trent’anni, dopo tutto quello che è successo, rifaresti la stessa cosa?
E’ passato tanto tempo, ho un’altra età, ho appreso un sacco di lezioni. La storia ha replicato quindi non voglio fare il gradasso dicendo che rifarei tutto. Spero però che ci sia sempre un giovane, come me allora, capace di rifare la stessa cosa
Ergastoli, condizionali e perdoni: è il turno di Gallinari!
Posto un’articolo uscito oggi sulla Gazzetta di Reggio. Ancora una volta parliamo di richiesta di libertà condizionale dopo i 26 anni di carcere scontati : questa volta l’istanza di cui si parla è quella presentata da Prospero Gallinari, ergastolano ex appartenente alle Brigare Rosse.
L’intervistatore chiede proprio a lui cosa ne pensa del perdono e delle strumentali richieste dei tribunali di sorveglianza
«Chiedere perdono? Sarei ipocrita».
L’ex Br Gallinari vuole la libertà condizionale: «E’ un mio diritto» di Tiziano Soresina
Prospero Gallinari, l’ex brigatista carceriere di Aldo Moro, ha chiesto la liberazione condizionale. Ha sulle spalle diversi ergastoli, ma ha già scontato i 26 anni di reclusione necessari per l’istanza. La legge richiede il «sicuro ravvedimento», ma il Tribunale di sorveglianza di Bologna avrebbe chiesto ai familiari delle vittime delle Br se sono disposti a perdonare. Partiamo dalla clausola di legge… 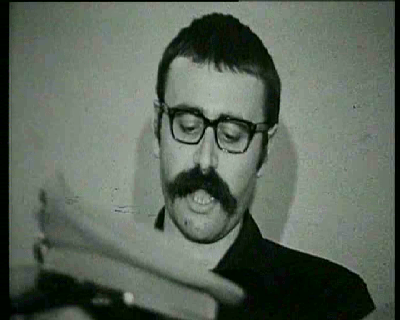
«Il mio ravvedimento? Sono 22 anni – spiega con calma Gallinari – che la storia delle Br è chiusa, cioè quando in otto brigatisti firmammo il documento in cui si sottolineava che la lotta armata contro lo Stato era finita. Le cose fatte per esprimere un processo rivoluzionario si erano concluse. Mi sono assunto la totale responsabilità di quegli eventi e all’interno di questa assunzione di responsabilità è iniziato il mio nuovo cammino».
Di cos’è composto il suo percorso rieducativo?
«Vivo con la mia compagna, ho una famiglia, lavoro da 13 anni in una tipografia in cui ho tanti amici e sono rispettato da tutti, mi sono reinserito socialmente».
Ma lei la scriverebbe una lettera ai familiari delle sue vittime chiedendo loro perdono?
«Sono sincero, la riterrei un’offesa per i familiari stessi andare a porre questo problema umano. La sofferenza dei familiari non nasce con la mia dissociazione, ma quando le cose sono avvenute. Una lettera di quel tipo la riterrei una grande ipocrisia. Che cosa dovrei scrivere? Che soffro per quelle cose? E’ un problema intimo. Sul piano etico il nodo lo sciolsi nel momento in cui decisi di lottare anche con le armi per la rivoluzione. Se fai queste scelte, la politica sta al centro di tutto. L’aspetto politico e quello umano vanno separati».
Ma altri suoi ex compagni di lotta armata hanno compiuto questo passo…
«E’ vero, hanno fatto questa mossa per uscire da determinate situazioni processuali, ma non è il mio modo di muovermi. Lo riterrei offensivo verso le famiglie, una cosa falsa, una recita».
Si è mai trovato a tu per tu con chi ha tanto sofferto per la scia di sangue lasciata dalle Br?
«Solo una volta, alla presentazione del mio primo libro. Contestò il mio ruolo, una discussione in chiave politica, dai toni normali».
La figlia di Rossa e la moglie di D’Antona hanno detto chiaramente che i magistrati devono assumersi le proprie responsabilità, perché non è compito dei familiari delle vittime decidere sulla liberazione dei brigatisti…
«Sono al corrente, ho apprezzato quelle parole».
Perché si è deciso a chiedere la liberazione condizionale?
«E’ un mio diritto. Così potrei muovermi con più libertà e non solo nelle tre ore pomeridiane previste dall’attuale detenzione domiciliare. Sarebbe importante per i miei problemi di salute (conseguenza di crisi cardiache, ndr) potermi allontanare da Reggio e svernare per un periodo in un luogo più adatto».
S’aspettava tanto clamore, le polemiche che tornano a fioccare sugli ex brigatisti?
«Sapevo che la notizia della mia richiesta di liberazione condizionale sarebbe prima o poi uscita. Ammetto lo stress che sto patendo per le polemiche innescatesi».
Le “donne” dei prigionieri e la storia rimossa, la nostra storia
AGGIORNAMENTO 18 GIUGNO 2013: LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA DICHIARA AMMISSIBILE LA RICHIESTA DI REVISIONE DEL PROCESSO TRIACA.
IL 15 OTTOBRE 2013 LE TORTURA ANDRANNO ALLA SBARRA E LA VERITA’ VERRA’ RISTABILITA.
LEGGI QUI LE NOVITA’, OTTIME: LEGGI
Quest’articolo lo lessi che ero poco più di una bambina, a tredici anni, riportato tra le note di un libro che cambiò la mia vita (regalatomi da una mano completamente inconsapevole):
“Dall’altra parte” – l’odissea quotidiana delle donne dei detenuti politici- di Prospero Gallinari e Linda Santilli.
Un articolo, un “reportage”, una testimonianza scossa di una giornata passata con le “donne dei detenuti” br e non, reclusi nel carcere speciale di Trani dopo appena un mese dalla rivolta. Le compagne di uomini fatti a pezzettini dai GIS, uomini con dita denti schiene e costole spezzate: detenuti politici che avevano messo a ferro e fuoco un carcere e che ora scontavano sulla loro pelle e quella dei loro cari la repressione dello stato.
Uno stato che doveva dimostrare la sua forza: uno stato che aveva mandato i GIS a sedare la rivolta …e c’era riuscito, ovvio!, peccato che al rientro dell’operazione – nei festeggiamenti per il capodanno- il generale che aveva guidato il masssacro è stato ucciso sul pianerottolo di casa.
Quest’articolo racconta il mai raccontato, quello vissuto da chi ha avuto la vita sventrata dal carcere, dalle leggi speciali, dall’ergastolo solo perchè madre, figlio, amore di un compagno prigioniero.
La tradotta di Trani ferma a Barletta. Per Trani si cambia.
Sul marciapiede, alle sette di mattina si riversano i familiari. Perlopiù sono donne, madri, compagne, sorelle. Nei venti minuti d’attesa prima che arrivi il Roma-Bari che bisognerà prendere al volo, di corsa dal giornalaio a raccattare quotidiani, di corsa al gabinetto, di corsa al bar a buttar giù un caffè; poi dieci minuti ancora , questa volta in piedi contro gli sportelli del treno, e giù di nuovo su un altro marciapiede, quello della stazione di Trani.
Qui il femminismo non avrebbe ragione d’esistere.
Le donne dei prigionieri sono forti, gestiscono le loro azioni con autorevolezza, a tratti perfino con allegria. Di fronte al procuratore capo De Marinis, ogni sabato, da quando c’è stata la rivolta, la dignità la chiarezza la determinazione sono loro […].
 Il primo sabato: le visite e i pacchi sono sospesi. Il secondo, ancora niente visite e niente pacchi. Le donne si organizzano, attuano il blocco dei cancelli, aspettano dieci ore, circondate dai carabinieri minacciosi, e commettono un peccato d’onestà: credono all’ufficiale che promette un colloquio con il direttore se il blocco viene tolto. Naturalmente l’ufficiale non rispetta la parola. Però i pacchi passano.
Il primo sabato: le visite e i pacchi sono sospesi. Il secondo, ancora niente visite e niente pacchi. Le donne si organizzano, attuano il blocco dei cancelli, aspettano dieci ore, circondate dai carabinieri minacciosi, e commettono un peccato d’onestà: credono all’ufficiale che promette un colloquio con il direttore se il blocco viene tolto. Naturalmente l’ufficiale non rispetta la parola. Però i pacchi passano.
Il terzo sabato, ancora visite distanziate, ancora il ritrovarsi davanti al secondo cancello. Per ogni nome chiamato passa un’ora. I colloqui dovranno essere con i vetri. NO, prigionieri e donne dicono no. […]
Si decide di nuovo il blocco dei cancelli. […]
Da tutte le parti piovono autoblindo, e carabinieri, a nugoli come le mosche. Arriva anche un funzionario in borghese, forse Digos. Dice che le manifestazioni sono proibite, dice che bisogna sgombrare se no ci pensa lui, e infatti ci pensa.
I carabinieri si schierano a pochi passi dalle donne, faccia a faccia. Rigidi e neri che sembrano lì come per un film. Comparse che non conoscono tutta la trama, ma solo il povero ruolo che le riguarda. E caricano duro.
Piovono le botte e gli spintoni, ma il funzionario capisce che la loro è solo forza fisica.[…]
Le notizie che filtrano dall’interno sono come sassi in faccia e perdono ordine e priorità, trasformandosi in una sorta di onda d’urto che spinge le donne ad agire. Guardie incappucciate, da Ku Klux Klan, chiamano per nome i detenuti, e a mano a mano che uno viene crocifisso dalla luce dei fari, giù botte. Quindici prigionieri vengono trascinati sul tetto: le guardie che li tengono chiedono alle altre, in basso, se ci sono morti o feriti tra i loro colleghi. Sono pronte, a una risposta affermativa, a buttar giù i detenuti.
Il policlinico di Bari si lascia portari via dai carabinieri i feriti gravi. Ma questo è avvenuto subito dopo la rivolta. Le donne si sono già battute per organizzare una fitta rete di controinformazione, ma tranne le trasmissioni di poche radio libere e qualche stralcio di notizia censurata dagli stessi giornalisti che la passano, all’opinione pubblica non arriva niente.
Altre notizie, sassi in faccia. I prigionieri sono ammassati in cameroni e come unica forma di protesta possibile attuano la “guerra batteriologica”, buttano escrementi e immondizie nei corridoi e dalle finestre. I feriti curati alla bell’e meglio subito dopo la rivolta peggiorano. I punti vanno in suppurazione, alcuni hanno la febbre alta e non si reggono in piedi, altri hanno le ossa rotte, le mani le caviglie, le costole.
Falco il medico della prigione, che nome meglio di così non poteva avere, non si fa vivo. Neanche il Giudice di sorveglianza. […]
Quando vengono concessi i colloqui, le donne e i prigionieri li rifiutano: si vorrebbe ancora farli parlare attraverso vetri e citofoni. Vengono pestati e trascinati all’isolamento, ma non si illudano i carcerieri che questo possa spingere i detenuti o i loro familiari alla rinuncia della propria dignità umana. Le donne stendono una denuncia. La firmano nominalmente, la portano alla procura, la presentano come legge vuole, anche se si immaginano che finirà in un cassetto. Trasmettono altri comunicati attraverso l’Ansa, ma anche su questi cala la nebbia.
Notte e nebbia. Nacht und Nebel sulle carceri speciali.
Notte e nebbia sulle coscienze. Nel paese delle interrogazioni parlamentari non si alza una sola voce, fosse anche semplicemente per chiedere. Ma di quello che accade o che potrebbe accadere nei lager di questa repubblica qualcuno dovrà pur rispondere.
Laura Grimaldi
Il Manifesto
29 Gennaio 1981
[A mamma Clara, a suo figlio Bruno]
I LINK SULLA TORTURA
breve cronologia ragionata e testimonianza di Ennio di Rocco, B.R.
Testimonianze di Emanuela Frascella e Paola Maturi, B.R.
Testimonianza Di Sisinnio Bitti, P.A.C.
Arresto del giornalista Buffa
Testimonianza di Adriano Roccazzella, P.L.
Le donne dei prigionieri, una storia rimossa
Il pene della Repubblica
Ma chi è il professor “De Tormentis”?
Atto I: le torture del 1978 al tipografo delle BR
De Tormentis: il suo nome è ormai il segreto di Pulcinella
Enrico Triaca, il tipografo, scrive al suo torturatore
Le torture su Alberto Buonoconto
La sentenza esistente
Le torture su Sandro Padula
Intervista a Pier Vittorio Buffa
Enrico Triaca: così mi ha torturato De Tormentis
“Costituzione” e “democrazia” non sono valori che m’appartengono
La Costituzione??
La Democrazia??
 Ma perchè? Perchè siamo diventati così?
Ma perchè? Perchè siamo diventati così?
Sarà dura per me stare in piazza questo 25 aprile: volevo portare il mio bambino al suo primo corteo di LIBERAZIONE ma non credo riuscirò a farlo.
Sono comunista, sono antifascista…ma quest’ antifascismo non mi piace, quest’antifascismo non m’appartiene.
Non riesco a vedere “compagni miei”, SANGUE MIO, invocare democrazia e Costituzione…
Non potete chiedermi di difendere la Costituzione…non la potete trattare come una cosa intoccabile, detentrice di valori eterni ed inviolabili.
Ma di cosa stiamo parlando?
Ma da quando amiamo la nostra Costituzione? La democrazia? Una costituzione che parla di “famiglia”, di “proprietà privata”?
La stessa democrazia che tiene i compagni in carcere da trent’anni, la stessa democrazia che ha regalato ergastoli e leggi speciali,
la stessa democrazia che sgombera le case, che carica i lavoratori e l’ha sempre fatto.
Quanti proletari sono stati ammazzati dalla nostra Costituzione???
Ieri ad Ostia c’è stata l’ennesima aggressione di Casa Pound: c’era un compagno solo ad attacchinare che s’è salvato per un pelo:
Volevo mettere il comunicato e non ne sono stata capace: si invocano le “forze sinceramente democratiche”… sul mio blog, scusate, non riesco a mettervi!
Non riesco a condividere strade e piazze nemmeno più con la retorica partigiana di personaggi come Bentivegna che poi hanno avallato ergastoli a go-go.
Basta, invece di capire questo, di superare quella retorica in modo antagonista e rivoluzionario facciamo addirittura passi indietro,
la peggioriamo, la rendiamo ancora più “democratica e populista”. Non ne posso più!
Vorrei contenuti di altro genere, vorrei parole nostre…non vorrei appellarmi solo al lessico borghese, alle Costituzioni borghesi e ai loro tribunali.
Questo 25 aprile mi sento molto sola, e non per i tanti fascisti in giro, ma per il modo in cui tentiamo di combatterli!
Intervista a Sonja Suder e Christian Gauger, a rischio estradizione!
Dal blog DamnatioMemoriae non posso non prendere (GRAZIE!!!) la traduzione di quest’intervista pubblicata sull’edizione domenicale della Tageszeitung (TAZ, quotidiano berlinese di sinistra) del 21.3.2010, agli esuli tedeschi in Francia Sonja e Christian, di cui ho già parlato in questo blog.[Archivio]
Revolutionäre Zellen
Sfuggiti per 22 anni ai cacciatori di terroristi. Sonja Suder e Christian Gauger sulla vita in clandestinità e su ciò che si prova quando si viene scoperti
“Guardi sempre se c’è qualcuno dietro di te”
di Andreas Fanizadeh
taz: Signora Suder, signor Gauger, quando vi siete accorti per la prima volta di essere osservati?
Sonja Suder: Era l’estate 1978. Eravamo appena tornati a Francoforte da una gita nel sud della Francia. Alle 6 di mattina ci siamo mossi per montare il nostro stand al mercato delle pulci all’Eisernen Steg sul Mainufer.
E li avete notato che qualcuno vi seguiva?
Suder: Alle sei di mattina è evidente se qualcuno ti sta dietro dalla porta di casa fino al mercato, dove poi non monta un suo stand. Al pomeriggio l’abbiamo comprovato ed era chiaro: eravamo osservati. Era un clado giorno d’estate a Francoforte, credo in agosto. E dovemmo prendere una decisione.
Perché?
Eh, erano tempi duri, era l’anno dopo il sequestro Schleyer e i morti di Stammheim. Decidemmo di andarcene via.
1978.
Chi si ricorda del 1978, l’anno in cui Sonja Suder e Christian Gauger scomparvero dalla scena, per restare introvabili nei successivi 22 anni? L’anno in cui l’Argentina visse i mondiali di calcio. O in cui nacque Katja Kipping, oggi vice capo del Partito Die Linke (La Sinistra). C’era ancora la RDT (Germania dell’Est) e l’Europa occidentale era nella fase finale del movimento del ’68. In Nicaragua i Sandinisti attaccarono il Palazzo Nazionale, in Italia le Brigate Rosse uccisero il democristiano Aldo Moro.
Quando l’esplosivo scoppiò all’improvviso E nella Repubblica Federale Tedesca, nel giugno del 1978, un conoscente -secondo la Procura penale- di Sonja Suder e Christian Gauger si preparò a piazzare una bomba al Consolato argentino di Monaco. Si chiamava Herrmann Feiling ed avrebbe agito, come Sonja Suder e Christian Gauger, nell’ambito delle cosiddette Cellule Rivoluzionarie (RZ). Le RZ erano per gli apparati di difesa dello Stato difficili da valutare, poiché dalla loro spaccatura del 1976/77 agivano senza una direzione riconoscibile. Il gruppo propagava attacchi con danni materiali e tentava, diversamente dalla RAF, di non fare vittime. Suder e Gauger avrebbero partecipato, dice oggi la Procura, a due attacchi contro imprese che lucravano sull’uranio con il Sudafrica, nel 1977, e ad un incendio al castello di Heidelberg, nel 1978. Perciò il 15 settembre 1978 un giudice istruttore federale emise un mandato d’arresto contro i due.Se Gauger, Suder e Feiling si conoscevano veramente, come ritiene la Procura, potevano senz’altro, nel 1978, considerare l’Argentina come uno Stato di non-diritto. Là i militari avevano fatto nel 1976 un colpo di stato con un seguito di 30’000 omicidi. In quel paese e in condizioni scandalose si giocarono i campionati mondiali di calcio. E la coalizione social-liberale di Bonn tollerava gli affari delle imprese tedesche con la dittatura argentina, mentre aiutava solo con molte esitazioni i cittadini germanici incarcerati e torturati in Argentina. V’erano insomma serie inconvenienti , anche se solo pochi come Herman Feiling tentarono di bucare con una bomba il muro del Consolato argentino. Ma l’attentato al Consolato non ebbe luogo. Per Hermann Feiling, il presunto conoscente di Suder e Gauger, la preparazione ebbe un esito fatale. L’esplosivo scoppiò il 23 giugno prima del previsto ad Heidelberg, e Feiling perse entrambe le gambe e gli occhi.
Il ferito grave venne palesemente interrogato dagli inquirenti già nella clinica universitaria di Heidelberg. Per settimane e mesi, dicono amici ed avvocati, gli inquirenti isolarono Feiling, per cercare di ottenere informazioni sulla struttura organizzative delle Cellule Rivoluzionarie. Gli inquirenti verbalizzarono ciò che Feiling avrebbe detto loro sotto l’effetto dei medicamenti e senza l’assistenza di un legale liberamente scelto, cose che poi egli ritrattò.
Poche settimane dopo l’incidente di Feiling, Suder e Gauger notarono la squadra di osservazione a Francoforte e si eclissarono. Da allora avrebbero vissuto da qualche parte all’estero senza più essere attivi -come lo erano in precedenza- in rapporto alle RZ.
Il sospetto contro Suder e Gauger “si appoggia in sostanza sulle dichiarazioni del testimone Feling nel 1978” conferma oggi, su richiesta, la Procura di Francoforte. Solo nel 1999 si aggiunse secondo le autorità un ulteriore sospetto contro Sonja Suder. Accusa: partecipazione all’attacco contro l’OPEP a Vienna nel 1975 e complicità in omicidio. I termini di prescrizione per gli attentati originariamente imputati a Suder e Gauger è di 20 anni. Sarebbero quindi prescritti dal 1998. Ma, sostiene la Procura pubblica, la prescrizione è stata “interrotta più volte” e può andare “al massimo fino al doppio del tempo previsto, dunque a 40 anni”. Un attacco incendiario del 1978 (prescrizione: 10 anni) può essere trasformato in un attacco incendiario con messa in pericolo della vita altrui (prescrizione: 20 anni) e così allungare la prescrizione a 40 anni.
È del 2000 la spettacolare scoperta con immediato arresto dei due “pensionati delle RZ”, come vennero definiti, a Parigi. Da allora le autorità francesi e tedesche si affannano su Suder e Gauger. Nel 2001 la Francia respinse una domanda di estradizione della Germania. Ora la pagina potrebbe voltarsi, grazie al nuovo mandato di cattura europeo, contro i due militanti della sinistra degli anni settanta. Il caso pende al momento presso la Corte costituzionale francese. Si ignora se la Francia estraderà.
2010.
Parigi, Saint Denis, vicino all’Università 8. Su piccolissimi appezzamenti di terreno sorgono piccole case, in lontananza si scorgono i profili di alcuni grattacieli. Non c’è nessuno per strada, è una giornata fredda e umida. In una delle casine, o meglio in una parte minuscola di una di quelle casine, vivono da quando vennero scoperti ed arrestati Sonja Suder e Christian Gauger. Sonja Suder ha compiuto nel frattempo 77 anni, Christian Gauger ne ha 68. Erano una coppia già prima della fuga nel 1978. È la prima volta che parlano con la stampa tedesca. Il colloquio è accompagnato da thé e torte. La loro cucina non arriva a 16 metri quadrati.
In clandestinità poco prima della laurea
Com’è, essere trovati e presi decine di anni dopo aver attaccato delle imprese tedesche per i loro affari con il Sudafrica dell’apartheid, dopo essere scomparsi ed aver vissuto una vita clandestina in Francia? Suder e Gauger sorridono. Su quei temi non parlano. Entrambi vogliono parlare con la TAZ a condizione di non dover rispondere a domande che possano avere un rilievo giuridico nel loro processo. Non dicono se, e se sì, per cosa, portano responsabilità.
 taz: Da quando vive in esilio?
taz: Da quando vive in esilio?
Sonja Suder: Dal 1978.
Prima viveva a Francoforte?
Suder: Si, studiavo medicina. Quando siamo partiti, avevo quasi finito.
Quanti anni aveva, allora?
Suder: Dovevo averne 45.
E lei, signor Gauger?
Christian Gauger: Anch’io vivevo a Francoforte. Avevo un diploma in psicologia e lavoravo con la pedagogia speciale all’Università.
Come collaboratore scientifico?
Gauger: No, come ‘servitore’ scientifico. Così si chiamava allora.
Gauger squadra il giornalista. Beve un po’ dalla sua tazza -thé d’erbe come quello di Suder- ed è calmo e concentrato. I suoi capelli bianchi li ha raccolti in una treccia, il viso è incorniciato da una barba sale e pepe tagliata corta. Con la sua camicia a fiori ed il leggero dialetto della regione dell’Hess potrebbe essere uscito direttamente da un negozio di antiquariato del quartiere Bockenheim a Francoforte. Sonja Suder dirige il dialogo. I suoi 77 anni non si notano. Una personalità agile, vivace e spontanea, con una voce decisa, è vestita sportivamente in nero, con capelli corti e scuri.
La camera a Saint Denis è arredata con mobili usati, comoda e pratica, come se ne vedono nelle comuni della scena alternativa. L’anticonsumismo sembra un’ideologia pratica per la vita spartana della clandestinità, senza pensione né entrate stabili. Tra i libri sugli scaffali si notano molti reggiposate. I reggiposate vengono volentieri usati in Francia per appoggiarvi le posate tra una portata e l’altra, per non sporcare il tavolo. Sono di porcellana, di diversi metalli nobili, rifiniti in modo semplice o artistico. Ogni uomo ha un hobby, e collezionare reggiposate è quello di Christian Gauger. Lui racconta lentamente, è quasi floscio. Nel 1997 ha subito un infarto ed ha dovuto essere riportato in vita.
Taz: Com’era la situazione, quando veniste arrestati nel 2000?
Suder: Eravamo arrivati da poco a Parigi e siamo usciti dall’albergo. Andò tutto molto in fretta: mani in alto! Poi volto e braccia contro il muro.
Polizia francese?
Suder: Sì, polizia francese.
Nessun tedesco assieme a loro?
Suder: No, solo più tardi, al distretto degli sbirri, lì c’erano anche dei tedeschi. Non si sono lasciati vedere, ma potevi sentire come parlavano tra di loro.
È importante per voi che si parli di ‘sbirri’?
Suder [ride]: No, possiamo anche dire polizia.
Ve l’aspettavate, di essere presi nel 2000?
Suder: No. Non in quel particolare momento, anche se rispetto alla tua vita sai che potrebbe accadere in qualsiasi momento. Non si sa mai cosa stia effettivamente succedendo. In questo senso essenzialmente te lo aspetti.
Insomma non avevate nessun concreto indizio?
Suder: No. E questo benché ci stessero sicuramente già addosso da un pezzo.
Sapete come vi hanno ritrovati dopo 22 anni?
Suder: Non è chiaro. Avevamo avuto in incontro con un parente. Forse gli si sono appiccicati.
Intende dire che per tutto l’anno un commando di catturatori vi è stato addosso?
Suder: Non credo. Fino alle dichiarazioni di Hans-Joachim Klein nel 1998/99 non eravamo neppure sempre indicati nelle ricerche per la cattura in Europa. La cosa deve essere cambiata dopo.
Hans-Joachim Klein partecipò nel 1975 all’attacco contro l’OPEP a Vienna. Si allontanò in seguito dal terrorismo ma venne preso solo nel 1998 in Francia. Dopo il suo arresto sostenne per la prima volta nel 1999 che Sonja Suder aveva potuto partecipare alla logistica dell’attacco all’OPEP. Fino al 1999 non c’era un ordine di arresto internazionale?
Suder: No, secondo i nostri avvocati. È probabilmente per questo che prima abbiamo avuto abbastanza tranquillità.
Signor Gauger, si trattiene? Non vorrebbe partecipare alla nostra conversazione?
Gauger: Di molte cose non ho più ricordi. Ho avuto un infarto e sono entrato in coma.
Quando è successo?
Suder: 1997.
Gauger: Il cuore mi si fermò. Ero praticamente morto. Sonja mi ha riportato in vita. [Arresto cardiaco e infarto, con i conseguenti pregiudizi sul cervello e sulla capacità di memoria sono attestati da perizie mediche francesi].
Le vostre false identità erano così ben fatte che potevate chiedere delle cure mediche?
Suder: Dovevamo! Già solo per il controllo e le medicine. La riabilitazione l’ho poi fatta io con lui. Era davvero una situazione assurda.
E non vi hanno scoperti?
Suder: No. A volte abbiamo dovuto trattenere il respiro, ma la nostra età fa sì che la gente non sia tanto malfidata.
Gauger: Io avevo integralmente perduto la memoria.
Ma Sonja Suder l’ha riconosciuta?
Suder: Fatto che mi stupì, devo dire.
Gauger: Ma prima non sapevo neppure che esistesse, l’ho conosciuta solo quando è ritornata nella camera.
Che sentimento si prova, quando ci si è dimenticati tutto, si vive in clandestinità e ci si deve fidare di una persona che ci insegna chi si è?
Gauger: Prima o poi viene la paura: cazzo, che succede se rimango stupido? Quando mi è venuto questo timore era però anche il momento in cui ho notato che potevo pensare da solo. La cosa è durata per un po’.
Sonja Suder le ha anche dovuto raccontare perché viveva in clandestinità?
Gauger: Sì. Ma naturalmente non so se mi ha raccontato tutto. Semplicemente non lo so.
Suder: Questo neppure si può. Non puoi raccontare un’intera vita. Se qualcuno lo chiede e se si lavora con certi testi di riabilitazione, si può ri-raccontare qualcosa, ma non si può sovraccaricare una cervello. La cosa funziona pezzetto per pezzetto.
1997 e 2000 – tra arresto cardiaco e incarcerazione non passò molto tempo.
Suder: Sì, ma si era già stabilizzato. Il punto di cui prima parlava fu dopo un mezzo anno di riabilitazione. Ma ancora oggi Christian mi chiede cose sul suo passato, ed in pratica continuiamo ancora la riabilitazione.
Dopo l’incarcerazione siete stati immediatamente separati?
Suder: Sì, subito.
Avete ancora famiglia in Germania?
Suder: Sì, abbiamo contatto con le nostre rispettive sorelle.
Signor Gauger, allora adesso può verificare autonomamente se ciò che le ha raccontato la signora Suder è vero?
Gauger: Sì, questo è almeno divenuto più facile.
Che atteggiamento avete avuto nei confronti dell’interrogatorio dopo l’arresto?
Suder: Se prima hai concordato “se succede qualcosa, nessuna parola, niente dichiarazioni”, hai allora un buon sentimento di sicurezza.
 Quanto siete rimasti in carcere preventivo nella prima procedura del 2000/2001?
Quanto siete rimasti in carcere preventivo nella prima procedura del 2000/2001?
Suder: Meno di tre mesi. Christian era detenuto a Parigi, il carcere femminile era fuori.
È stata la vostra prima volta in carcere?
Suder: Sì, io ero alla fine dei miei 60 anni, Christian all’inizio dei suoi.
Com’era in carcere?
Suder: Si dice che le prigioni francesi siano le peggiori del mondo. Io però non posso affermarlo. Sono stata messa in cella e avevo la normale ora d’aria nel cortile. Ho incontrato subito due donne basche. Da quel momento mi è stato organizzato tutto ciò di cui avevo bisogno, in modo naturale e ovviamente sottobanco. Insomma ero quasi un po’ privilegiata. Quella solidarietà era affascinante.
Qual’era la cosa più noiosa in carcere?
Suder: Di fatto, il baccano. Ad ogni passaggio ci sono porte d’acciaio, che vengono in permanenza aperte e sbattute rumorosamente. Sono dei botti continui. Un baccano incredibile. L’essere rinchiusa non era per me così brutto, per quello ti prepari un po’ prima. Devi subito vedere di fare qualcosa, come esercizi sportivi e letture.
Signor Gauger, come fu per lei?
Gauger: Al passeggio, è venuto subito uno da me. Sapeva già. Così poi sono stato sempre con lui e con un altro al passeggio. In cella eravamo in tre. I letti a castello erano scomodi; sul terzo, sopra, si è ben in alto, ti possono venire le vertigini. Altrimenti: topi e scarafaggi, che sono però animali domestici. Meglio che una cella singola tutta bianca, dove non vedi né senti nessuno.
Che si pensa, quando si è arrestati dopo 20 anni di esilio?
Suder: Adesso ci hanno proprio beccati.
Gauger: E io ho pensato: questo non è necessario.
Sapete ciò che concretamente vi viene rimproverato?
Suder: Tre attentati, due contro il programma atomico dell’allora regime dell’apartheid sudafricano, ed un attacco contro la ristrutturazione della città di Heidelberg. A me, inoltre, Vienna. Questa storia dell’OPEP. E con essa l’accusa: complicità in omicidio. In Francia questo sarebbe già prescritto. Le sole cose che qui non vanno in prescrizione sono i crimini contro l’Umanità.
L’accusa di partecipazione all’attacco contro l’OPEP l’ha sorpresa?
Suder: Sì.
1975. L’arresto di Klein nel 1998 fu un fulmine a ciel sereno, proprio come la sua affermazione della partecipazione di Suder. Klein aveva fatto parte nel 1975 di un commando diretto da Ilich Ramirez Sanchez, detto ‘Carlos’, e che si rese responsabile della morte di tre persone. A Klein, ferito durante l’azione, riuscì di partire con gli altri membri del commando e con i ministri dell’OPEP in ostaggio. Poi nel 1976 un commando tedesco-palestinese dirottò un aereo dell’Air France su Entebbe; in quell’occasione morirono Wilfried Böse e Brigitte Kühlmann, considerati dirigenti delle prime RZ. In seguito le RZ si rifondarono, distanziandosi da gruppi e formazioni del vicino oriente come quella di Carlos. Criticarono l’antiamericanismo e l’antisionismo della ‘sinistra antiimperialista’ e propagarono forme di attacco che non producessero morti.
Su richiesta, la Procura pubblica di Francoforte conferma oggi che, fino al 1999 ed a parte le affermazioni di Klein, non v’è mai stato il minimo indizio che Suder sia stata coinvolta nella prima fase delle RZ fino al 1976. Klein, la cui credibilità viene spesso paragonata con l’ex-membro della RAF e raccontatore di storie Peter-Jürgen Boock, accusò dei militanti delle RZ ed altre persone di aver partecipato all’attacco contro l’OPEP. Rudolf Schindler venne per questo processato dal tribunale di Francoforte. E venne assolto dall’accusa di complicità nell’attaco all’OPEP, smentendo l’accusa di Klein. La corte dubitò della sua “certezza di identificazione nel riconoscimento fotografico del 2.9.1999”. In quell’occasione accusò assieme a Schindler anche Suder, “benché in precedenza non avesse mai accennato ad un’altra donna”, affermò il tribunale già 2001. A parte la dichiarazione di Klein, ancora oggi la procura penale non ha null’altro in mano contro Suder per l’attacco all’OPEP.
TAZ: Quanto presenti sono state per voi in questi anni le accuse dei ’70, di una fase sempre più lontana delle vostre vite? Avete potuto avere una vita normale?
Suder: All’inizio no. Ti guardi sempre dietro per vedere se c’è qualcuno. Se parla tedesco.
Gauger: Il meno possibile contatti con dei tedeschi, questo è molto importante.
Signora Suder, signor Gauger, non vi è mai venuto in mente in tutti quegli anni: la storia è così vecchia, che senso ha, vogliamo ritornare e affrontiamo il passato?
Suder: Insomma, a me no. E a te, Christian?
Gauger: Certo, se avessero revocato i mandati di cattura.
Suder: Molto divertente. Ora è però chiaro: se la Francia ci estrada, saremo processati in Germania.
Il gruppo al quale avreste appartenuto si è sciolto definitivamente all’inizio degli anni novanta. Questo ha qualche influenza sul processo?
Suder: Giuridicamente nessuna. Dopo l’entrata in vigore degli accordi penali europei, siamo stati arrestati una seconda volta nel 2007. Christian per quattordici giorni ed io per un mese. E dal 2009 dobbiamo contare ogni giorno sull’eventualità di un’estradizione, benché il tribunale francese avesse già negato l’estradizione nel 2001
Dopo la vostra scoperta nell’anno 2000 e il rifiuto della domanda di estradizione avete vissuto a Parigi per la prima volta di nuovo legalmente. Com’è stato per voi?
Suder: Quando vivi sempre con una leggenda, non ti puoi costruire delle vere amicizie. Abbiamo vissuto tutti quegli anni molto ritirati. A Parigi in un primo tempo non avevamo nessun contatto. La nostra avvocatessa ci ha trovato dei compagni italiani, così da avere almeno un indirizzo da indicare per poter essere scarcerati. Poi una bravissima donna ci ha ospitati. Credo che in Germania sarebbe stato più difficile. Ma la cultura repubblicana ha in Francia una ricca e secolare tradizione di offrire rifugio agli esuli. Persone che non conoscevamo ci hanno lasciato la loro casa per mezzo anno, sono andati ad abitare nel sud della Francia permettendoci così di cercarci una nostra abitazione a Parigi. Praticamente non conoscevano né noi né la nostra storia, e ci hanno semplicemente aiutati. Ci siamo poi integrati in fretta nell’ambiente, abbastanza grande, degli esuli italiani, i militanti degli anni ’70 qui rifugiati, con le loro discussioni e le loro feste. Sono molto solidali. Abbiamo avuto fortuna.
Da Francoforte a Parigi
1. Clandestini: Nell’estate 1978 a Francoforte Sonja Suder e Christian Gauger si accorsero di essere spiati. Partirono all’estero ed assunsero false identità. Probabilmente vissero in Francia, a Lille. Nel 1997 Gauger subì un colpo apoplettico e perse la sua memoria -della falsa come della vera identità.
2. Scoperti: Nel 2000 vennero scoperti ed arrestati davanti ad un albergo a Parigi. Separati, passarono alcuni mesi in carcere preventivo. Da allora Suder, 77 anni, e Gauger, 68, vivono a Parigi. La Germania ne chiede alla Francia l’estradizione -fin’ora invano.
3. Incolpati: La Procura di Francoforte sul Meno accusa oggi la coppia di aver partecipato ad attentati contro imprese nel 1977 e contro il castello di Heidelberg nel 1978. Suder è inoltre accusata di complicità in omicidio: per l’attacco alla conferenza dei ministri dell’OPEP a Vienna nel 1975, dove tre persone persero la vita. Questa accusa è basata soltanto sulle dichiarazioni dell’ex-terrorista Hans-Joachim Klein.
Erri De Luca: prendiamo congedo dall’emergenza contro i rivoluzionari del ‘900
Prescrizione per i governanti
di Erri De Luca
Le Monde 8 février 2010
Il secolo ventesimo è stato quello delle rivoluzioni, la prima in Russia nel 1905, le ultime nell’Europa orientale dopo il collasso del patto di Varsavia. Con le rivoluzioni sono stati rovesciati i rapporti di forza e di oppressione,emancipando immense masse umane nel 1900, dall’Asia alle Americhe. E’ andata così nel mio tempo, sono stato militante rivoluzionario nell’Italia degli anni ‘70, non per estro di gioventù ma in obbedienza all’ordine del giorno del mondo.
Sono ancora in vita gli ultimi rivoluzionari del 1900. Alcuni sono diventati capi di stato e di governo, per loro si suonano gli inni nazionali. Altri restano dietro sbarre, in esili senza fine, oppure in frastornata libertà dopo decenni scontati in prigione. Queste ultime vite andrebbero protette, perchè sono la reliquia politica del secolo delle rivoluzioni, il grandioso 1900. Per esempio andrebbero protette le vite della signora Sonia Suder e del signor Christian Gauger (accusati di aver appartenuto alla Cellule rivoluzionarie tedesche, formazione politica degli anni 70) che stanno per essere estradati dalla Francia e consegnati alle prigioni tedesche. Spedire al giorno 1 di pena, alla casella di partenza, dei rivoluzionari del 1900, colpevoli secondo l’accusa di reati politici di trenta e più anni fa (otto olimpiadi): non è solo triste, è pure antico. Ribadisce che il ventesimo è secolo ancora in corso, alla faccia del miope che l’ha intravisto breve.
E’ invece tempo di prendere congedo dal secolo delle rivoluzioni, lasciando gli spiccioli di vita degli ultimi rivoluzionari al loro corso, togliendoli dal piccolo martirio delle ultime serrature.
Le polizie devono attenersi a mandati anche se abbondantemente scaduti. Ma esiste la misura e la saggezza politica per correggere distorsioni e stabilire in propria autonomia il tempo di chiudere e quello di aprire.
Le vite di Sonia Suder e Christian Gauger vanno protette non per clemenza, ma per evidenza di tempi scaduti, per diritto politico di chiudere il registro di classe del 1900. Si smette così di suddividere i rivoluzionari in vincitori da accogliere con cerimonia ufficiale, e vinti da estradare. Non perchè sono anziani, l’età, che condivido con loro, non è una attenuante. Attenua, sì, molte cose, ma non la responsabilità di essere stati dei rivoluzionari al tempo necessario.
E’ tempo di dichiarare prescritto il 1900 delle rivoluzioni, per pura igiene fisica e mentale. I nomi di Sonia Suder e Christian Gauger, siano consegnati all’archivio politico e non alla cronaca giudiziaria. E’ una buona occasione per stabilire il primato e la sovranità della politica sulle vite umane.
Prescription pour les gouvernants
di Erri De Luca Le Monde 8 février 2010
 Le XXe siècle a été le siècle des révolutions, la première en Russie en 1905, les dernières en Europe de l’Est après l’effondrement du pacte de Varsovie. Les rapports de force et d’oppression se sont inversés avec les révolutions, en émancipant d’énormes masses humaines dans les années 1900, de l’Asie aux Amériques. C’est ce qui s’est passé à mon époque, j’ai été un militant révolutionnaire dans l’Italie des années 1970, non par caprice de jeunesse, mais par obéissance à l’ordre du jour du monde.
Le XXe siècle a été le siècle des révolutions, la première en Russie en 1905, les dernières en Europe de l’Est après l’effondrement du pacte de Varsovie. Les rapports de force et d’oppression se sont inversés avec les révolutions, en émancipant d’énormes masses humaines dans les années 1900, de l’Asie aux Amériques. C’est ce qui s’est passé à mon époque, j’ai été un militant révolutionnaire dans l’Italie des années 1970, non par caprice de jeunesse, mais par obéissance à l’ordre du jour du monde.
Les derniers révolutionnaires du XXe siècle sont encore en vie. Certains sont devenus des chefs d’Etat et de gouvernement, on joue pour eux les hymnes nationaux. D’autres restent derrière les barreaux, dans des exils sans fin, ou bien dans une liberté désorientée après des dizaines d’années purgées en prison. On devrait protéger ces dernières vies, car elles sont les reliques politiques du siècle des révolutions, le grandiose XXe siècle.
Il faudrait protéger par exemple les vies de Sonja Suder et de Christian Gauger (soupçonnés d’avoir fait partie des “cellules révolutionnaires” allemandes), qui sont sur le point d’être extradés de France et remis aux autorités allemandes. Renvoyer au jour numéro un de leur peine, à la case départ, des révolutionnaires du XXe siècle, accusés de crimes politiques vieux de trente ans ou plus (huit olympiades)Pre: c’est non seulement triste, mais dépassé. C’est réaffirmer que le XXe siècle est encore là, en dépit des myopes qui l’ont vu bref.
Il est temps au contraire de prendre congé du siècle des révolutions, en laissant les miettes de vie des derniers révolutionnaires suivre leur cours, en les délivrant du petit martyre des dernières clôtures. Les polices doivent s’en tenir à des mandats d’arrêt, même largement expirés. Mais il existe la mesure et la sagesse politique pour corriger des distorsions et décider en toute autonomie du temps de fermer et de celui d’ouvrir.
Les vies de Sonja Suder et de Christian Gauger doivent être protégées non par clémence, mais par évidence de temps expirés, par droit politique de fermer le cahier de classe du XXe siècle. On cessera ainsi de diviser les révolutionnaires en vainqueurs à recevoir avec des cérémonies officielles, et en vaincus à extrader. Non pas parce qu’ils sont vieux, l’âge, que je partage avec eux, n’est pas une circonstance atténuante. Oui, elle atténue beaucoup de choses, mais pas la responsabilité d’avoir été révolutionnaires au moment nécessaire.
Il est temps de déclarer prescrit le XXe siècle des révolutions, par pure hygiène physique et mentale. Que les noms de Sonja Suder et de Christian Gauger soient consignés dans les archives politiques et non pas dans la chronique judiciaire. C’est une bonne occasion pour établir la suprématie et la souveraineté de la politique sur les vies humaines.
Traduit de l’italien par Danièle Valin
Martino Zicchitella
Prosegue la sezione di questo sito dedicata ai compagni uccisi durante azioni armate, tutti quelli che normalmente vengono rimossi dalla memoria collettiva, tutti gli “scomodi”.
Molti in questo ultimo periodo li ho saltati. Per problemi di tempo, ma non per dimenticanza, quindi il danno verrà riparato al più presto e tutti coloro che sembravano essere stati dimenticati dalle pagine di questo blog verranno ricordati.
Non ci si dimentica del proprio sangue.
Il tutto è tratto dal Progetto Memoria, Edizioni Sensibili alle Foglie
MARTINO ZICCHITELLA
– Nasce a Marsala il 26 aprile 1936
– pochi anni dopo si trasferisce a Torino
– svolge attività extra-legali e viene arrestato per rapina del ‘66
– evade dal carcere di Firenze
– riarrestato milita nel movimento di rivolta dentro alle carceri
– milita nei Nuclei Armati Proletari
– resta ucciso a Roma, durante un’azione armata dei N.A.P. il 14 dicembre 1976
Scritture di Martino Zicchitella
– “Memoriale redatto da Zicchitella; Anarchismo n.10 – 11, Catania 1976
 “Prima del mio arrivo nella Casa di reclusione di Lecce, mi era stato accennato come fosse usuale in questo luogo, conosciuto come il “lager del Salento”, percuotere i nuovi arrivati. Già il compagno S. N. in un memoriale presentato alla magistratura alcuni mesi fa, descriveva fatti avvenuti e metodi usati di violenza da restare sgomenti; egli si riferiva al caso di un detenuto che dopo essersi aperto il ventre dalla disperazione con un’arma da taglio, fu oggetto di un pestaggio da parte degli agenti di custodia, che lo ridussero in fin di vita a colpi di manganello e calci. Lo stesso poi (il suo nome era Caradonna), fu abbandonato in una cella sotterranea senza che gli fossero state apprestate le cure necessarie.
“Prima del mio arrivo nella Casa di reclusione di Lecce, mi era stato accennato come fosse usuale in questo luogo, conosciuto come il “lager del Salento”, percuotere i nuovi arrivati. Già il compagno S. N. in un memoriale presentato alla magistratura alcuni mesi fa, descriveva fatti avvenuti e metodi usati di violenza da restare sgomenti; egli si riferiva al caso di un detenuto che dopo essersi aperto il ventre dalla disperazione con un’arma da taglio, fu oggetto di un pestaggio da parte degli agenti di custodia, che lo ridussero in fin di vita a colpi di manganello e calci. Lo stesso poi (il suo nome era Caradonna), fu abbandonato in una cella sotterranea senza che gli fossero state apprestate le cure necessarie.
Trasferito in questo stabilimento, ebbi modi di constatare, e subire, i metodi che venivano messi in atto: un trattamento riservato quasi sempre ai compagni o simpatizzanti di sinistra.
Il 30 giugno 1975 faceva il mio ingresso nella menzionata casa penale proveniente da Rebibbia, dove fui trattato secondo il regolamento. Alla villa Bobò di Lecce invece, appena preso in consegna dal corpo di guardia del carcere, mi venne rivolta da un brigadiere degli agenti di custodia, questa frase: “E adesso che cosa avanzi?”
Certo non potevo immaginare cosa mi sarebbe accaduto nei seguenti 80 giorni. Dopo essere stato portato in un ufficio adiacente a quello del maresciallo comandante, fui perquisito da cima a fondo, senza rispetto alcuno della personalità umana, con accurate esplorazioni anali, poi introdotto in una sezioncina detta “Reparto isolamento”: qui fui rinchiuso in una cella che non aveva alcun arredo, solo mura, porte e inferriate di ferro. Qui ci rimasi circa mezzora, dopo di che fui invitato ad uscire in un corridoio dove c’erano ad attendermi un numero considerevole di guardie (una quindicina ).
Mi fecero percorrere il corridoio della sezione e a spintoni mi condussero in un passaggio che immetteva in un sotterraneo dello “la campana”. Si trattava di tre anguste celle lunghe due metri e trenta per uno e cinquanta. Appena scesi gli scalini e spinto in una delle tre cellette (la seconda), venni aggredito da alcune guardie che erano nel corridoio precedentemente, agli ordini di un appuntato.
Queste mi furono addosso in un baleno e mi percossero selvaggiamente per mezzora con calci e pugni, tanto da farmi svenire e procurarmi lesioni e dolori che accusai per oltre un mese. Dopo il primo pestaggio, chiusero la porta della cella e quella della sezione andandosene. Il locale maleodorante e sudicio era umidissimo, l’unica suppellettile era un bugliolo senza coperchio nel quale c’erano ancora escrementi umani.
Di lì a poco tempo con un rumore assordante di chiavi e ferri sbattuti, arrivarono altre guardie, era una seconda squadretta per il secondo pestaggio, l’appuntato era sempre lo stesso, aprirono la mia cella e mi si avventarono nuovamente addosso, dicendomene di tutti i colori, frasi come bastardo, fottuto, delinquente.
Mi strapparono da dosso la camicia e i pantaloni e questa volta ricevetti anche dei colpi con un bastone. Insomma avevo le ossa e il corpo in stato pietoso, era blu per le ecchimosi, il sangue mi fuoriusciva dal naso, dalla bocca, dalle abrasioni alle braccia e al corpo. Prima che se ne andassero gettarono nella cella due secchi d’acqua allagando l’angusto locale; in queste condizioni rimasi ben 24 giorni, cioè nudo con acqua sul pavimento e con scarso cibo, per i primi tre giorni non mi dettero nulla e per un mese non vidi un raggio di luce, e non presi una boccata d’aria all’esterno.
Nello stesso periodo ebbi modo di conoscere altri compagni che avevano subito o subirono vessazioni e pestaggi. 
Il trattamento fu pressappoco analogo per tutti: il B.D.S. fu addirittura messo in un reparto denominato “il forno”, locale strettissimo e privo di finestre, nel buio più totale, per diversi giorni. Altri due mesi, poi me li fecero trascorrere in una cella di un piano superiore, dove c’era un pancaccio e un gabinetto alla turca. Alla “campana” per tutta la durata dei 24 giorni non mi fu data né una branda né un materasso. Dormivo a terra con una coperta sudicia che subito si inzuppava d’acqua, che mi veniva consegnata la sera alle 21 e ritirata la mattina alle 8.
Continue furono le istigazioni al suicidio e durante la notte mi costringevano ad alzarmi per il controllo della ronda, la luce era accesa giorno e notte, naturalmente per tutto il tempo che rimasi in quel buco, non potei acquistare cibo, né scrivere a mia madre, la quale dopo il mio trasferimento da Roma non sapeva dove fossi stato mandato. […]
– Martino Zicchitella, “Assassinio di un uomo”, Porto Azzurro, in: Autori Vari, Liberare tutti i dannati della terra, Roma 1972, Edizioni Lotta Continua–
“Questa è la giustizia del nostro paese, condanne assurde, senza troppo andare per il sottile, labili indizi per ciò che concerne la colpevolezza, prove ed alibi di innocenza non tenuti in considerazione. Perché? Si tratta di un pregiudicato, pregiudicato divenuto per protesta di una società che fa schifo, democrazia di capitalisti, uomini che sfruttano milioni di altri uomini, salariandoli con molliche di pane, briciole lasciate cascare dalla loro sontuosa mensa, briciole che non sfamano, gocce che tengono in vita un moribondo.
Pregiudicato è colui che, stanco dei soprusi, stanco di essere sfruttato, stanco del massacrante turno di lavoro, dice al padrone: basta, ladro, restituiscimi ciò che mi hai rubato prima.
Stenti e fame alle dipendenze del padrone.
Stenti e fame durante l’espiazione della pena.
Stenti e fame dopo l’espiazione, scacciato e insultato.
Pregiudicato e operaio da noi, negro in America non sono che forme di preconcetti razziali del capitalismo, dei padroni che ci trattano come servi della gleba, quei padroni che vivono senza sapere che vuol dire un’esistenza squallida, nella miseria, senza sapere cosa significa desiderare pane e mortadella, di non aver avuto da bambino il piacere di possedere un giocattolo costoso, a volte il calore e l’affetto di una famiglia, del focolare.
L’orfanotrofio, il correzionale, il carcere, ecco sfornato il pregiudicato. Ed ora? … marcisca in una patria galera … rieducarlo ora? macché, carne da macello, taluni gridano pena di morte, altri no! Fatelo vivere, fatelo vegetare, l’organizzata industria della giustizia deve avere la sua materia prima.
Polizia, carabinieri, parte di una florida industria che produce … pregiudicati, e criminali, il carcere è l’università ove si laurea, la scuola per delinquere, il giovane che vi è rinchiuso oggi per un furtarello, sarà il rapinatore o l’assassino di domani, non importa, l’industria non deve fallire.
 Le carceri magazzini di carne umana sono zeppe, si raggiunge ormai, in ogni stabilimento penale o giudiziario, la saturazione, uno sull’altro come animali, l’esempio più classico dei tre compagni arsi vivi a San Vittore in un’angusta cella, dico tre persone … tre giovani vite stroncate nel fiore dell’età per una assurda condizione carceraria, per il sadismo edilizio che costringe tre giovani a stare rinchiusi in due metri quadrati di spazio.
Le carceri magazzini di carne umana sono zeppe, si raggiunge ormai, in ogni stabilimento penale o giudiziario, la saturazione, uno sull’altro come animali, l’esempio più classico dei tre compagni arsi vivi a San Vittore in un’angusta cella, dico tre persone … tre giovani vite stroncate nel fiore dell’età per una assurda condizione carceraria, per il sadismo edilizio che costringe tre giovani a stare rinchiusi in due metri quadrati di spazio.
Nel carcere di Torino sono stato compagno di cella con Bobbio, Viale, Bosio, Mochi Sismondi, compagni e seguaci di Lotta Continua, al loro fianco ho compreso veramente il valore di ciò che significhi lotta per la libertà, lotta al capitalismo: ed a tutte le sue strutture borghesi, con profonde radici fasciste.
Con loro ho vissuto momenti di vera fratellanza, fummo commensali, discutemmo sulle occupazioni delle fabbriche, delle università, la Fiat, Palazzo Campana. Su queste basi capeggiai nell’estate ’68 una rivolta passiva. Un sit-in alla Bertrand Russel a protesta e a richiesta che si facesse di più per i detenuti, che si riformassero i codici, che si varasse l’ordinamento carcerario, fui prelevato di peso, attaccato dalla Stampa per il mio gesto e trasferito in casa di rigore. Ancora una volta dovetti subire la repressione da parte della polizia e voluta dai capitalisti.
Dovrò ancora scontare oltre 15 anni di carcere per dei reati che non ho commesso, con ingiustizie e provocazioni: uscirò … debbo uscire per scendere ancora in piazza e alzare la destra, serrare il pugno, dovrò contestare, dovrò combattere la polizia mia acerrima nemica, il capitalismo dovrà essere sconfitto, e con loro i servi e i fascisti, dovrò uscire per raggiungere i miei compagni e marciare al loro fianco verso un nuovo orizzonte.”
Documenti prodotti da organizzazioni armate per la persone o per l’evento in cui ha incontrato la morte
– Nuclei Armati Proletari, “Onore al compagno Zicchitella”, Roma 1976
“Il compagno Martino Zicchitella nacque a Marsala il 26-4-1936 ma fin da piccolo ha vissuto a Torino, la città della borghesia savoiarda, degli ex-repubblichini, la citta dei Valletta, la città in cui la sperequazione capitalistica è più evidente e più umiliante. La città metropoli in cui, già negli anni del boom, la vita sociale è pianificata, controllata e manipolata; dove ogni attività è finalizzata alla produzione di plusvalore e consenso, attraverso l’utilizzazione dei più rudimentali mass-media del tardo capitalismo.
Dai casermoni di Via Verdi ai portici di Via Roma lastricati di marmo, alla Barriera di Milano, alla Crocetta, i salariati di Torino si battono tra centinaia di contraddizioni giornaliere, simili a quelle di qualsiasi altro paese capitalista, ma tutte riconducibili a una sola: quella della propria appartenenza di classe, del proprio potere di acquisto dal quale dipende la gradazione della propria identità umana e sociale. Qui l’acquisizione e l’interiorizzazione dei valori legati all’ideologia borghese non sono scelta, sono induzione violenta, costante, asfissiante.
Martino sceglie la strada dell’appropriazione violenta ed individuale del benessere padronale: quella della rapina, per cui viene arrestato nel ’66.
Durante l’alluvione di Firenze, Martino evade, vive ancora contraddittoriamente la sua realtà di proletario detenuto; salverà invece alcuni giovani dalla melma dell’Arno.
Il carcere e lo scontro che in esso si vive collettivamente gli fanno acquisire i primi elementi di coscienza rivoluzionaria e lo portano nel ’68 alla testa, come direzione ed avanguardia riconosciuta, delle prime dimostrazioni pacifiche nelle carceri “Nuove” di Torino, alle quali il potere risponde brutalmente, come sempre.
Nel ’70 Martino ha pienamente chiarificato la sua identità, ha identificato lo Stato anche nelle sue appendici carcerarie e riesce ad evadere da Alessandria.
Rimane fuori poche ore con le gambe spezzate per il salto dal muro di cinta. Ripreso viene massacrato dalle guardie e rimarrà claudicante.
Nel ’71 è alla testa della rivolta delle “Nuove”. Con lui altri compagni che in quelle lotte e da quelle lotte hanno con sequenzialmente maturato la scelta della lotta armata; all’interno della quale rappresentano le avanguardie più alte e più coscienti del proletariato detenuto, al quale la loro prassi fornisce le più chiare indicazioni: l’evasione e l’organizzazione combattente.
Il ’71 è l’anno di Attica per i proletari che si ribellano in USA; quello di Porto Azzurro per i compagni come Martino. Le successive rivolte ad Alghero, Noto, Enna, lo vedono farsi carico, nella gestione delle lotte, degli interessi di sopravvivenza dei proletari prigionieri, della loro necessità di organizzarsi e combattere.
Nel ’74 a Viterbo inizia un confronto con altre avanguardie espresse dalle lotte dei detenuti sulla costituzione in organizzazione politico-militare all’esterno di alcune avanguardie rivoluzionarie.
Con la presenza a Viterbo di un militante dei NAP, il confronto prosegue e si sviluppa interno-esterno, sul piano politico quanto su quello organizzativo-militare.
Partecipa così alla costruzione e alla realizzazione della operazione coordinata con l’attacco armato interno-esterno del maggio ’75 che vede al primo posto la parola d’ordine della liberazione dei combattenti comunisti prigionieri.
L’attacco interno non coglie l’obiettivo della liberazione ma, per effetto dell’attacco esterno che vede imprigionato il boia Di Gennaro, è comunque un momento di enorme crescita politico-militare che Martino fa suo patrimonio all’interno dell’organizzazione dei NAP.
Trasferito a Lecce per rappresaglia subisce per mesi torture fisiche e psicologiche ma non cessa di porsi come direzione dello scontro organizzando e realizzando con un altro militante dei NAP l’azione armata dell’agosto ’76 che porta alla liberazione di 11 prigionieri.
La sua morte nello scontro di Roma caratterizza e definisce la sua vita e la sua coerenza di combattente comunista.”
Sonja e Christian: altre 2 estradizioni annunciate
Quando la memoria si fa vendetta
dal blog Damnatio Memoriae prendo questo lungo articolo. Finalmente del materiale in italiano -OTTIMO- su questi due compagni rifugiati in Francia.
Ancora due estradizioni
Fatta a pezzi la dottrina Mitterrand, la Francia non si vergogna più di tradire la parola data, di rinnegare l’ospitalità concessa.
Stavolta sono due ex-militanti tedeschi degli anni ’70 a subire la vendetta di Stato.
La loro storia ripropone le assurdità di quella di Paolo Persichetti, Cesare Battisti e Marina Petrella.
 Come i militanti italiani, anche Sonja Suder (oggi 76 anni) e Christian Gauger (68) si erano rifugiati in Francia, dopo aver militato nelle Revolutionäre Zellen (RZ), organizzazione autonoma di cui s’è parlato nel post sulla strage di Bologna.
Come i militanti italiani, anche Sonja Suder (oggi 76 anni) e Christian Gauger (68) si erano rifugiati in Francia, dopo aver militato nelle Revolutionäre Zellen (RZ), organizzazione autonoma di cui s’è parlato nel post sulla strage di Bologna.
Sonja e Christian arrivano in Francia nel 1978 e vivono a Lille, una cittadina di provincia, dove campano da ‘brocante’ con pochi soldi, recuperando, riparando e rivendendo oggetti al mercato delle pulci.
Nel 2000, vengono arrestati su mandato estradizionale della Repubblica Federale Tedesca, che rimprovera loro la partecipazione a tre azioni incruente : nell’agosto 1977 le esplosioni contro la ditta MAN di Norimberga e la ditta KSB di Frankenthal, e nel maggio 1978 l’incendio al castello di Heidelberg.
Gli attacchi furono rivendicati dalle Revolutionäre Zellen (RZ), che accusavano le due imprese di produrre compressori e pompe per il nucleare, esportandole tra l’altro verso il Sud Africa, dove vigeva l’apartheid razzista (siamo al tempo del massacro del ghetto di Soweto, con Nelson Mandela incarcerato come terrorista), ed il sindaco di Heidelberg della politica di distruzione di quartieri cittadini per farne delle zone destinate ai ricchi. [‘Gentrificazione’, dall’inglese gentry, nobile, è il neologismo che oggi si usa per indicare questi processi di modificazione classista del territorio urbano.]
Ulteriore accusa contro Sonja, era di aver contribuito al reclutamento nelle RZ di Hans-Joachim Klein e all’organizzazione logistica dell’attacco alla sede dell’OPEP a Vienna nel 1975. Tre mesi dopo quel primo arresto sono messi in libertà provvisoria su cauzione ed in seguito la corte parigina emette un ‘avviso sfavorevole’ all’estradizione. La possibilità di perseguire i due viene negata alla Germania poiché i reati sono, secondo il diritto francese, prescritti per i molti anni passati dagli avvenimenti.
Sonja e Christian, il cui rifugio in Francia sembra solidamente garantito da una sentenza definitiva, riprendono così una vita ‘normale’ da esiliati, per la prima volta alla luce del sole. Per la prima volta dopo 22 anni, possono allacciare rapporti sociali apertamente, senza nascondersi, ed entrare in contatto anche con altri esiliati, tra cui gli italiani, che offrono loro appoggio solidale.
Per Christian la ritrovata condizione di legalità è inoltre particolarmente importante, poiché gli permette di accedere alle cure mediche di cui ha urgente bisogno, per i gravi problemi cardiaci di cui soffre.Ciò che invece sta proprio in quegli anni cominciando a cambiare, è la politica di asilo del governo.
Dall’elezione del socialista François Mitterrand alla Presidenza della Repubblica, nel 1981, la Francia aveva preferito non estradare gli ex-militanti rifugiatisi sul suo territorio. Il principio seguito era quello dell’ospitalità verso chi, esiliandosi apertamente e quindi rispettando le leggi del paese che li accoglie, avesse rinunciato alla lotta armata.
Quali che fossero le sentenze nelle procedure d’estradizione verso l’Italia, e cioè anche in caso di “parere favorevole all’estradizione”, la Francia non rimpatriava i rifugiati politici di fatto. Indifferenti a tentativi e proteste delle autorità italiane, tutti i governi francesi continuarono a seguire questo principio, che aveva del resto un aspetto utilitario di un certo rilievo, almeno nei primi anni: evitare la clandestinità sul proprio territorio di centinaia di ex-militanti, ed evitare così di spingerli di nuovo all’illegalità.
Dopo i famosi attentati dell’11 settembre negli Stati Uniti, tutto cambia: ora il principio si chiama ‘tolleranza zero’. Il 25 agosto 2002 viene eseguita nel giro di poche ore l’estradizione di Paolo Persichetti, che da 8 anni era stato lasciato lavorare e studiare alla luce del sole.
Seguirà Cesare Battisti, anche lui ‘legalizzato’ con un permesso di soggiorno, dopo aver subito, 13 anni prima, un processo estradizionale risoltosi con un “parere sfavorevole”, che è ri-arrestato nel 2004 e ri-processato fino ad ottenere un “parere favorevole” (per gli stessi reati del precedente “parere sfavorevole”).
Nel 2007 è di nuovo la volta di Sonja e Christian.
Vanno in farmacia a prendere delle medicine e vengono catturati: “un agguato puro, come nel caso di Paolo”, commentano.
E come nel caso di Cesare, di nuovo un processo estradizionale per le stesse accuse, fino ad ottenere un “parere favorevole”, che arriva nel febbraio 2009.
Questa volta, per cappottare la prima sentenza, i giudici dicono che i termini di prescrizione applicabili sono quelli tedeschi.
E subito, nel luglio 2009, il Primo ministro François Fillon firma il decreto d’estradizione, che viene comunicato a fine ottobre.
Accuse senza atti
Sonja e Christian, difesi dall’avvocato Irène Terrel, hanno ancora un ricorso aperto al Consiglio di Stato. Il loro pessimismo è purtroppo legittimo.
“Se ci estradano, finiamo in prigione a Hessen. Gli avvocati tenteranno ovviamente di tirarci fuori, ma chissà quando tempo occorrerà per il processo. Sarà messo in cantiere quando saremo nel paese. Anche gli atti non li si riceve prima, e così non si può neppure preparare una strategia difensiva.”
Ciò che si sa, è che il loro coinvolgimento nei procedimenti penali contro le RZ (sui gruppi Revolutionäre Zellen e Rote Zora si è detto nel post sul caso Thomas Kram), è dovuto alle dichiarazioni del 1978 di un altro militante, Hermann Feiling.
Hermann Feiling, all’epoca studente di 26 anni, venne colpito dall’esplosione di una bomba che era destinata al consolato argentino di Monaco per protesta contro la feroce repressione scatenata dalla dittatura militare. Quel 23 giugno 1978, l’esplosivo, che avrebbe al più rotto qualche mattone del muro consolare, lo ridusse in fin di vita. Il suo ‘interrogatorio’ cominciò meno di 24 ore dopo le operazioni chirurgiche d’urgenza che dovette subire. Le autorità volevano approfittare della situazione per “penetrare nelle Cellule Rivoluzionarie” -come dichiarò il Procuratore federale Kurt Rebmann in una conferenza stampa il 4 luglio- di cui conoscevano poco o niente. Ti è esplosa una bomba sulle ginocchia: hai perso le gambe (amputazioni sopra la coscia), e gli occhi (estrazione dei bulbi oculari). Sei rintronato, letteralmente (epilessia post-traumatica), e i tuoi sensi sono alterati (lesioni cerebrali alla funzione della memoria).
Un essere umano in queste condizioni ha bisogno di aiuto, di cure, di protezione. Negargliele per intero, esercitando un potere assoluto sulle sue condizioni, è un trattamento inumano.Nel buio in cui hai paura di essere abbandonato, qualcuno ti fa capire di volerti aiutare, di essere dalla tua parte. Sei circondato solo da investigatori, procuratori, guardiani e personale medico, ma hai sentito un nome che credi sia del tuo avvocato, e quelli sono tutto il ‘tuo’ ambiente sociale che ti ‘sostiene’, l’unico contatto che ti racconta il mondo che non vedi più. Hai un male cane, ti riempiono di medicine (Dipidolor, a base di morfina, Valium a siringate) che ti rendono ancora più strano, ma ti alleviano il dolore, e loro ti parlano, ti chiedono.
Così è stato ‘sentito’ Heiling, a cominciare dalla clinica universitaria in cui venne ricoverato d’urgenza, isolato per quattro mesi da ogni contatto con familiari, amici e difensori; questa misura di ‘Kontaktsperre’, usata nei regimi di reclusione più duri per i ‘terroristi’, non era neppure basata su un ordine di arresto, e addirittura ‘Der Spiegel’, il settimanale del gruppo Springer nemico giurato dei terroristi, se ne mostrò sorpreso.
L’articolo che lo Spiegel pubblicò a commento del processo, nel novembre 1980, si chiedeva: Un uomo senza gambe né occhi sul banco degli accusati. Combattere i terroristi a qualsiasi prezzo?
Nella sua dichiarazione al processo, Hermann Feiling ebbe a dire: La mia condizione di pericolo di vita, il traumatismo dopo l’accecamento, il mio assoluto disorientamento, la mia totale impotenza capitarono al momento giusto per investigatori, dopo anni di frustrazioni. Le 1330 pagine di verbali, che proverrebbero da me, sono il frutto di quella situazione. Lì ci sono anche persone del mio fantastico mondo dei sogni di allora che vengono chiamate in causa in relazione alle RZ, o vengono accusate persone che io non ho mai conosciuto.Un paio di luminari della contro-guerriglia media attesteranno che Hermann era in perfette condizioni per rispondere coscientemente agli interrogatori, magari non da subito, ma quasi. (vedi le perizie del Prof. Mentzos e del Prof. Jacob)
Dell’uso della malattia come strumento di indagine, di cui s’è parlato recentemente in Italia (per il suicidio di Diana Blefari Melazzi) c’è un altro episodio che sembra ricalcare quello di Hermann Feiling.
Nel 2002, in Grecia, il pittore di icone Savvas Xiros ebbe pure lui un incidente con una bomba, che gli costò tra l’altro le mani.
E pure lì la polizia brancolava nel buio da anni e saltò sull’occasione. L’organizzazione clandestina cui davano la caccia si chiamava 17 Novembre, e nessuno dei suoi membri era stato mai identificato. Con le ‘interviste’ ad un uomo in brandelli riuscirono a prenderne i militanti e ad irrorarli di ergastoli. Giustificarono poi i metodi da ‘Guantanamo greca’ dicendo che Savvas non era in stato di arresto, e tutti quegli incappucciati che lo circondavano erano li ‘per proteggerlo’.
Le ragioni dell’accusa
Le narrazioni di Hermann Feiling sono dunque il primo pilastro dell’accusa, che vorrebbe fare a Sonja e Christian un ennesimo ‘ultimo processo alle RZ’. Ennesimo, perché già il processo conclusosi il 19 febbraio 2009 a Stammheim era stato chiamato così dalla stampa (vedi Il processo a Thomas K., anche per alcuni tratti storici e politici delle RZ).
Il secondo pilastro dell’accusa è costituito dalle dichiarazioni di un pentito, Hans-Joachim Klein, che ha raccontato che Sonja lo avrebbe messo in contatto, nel 1975, con il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina ‘External Operations’(PFLP-EO) per organizzare l’attacco alla sede dell’OPEP di Vienna.
Klein fece da ‘testimone della corona’ (Kronzeuge, delatore premiato) in quel processo e ne ottenne in cambio la libertà (fece 3 degli 8 anni di condanna, anziché tre ergastoli).
Il tribunale di Francoforte assolse però Rudolph Schindler, altro ex-militante delle RZ accusato degli stessi fatti rimproverati ancora oggi a Sonja, perché ritenne Hans-Joachim Klein completamente inattendibile.Anche questo secondo ‘pilastro’ è di sabbia, tanto che ci si chiede che senso abbia mantenere un mandato di cattura internazionale, perché spingere tanto una procedura d’estradizione, per accuse così fragili e dopo 34 anni dai fatti? “Mancanza di pentimento e di disponibilità a cooperare vanno punite, altrimenti non non si faranno più accordi e nemmeno paura. Quando dei militanti della sinstra se la cavano, è una piccola, ma fondamentale trasgressione della ragion di Stato.”  Così commenta Analyse&Kritik (‘Non perdonare nulla, non dimenticare nulla’ Nr. 538/17.4.2009), e che ci sia voglia di esemplarità in è l’unica spiegazione sensata di questo caso. La vedono anche Sonja e Christian: “… si crede, con un processo come questo, di poter dimostrare alla nascente resistenza che nessuno se la cava.”
Così commenta Analyse&Kritik (‘Non perdonare nulla, non dimenticare nulla’ Nr. 538/17.4.2009), e che ci sia voglia di esemplarità in è l’unica spiegazione sensata di questo caso. La vedono anche Sonja e Christian: “… si crede, con un processo come questo, di poter dimostrare alla nascente resistenza che nessuno se la cava.”
La memoria giudiziaria
Da parte sua, il Ministero pubblico di Francoforte si nasconde dietro il dito della legalità: “Noi dobbiamo perseguire fino alla prescrizione”, dice la sua portavoce Doris Möller-Scheu “e da noi l’omicidio non va in prescrizione.” Omicidio? Allude alle vittime dell’attacco all’OPEP, cui Sonja non ha partecipato, non ve ne sono altre possibili perché la violenza praticata dalle RZ escludeva il ricorso all’assassinio politico.
Ciò che è in realtà successo, è che la seconda richiesta di estradizione si è basata soprattutto su una nuova, grande disponibilità francese a collaborare nella repressione a tolleranza zero, ed ha approfittato di un nuovo accordo bilaterale che consente di tenere conto dei termini di prescrizione non del paese richiesto, come è stato sino ad ora in tutte le Convenzioni d’estradizione, ma del paese richiedente. E in Germania i termini di prescrizione per reati con uso di esplosivo sono stati aumentati a 40 anni, mentre in Francia, come si è visto, tutti i reati di cui sono accusati Sonja e Christian sono ormai prescritti. Con l’istituto della prescrizione lo Stato sancisce un termine temporale oltre il quale esso rinuncia a perseguire e punire un reato. Il trascorrere del tempo assume dunque il ruolo di recidere definitivamente il legame tra reato e pena. Tra le ragioni che fondano la memoria giudiziaria come limitata nel tempo -e inevitabilmente seguita dall’oblio giudiziario- spiccano due orientamenti: uno è di prospettiva garantista, che vede la prescrizione come una forma di tutela del cittadino dall’ingerenza dello Stato (senza necessariamente esplicitare un diritto soggettivo alla prescrizione); un altro è di ordine utilitaristico, che vede nel lungo trascorrere del tempo la perdita dell’interesse dello Stato a punire, stante che non può più invocare la necessità di integrare l’ordine pubblico turbato dal reato.
Sul piano che il diritto chiama di ‘prevenzione speciale’, si considera che il tempo, incidendo anche sulla natura psichica della persona, la trasformi, sicché la pena che arrivi tardi, quando il legame tra autore e fatto è ormai dissolto, colpirà un individuo ormai diverso, sul quale non avrà alcun effetto rieducativo. Una punizione tardiva rispetto al reato, priva d’una ragione di essere, non può che apparire una vendetta.
Salvo che la concezione della pena come controllo sociale non necessiti di un ‘esempio’, del monito ‘puniremo sempre e comunque ogni atto di ribellione sociale’: una scelta integralmente politica che non ha più nulla a che vedere con considerazioni giuridiche.
La prescrizione, che costituisce una rinuncia preventiva al potere repressivo dello Stato, non esiste nei paesi anglosassoni ordinati secondo la ‘common law’. La loro memoria giudiziaria è in questo senso assoluta e senza fine. L’oblio lì interviene prima, poiché essi conoscono la discrezionalità dell’azione penale, che pure permette la rinuncia preventiva alla repressione. Gli USA hanno così chiesto ed ottenuto l’arresto estradizionale, in Svizzera, del regista franco-polacco Roman Polanski, per il reato di rapporti sessuali illeciti con una minorenne.Per l’ordinamento svizzero, il reato è largamente prescritto, ma la Confederazione si è pecorescamente sottomessa ad un accordo bilaterale con gli Stati Uniti che fa prevalere la legge statunitense, e dovrà estradarlo.
Che c’entra, è presto detto.
Il Presidente francese Nicolas Sarkozy, che deve autorizzare la consegna di Sonja e Christian, ha pubblicamente protestato contro l’arresto estradizionale di Polanski, scandalizzandosi del fatto che il giudizio venga dopo 32 anni, quando ormai l’interessato ne ha 76. Ne ha parlato in un’intervista a Le Figaro il 15.10.09, poi Le Monde del 27.10.09 ha messo in relazione la su affermazione con il caso di Sonja Suder e Christian Gauger. L’articolo di Le Monde sul caso ripete però un luogo comune che non corrisponde alla realtà storica, poiché dice che le Cellule Rivoluzionarie erano “un’organizzazione vicina alla Rote Armee Fraktion”, mentre in realtà le due formazioni non avevano legami, né organizzativi né politici. Ma erano senz’altro assai poco conosciute fuori dalla Germania. In un riquadro, Le Monde segnalava ancora che era in preparazione una lettera a Sarkozy. Ora è stata fatta e gli è stata inviata. Eccola.
Lettera aperta indirizzata al Presidente della Repubblica da alcune persone senza qualità né titoli particolari
Signor Presidente della Repubblica,
Lei ha affermato, a proposito dell’affare Polanski: “Pronunciarsi trentadue anni dopo i fatti, ora che l’interessato ha settantasei anni, non è buona amministrazione della giustizia” (Le Figaro del 16.10.2009). In questo enunciato Lei non ha espresso una semplice opinione, ma ha invece richiamato un principio fondamentale del diritto, evocando la necessità imperativa di limiti temporali all’esercizio della giustizia penale, principio affermato ‘in dottrina, norma e giurisprudenza’. Senza il quale, una giustizia che si pretendesse ‘infinita’ diverrebbe una teologia della vendetta.
Sul caso che è all’origine della Sua essenziale messa a punto, è stato scritto, Signor Presidente: “esiste un solo argomento a favore di Polanski, ma decisivo: il tempo…”.
Già il diritto romano considerava che il trascorrere dei decenni estingue progressivamente la turbativa provocata dall’atto originario, “e ciò traduce, in tutte le culture, un più alto principio di civiltà”. Se ci si attiene a questo principio, nessun privilegio quindi, per chicchessia, soltanto ‘una difesa logica, generale, uguale per tutti’.
Converrà, Signor Presidente che evocarlo in un caso per derogarne in seguito l’applicazione in un altro caso sarebbe peggio ancora che ignorarlo.
Orbene, nel momento stesso in cui Lei rilasciava questa dichiarazione, due cittadini tedeschi, Sonja Suder e Christian Gauger, rispettivamente di settantasei e sessantotto anni di età, si vedevano notificare un decreto di estradizione in forza di accuse risalenti a più di trent’anni e riguardanti fatti a carattere politico, sopravvenuti nel contesto dei movimenti sociali radicali degli anni settanta in Germania.ScrivendoLe, signor Presidente, ci siamo fatti divieto di far valere come argomenti i nostri affetti e i nostri specifici giudizi di valore sui contesti storici e sociali e a fortiori sulle persone: ci siamo imposti di attenerci qui alla sola lettera del diritto.
Con questa decisione che spetta esclusivamente all’esecutivo, lo Stato di cui Lei è il primo magistrato, potrebbe a termine consegnare alla giustizia tedesca due persone in vista di un processo che si svolgerebbe ben al di là dei ‘termini ragionevoli’ richiesti per un ‘processo equo’.
L’estradizione di Sonja Suder e Christian Gauger significherebbe comunque consegnarli a una lunga detenzione preventiva, dal momento che in forza delle disposizioni in vigore in Germania, rimangono pur sempre degli imputati in attesa di giudizio. Ci sembra inoltre importante ricordare che quest’uomo e questa donna hanno già sofferto di questa ‘giustizia che non rinuncia mai’.
Nel 2001 infatti, la Sezione istruttoria della Corte d’Appello di Parigi li ha dichiarati non estradabili poiché la Germania imputava loro fatti prescritti in diritto francese. Ciononostante, questa stessa sezione li ha giudicati estradabili per gli stessi fatti, sulla base della Convenzione di Dublino, appena introdotta, secondo la quale i dispositivi di prescrizione che governano l’estradizione sono ormai quelli del paese richiedente. Orbene, l’applicazione di questa convenzione al caso di Sonja Suder e Christian Gauger calpesta due principi essenziali dei diritto: ‘l’autorità della cosa giudicata’ e il carattere non retroattivo dei testi repressivi allorché essi aggravano la situazione degli imputati.
Non possiamo credere, signor Presidente, che Lei non applicherà a queste due persone il criterio che ha pubblicamente difeso. Tanto più che esse rientrano pienamente nella ‘clausola umanitaria’ prevista dai testi internazionali. Non fosse che per questi due motivi, s’impone l’annullamento dei decreti di estradizione nei confronti di Sonja Suder e Christian Gauger.
Ci sembra inoltre signor Presidente che da questo principio di ‘civiltà giuridica’ che la Francia rivendica, derivi inoltre la decisione di non procedere a nessuna estradizione per fatti risalenti a più di un quarto di secolo.
Ecco quello che volevamo dirLe signor Presidente, noi che siamo oggi inquieti per le minacce che pesano sulla vita di Sonia Suder e Christian Gauger.
La ringraziamo dell’attenzione che vorrà riservare al nostro appello.Parigi, 5 novembre 2009
Jean-Michel Arberet
Emmannuelle Bastid
Jean-Pierre Bastid
Claire Blain-Cramer
Gilles Berard
François Chouquet
Guido Cuccolo
Claudio Di Giambattista
Aitor Fernández-Pacheco
Claudio Ielmini
Mouloud Kaced
Janie Lacoste
Ezio La Penna
Lucia Martini-Scalzone
Elda Necchi
Isabelle Parion
Claudine Romeo
Luigi Rosati-Elongui
May Sanchez
Oreste Scalzone
Gianni Stefan
Hanlor Tardieu …
L’indirizzo email per sottoscrivere la lettera è: contact[at]stopextraditions.info
Sito per Sonja e Christian
L’odio per gli anni ’70 e la retorica dei “calli”
C’è una categoria di questo blog a cui tengo molto.
E’ quella dedicata ai compagni uccisi, una sezione aggiornata costantemente (purtroppo la lista è lunga ed io sono lenta) con pagine di ricordo che hanno come fonte principale gli “Sguardi Ritrovati”, secondo volume del Progetto Memoria (Ed. Sensibili alle Foglie), dedicato a tutti i compagni che hanno perso la vita durante azioni armate.
Io amo ricordare anche loro. Tra i miei morti, quelli che sento parte della mia storia, c’è tutta quella generazione di operai e di sfruttati, di studenti e proletari che scelsero di provarci con le armi a sovvertire questo paese.
Una di queste pagine è dedicata a Margherita Cagol, tra le fondatrici delle Brigate Rosse, uccisa dai carabinieri di Dalla Chiesa in uno scontro a fuoco durante il sequestro Gancia, in una cascina delle langhe piemontesi.
Pochi giorni fa il signor Piep Piper, così si è firmato, m’ha lasciato un commento che m’ha particolarmente irritato…
commento che per un po’ ho lasciato a marcire, in sospeso. Il tono è di quelli da vecchio comunista del P.C.I., di quelli che denunciavano gli operai dentro le fabbriche; in più mi accusa della mia età, divertentissimo!
Ora l’ho approvato ed è stato decorato meravigliosamente da una risposta a firma di Paolo Persichetti che sento di sottoscrivere in tono e con sommo piacere … quindi vi riposto qui questo allegro dibattito…
Se volete, i microfoni sono aperti: questo il link del vecchio post.
Piep Piper: ” Vedo con raccapriccio che la demenza ideologica mascherata da poesia libertaria fa ancora proseliti, anche tra chi, essendo nata nel 1982, di quello che sono stati i sanguinosi anni 70′, probabilmente ha solo leggiucchiato in piena era già berlusconiana. Si vergogni, la Cagol era solo una potenziale assassina, allo stesso livello di quelli che diceva di combattere. Noi comunisti veri, coi calli sulle mani, ce ne abbiamo le palle piene di voi, poeti borghesi della libertà col mitra in mano. Chi spara non ha mai ragione, si rilegga (se mai l’ha letto) Socrate, Gandhi, Pasolini e anche Paperino.”
Paolo Persichetti:
Commendator Piep Piper,
Di sicuro gli unici calli che lei conosce sono quelli che crescono tra l’indice e il medio, notoriamente i calli della spia, come quelle che negli anni 70 denunciavano gli operai insubordinati, i quadri di lotta più combattivi, i militanti che nei quartieri portavano avanti le battaglie sociali e che davano fastidio al suo Pci coinvolto nella politica di solidarietà nazionale, nel compromesso storico, nella strategia dell’austerità che chiedeva alla classe operaia di lavorare di più e rinunciare agli aumenti salariali. Eravate i maggiordomi della Fiat, gli informatori delle questure, stilavate liste di sospetti che poi portavate a Dalla Chiesa e ai vostri magistrati, come Caselli.
Voi siete quelli del muro di Berlino, di una concezione del socialismo che pensava di organizzare la società come una caserma. Quel tipo di socialismo che irrideva Brecht quando ricordava il discorso del segretario dei comunisti di Berlino, che davanti ad una piazza di operai in protesta non chiedeva le dimissioni del comitato centrale ma quelle del popolo. Lei è della stessa pasta dei Severino Galante, dei Luciano Violante. Uomini dell’ordine statale, legalitari, amate le toghe non le tute blu. Pensate che la società debba essere un tribunale.
Nei posti di lavoro e nei quartieri avete preso il posto delle Digos e dimenticato persino l’azione sindacale. La lotta di classe non la praticavate più da tempo con la vostra ideologia del patto tra produttori. Da classe operaia dentro lo Stato, siete diventati un pezzo di Stato dentro la classe operaia.
Grazie ai “sanguinosi anni 70”, come lei li chiama con consumata prosa berlusconiana-girotondina (rovesci della stessa medaglia), abbiamo avuto per un paio di decenni la scuola di massa, il diritto allo studio per tutti, l’accesso alle università senza più criteri di classe (così i figli di operai e dei contadini sono potuti diventare avvocati o medici), il divorzio, l’aborto, il nuovo diritto di famiglia, la chiusura dei manicomi, la riforma carceraria, il diritto all’assistenza sanitaria, il miglioramento e l’estensione delle pensioni, il punto unico di scala mobile, conquiste salariali e normative sul diritto del lavoro, un abbozzo di Stato sociale prima inesistente, e altro ancora.
Tutte cose smantellate a partire dagli anni 80, grazie a gente come lei. Per quelli come la Cagol, era ancora troppo poco. Ma senza gente come lei tutto questo non ci sarebbe stato.
Quello che lei scrive mi fa pensare ad una frase di Socrate: “Più gente conosco, e più apprezzo il mio cane.”
Forse farebbe bene a seguire anche il consiglio che Gandhi dava quando incontrava tipi come lei: “Dobbiamo fare il miglior uso possibile del tempo libero”, aggiungo, invece di scrivere stronzate a commento dei post altrui che non gradisce.
Pasolini se lo tenga pure. Lei è di quelli che ama di certo la poesia in cui si sbrodolava per i poliziotti del 68. Criticava la modernità capitalista perché era un nostalgico dell’evo rurale. Ha scritto anche cose giuste, come spesso accade ai più lucidi reazionari.
Paperino? Certo che adoriamo Paperino.
Lei invece è di quelli che si identificano con Topolino, e forse ancora di più con Gastone. Viva il papero proletario che rifiuta il lavoro, che non vuole morire in fabbrica e cerca di strappare qualche dollaro a quel taccagno di suo zio. Nella paperopli degli anni 70, lei invece sarebbe stato uno di quelli arruolati in difesa del suo forziere. Oggi invece è con quelli che concepiscono la politica unicamente come uno scontro tra Rockerduck-Berlusconi e Debenedetti-Paperon de Paperoni.
Viva il papero proletario che rifiuta il lavoro, che non vuole morire in fabbrica e cerca di strappare qualche dollaro a quel taccagno di suo zio. Nella paperopli degli anni 70, lei invece sarebbe stato uno di quelli arruolati in difesa del suo forziere. Oggi invece è con quelli che concepiscono la politica unicamente come uno scontro tra Rockerduck-Berlusconi e Debenedetti-Paperon de Paperoni.
Si vede che ha letto per troppo tempo Tex Willer e Zagor. Un po’ di Gruppo Tnt e di Mafalda le avrebbe allargato il cervello.
È dai fumetti che uno legge da bambino che si vede poi cosa diventerà da grande.
A Claudio Pallone, ucciso dalla polizia
CLAUDIO PALLONE
– Claudio Ernesto Pallone nasce in Argentina, il 2 novembre 1954
– Frequenta le scuole a Roma, si iscrive all’università
– Lavora come correttore di bozze
– Viene arrestato nel maggio 1977 ed esce dopo alcuni mesi
– milita nel Movimento Comunista Rivoluzionario
– Viene ucciso dalla polizia a San Donato Val Comino (FR), il 13 novembre 1980, insieme ad Arnaldo Genoino, ferito mortalmente, che morirà in ospedale
– Archivio Progetto Memoria, Note sul percorso politico
“Claudio Ernesto Pallone cresce alla Garbatella, con i collettivi Politici Studenteschi del suo liceo. Fra le sue prime esperienze di militanza nel Gruppo Comunista della Garbatella, formazione di quartiere che, nei primi anni ’70, confluisce nel Gruppo Gramsci. Con lo scioglimento del Gramsci (1973) milita nell’area dell’autonomia romana; partecipa alla vita del foglio trasversale Zut; si iscrive, in quanto disoccupato, alla lista di collocamento per entrare al Policlinico ed è presente a tutte le manifestazioni, partecipando molto attivamente al movimento dell’autonomia. Nel marzo 1977 partecipa alla manifestazione dell’università che culmina con la cacciata di Lama. Nel maggio 1977 viene arrestato, in seguito ad un attentato conto una caserma PS nel quartiere Garbatella, dopo gli scontri con le forze dell’ordine seguite alla morte di Giorgiana Masi. La sua carcerazione dura qualche mese.
Durante il 1978, con altri militanti, da vita ad esperienze armate diffuse sul territorio e variamente denominate. Nel 1979 partecipa al dibattito che da vita al MCR, esperienza entro cui è collocato l’evento che porta alla sua morte.”
Testimonianze al Progetto Memoria
– Vincenzo Sparagna, Roma 1995
“Claudio me lo ricordo come un ragazzo giovane, alto ma non altissimo, magro ma non magrissimo, con una bella cornice di capelli mi pare più rossi che castani, più amaranto che biondi. Aveva due occhi dolci e gentili, di quelli che sanno sorridere con discrezione, facendoti partecipe di un’ironia senza invaderti l’anima, di quelli che sanno annuire o dissentire, ma conservandoti l’affetto anche nel dissenso, come una carezza.
Lavorava, quando lo conobbi, come correttore di bozze al Male. […] Veniva una mattina alla settimana in tipografia (la mattina della chiusura del numero) e correggeva le bozze che si preparavano nella tipografia “15 giugno” su delle antiquate Linotypes. C’era l’odore del piombo fuso, il ticchettio delle macchine e Claudio stava ore, chino sulle bozze, mentre magari io e altri lavoravamo con Franco Circosta, l’indimenticabile 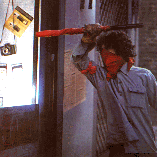 ‘roccia’, al montaggio delle pagine… fino a notte fonda, talvolta le quattro del mattino del giorno dopo.
‘roccia’, al montaggio delle pagine… fino a notte fonda, talvolta le quattro del mattino del giorno dopo.
Talvolta Claudio andava via dopo aver visto le ultime bozze, talvolta restava a guardarci lavorare e dare una mano fino a tardi, quasi in silenzio sempre, ma anche presente, premuroso, gentile.
Poi, una mattina, Claudio non venne. C’era il sole, erano già le undici, poi le dodici, mi trovavo ad aspettarlo dalle dieci. Ormai ero arrabbiato, mi toccava correggere tutte le bozze, ricorreggere le pagine, tutto procedeva più lentamente. “Che cavolo combina Claudio?” La giornata finì e il numero venne montato. Di Claudio nessuna notizia.
Solo il giorno dopo venimmo a sapere che era morto, ucciso sul ciglio di una strada, dopo un tentativo di rapina, militante clandestino di qualcosa, le “Brigate Rosse”, le “Unità Combattenti”, i “Proletari contro il destino” poco importava.
Mi restava questo vuoto nello stomaco, questa angoscia in cuore, l’impossibile, eppur realissimo, collage tra il silenzioso Claudio dai capelli rossi, il gentile, mite, attento e puntuale correttore di bozze, forse studente, forse lavoratore autodidatta e il suo “doppio” drammatico, armato di determinazione, nel rischio consapevole e praticamente quotidiano della morte.
Forse un “inutile” simbolo in più del dramma della nostra generazione di fronte all’abisso della fine della storia. Oppure solo un giovane dagli occhi dolci, troppo caro agli Dèi”.
Tratto da “Sguardi Ritrovati”, vol. 2 del Progetto Memoria. Edizione Sensibili alle Foglie
Battisti, Genro: L’italia è stata arrogante e autoritaria
Intervista al ministro della Giustizia brasiliano
di Paolo Persichetti, Liberazione 14 Novembre 2009
Il supremo tribunale brasiliano si è spaccato in due come un cocomero. Quattro giudici hanno ritenuto l’asilo politico concesso a Cesare Battisti dal ministro della Giustizia, Tarso Genro, <corretta sotto il profilo costituzionale>.
 Hanno poi respinto la richiesta di estradizione avanzata dall’Italia perché i reati contestati «hanno una natura politica» che cade sotto la protezione della legge brasiliana e dei trattati internazionali ratificati dal loro Paese. Altri quattro giudici, con argomenti esattamente opposti, si sono pronunciati per il via libera alla estradizione. Questa cristallizzazione, come da più parti si è osservato, palesa in modo eclatante uno scontro istituzionale molto duro. In ballo c’è l’interpretazione della costituzione brasiliana e soprattutto quale debba essere la gerarchia dei poteri in materia estradizionale. Decide e prevale, in ultima istanza, il potere politico, dunque l’Esecutivo, come accade in tutti i Paesi del mondo, compresa l’Italia, oppure deve essere il Giudiziario a dire l’ultima parola?
Hanno poi respinto la richiesta di estradizione avanzata dall’Italia perché i reati contestati «hanno una natura politica» che cade sotto la protezione della legge brasiliana e dei trattati internazionali ratificati dal loro Paese. Altri quattro giudici, con argomenti esattamente opposti, si sono pronunciati per il via libera alla estradizione. Questa cristallizzazione, come da più parti si è osservato, palesa in modo eclatante uno scontro istituzionale molto duro. In ballo c’è l’interpretazione della costituzione brasiliana e soprattutto quale debba essere la gerarchia dei poteri in materia estradizionale. Decide e prevale, in ultima istanza, il potere politico, dunque l’Esecutivo, come accade in tutti i Paesi del mondo, compresa l’Italia, oppure deve essere il Giudiziario a dire l’ultima parola?
Attorno alla battaglia giuridico-politica che si è tenuta fino ad ora nelle aule di giustizia brasiliane, la destra – oggi all’opposizione – alleata con una parte significativa della magistratura, sta tentando un assalto al potere politico legittimamente eletto, rappresentato dal presidente della repubblica Ignazio Lula da Silva. Uno scenario esattamente rovesciato rispetto a quello italiano. Il nostro governo, che per voce del suo premier raglia contro i «magistrati comunisti», non esita oltre oceano a costruire trame di corridoio con pezzi di magistratura per strappare con ogni mezzo l’estradizione di Battisti, dando una mano ai suoi amici della destra brasiliana per fare fuori Lula.
Degli scenari che si aprono dopo la situazione di stallo, venuta a crearsi tra i giudici della Supremo tribunale federale di Brasilia, abbiamo parlato con il ministro della Giustizia brasiliana, Tarso Genro.
Ministro, cosa accadrà ora? Il presidente del Stf, Gilmar Mendes, voterà oppure come accaduto in altre occasioni, rispetterà il principio dell’habeas corpus?
Ha dichiarato che voterà.
Ha idea di come si pronuncerà?
È un’incognita perché ad oggi non ha ancora avuto l’opportunità di presentare pubblicamente la sua posizione.
È vero, come alcuni quotidiani hanno scritto, che se il Presidente Lula non ratificherà l’eventuale voto favorevole alla estradizione di Battisti, si potrebbe aprire una procedura di impeachment contro di lui?
Impossibile. Dietro questo scenario c’è una concezione completamente distorta della costituzione brasiliana. Le decisioni del Supremo tribunale sulla concessione dell’asilo non hanno forza di legge. Sono pareri privi di effetto vincolante. La decisione finale è riservata dalla costituzione al Presidente della repubblica. Se il voto finale del Supremo tribunale dovesse pendere per l’estradizione, la decisione passerà nelle mani del Presidente della repubblica. Decisione che comunque si farebbe attendere perché sul capo del signor Battisti pesa un procedimento penale per possesso e falsificazione di documenti d’identità. Per questo, quale che sia il risultato finale del voto, non vi può essere nessuna immediatezza della estradizione prima che non sia concluso il processo.
Eppure, in una dichiarazione il Presidente del Stf, ha evocato chiaramente il rischio di un impeachment (procedura di rimozione) contro Lula, se questi non si atterrà all’esito della decisione della Suprema corte.
Questa dichiarazione non l’ho mai letta da nessuna parte, mi è stata solo riferita. Se fosse vera, sarebbe espressione di una concezione profondamente sbagliata del sistema legale, dell’equilibrio e della divisione che presiede alle diverse competenze tra potere esecutivo e giudiziario.
Ministro, secondo lei perché Toffoli (il giudice nominato in sostituzione di un suo collega scomparso Ndr) non ha votato?
Non lo so. Ha parlato di un problema di coscienza, ma non saprei dire esattamente quale sia la ragione personale che gli ha impedito di esprimere il voto.
Forse perché ci sono state pressioni da parte italiana?
Pressioni da parte dell’Italia ci sono state fin dall’inizio.
Secondo lei si è andati ben oltre la legittima difesa dei propri interessi, fino alla vera e propria ingerenza negli affari interni?
Sì, da parte di persone appartenenti al governo italiano. Pressioni totalmente inaccetabili dal punto di vista politico e giuridico. In questa vicenda l’Italia ha dimostrato di avere una visione autoritaria e arrogante, inaccettabile per un paese democratico.
Un film su Prima Linea
Anche qui passo direttamente al ritrasmettere qualcosa di non mio.
Prendo dal blog Insorgenze (tanto pe’ cambià) un pezzo sul film appena uscito tratto dal libro di Segio (“Miccia Corta”).
Poi, una serie di link su questo personaggio, sempre provenienti dallo stesso blog
Una storia di Prima linea
Il film girato da Nicola De Maria di cui non avevamo bisogno
Ora Sergio Segio si dissocia (come sempre nel suo stile) dal film che ha ispirato col suo libro, vendendo i diritti d’autore
 Con uno stile che a tratti cerca di imitare la moda gauchiste del noir, Segio narra in forma d’epopea l’evasione organizzata, il 3 gennaio 1982, dal carcere di Rovigo. In realtà il testo è un pastiche di generi diversi: si apre con una lunga introduzione “precauzionale” (non sia mai che il magistrato di sorveglianza si arrabbi), nella quale si avverte il lettore che i fatti raccontati non implicano il tragitto successivo del protagonista, ravvedutosi ampiamente delle sue gesta precedenti.
Con uno stile che a tratti cerca di imitare la moda gauchiste del noir, Segio narra in forma d’epopea l’evasione organizzata, il 3 gennaio 1982, dal carcere di Rovigo. In realtà il testo è un pastiche di generi diversi: si apre con una lunga introduzione “precauzionale” (non sia mai che il magistrato di sorveglianza si arrabbi), nella quale si avverte il lettore che i fatti raccontati non implicano il tragitto successivo del protagonista, ravvedutosi ampiamente delle sue gesta precedenti.
Dopo aver recitato la penitenza iniziale, l’autore finalmente si avventura nel racconto dell’assalto portato alle mura del carcere. Episodio narrato, almeno nelle intenzioni iniziali, col punto di vista di chi vorrebbe riprodurre parole, sentimenti, emozioni dell’epoca; quelle integrali e genuine, non quelle filtrate e deformate dalla memoria. In realtà, l’artificio letterario ricercato non riesce. La sequenza della giornata è intercalata da lunghi e noiosi intermezzi che diventano veri e propri excursus sulla nascita e la storia di Prima Linea, proposti dall’io narrante insieme ad altre riflessioni e considerazioni che svariano nel tempo, celando malamente il senno (?!) del poi spacciato per l’avvedutezza del prima.
Ove mai nel frattempo qualcuno avesse frainteso le intenzioni di un racconto fin troppo compiaciuto sull’evasione, o l’incedere minuzioso di lunghi passaggi sulle armamento, i vari calibri ben oliati, le loro caratteristiche, gli usi possibili e consigliabili (che disvelano il fanatismo ultramilitarista e stalinoide del personaggio che non mancò di processare e uccidere un suo compagno, William Vaccher, accusato di aver fato alcune ammissioni davanti ai carabinieri), nonché i riferimenti alle marche di champagne e ristoranti alla moda che sembrano anticipare gli anni della Milano de bere, il volume si conclude con un apparato di lettere e articoli che descrivono il percorso politico successivo alla cattura, per ricordare l’esperienza carceraria che condusse alla creazione delle «aree omogenee», al mutato giudizio sul passato, a quell’autocritica degli altri che prese il nome di «dissociazione della lotta armata».
Nonostante, in quel 1982, Segio avesse maturato la convinzione del fallimento della lotta armata, egli si racconta avvinto da un ineluttabile destino: «non c’è salvezza possibile per chi ha sognato di cambiare il mondo». Inanellando una serie impressionate di goffe citazioni scapigliate, fa torto a quella generazione che gli fu accanto nel lottare e che trascina nel «novero dei destinati alla sconfitta, che non scelgono l’esilio ma di andare sino in fondo, pagando quel che bisogna pagare al sogno a lungo coltivato».
Come immerso nella recita di un consunto copione dannunziano, raffigura se stesso e i suoi compagni avvolti in un’atmosfera d’estetismo combattente, «anime capaci di tenerezza» che sceglievano «di morire non nella lenta emorragia della vita ma di fretta, senza risparmio, come candele accese dai due lati[…] non per malattia del corpo ma per quella della coerenza, per un’inguaribile infezione dell’anima». Poeti armati, esercito scapigliato, tribù del “mucchio selvaggio”, novelli sturm und drang del settantasette nostrano, sognatori impazienti, adepti del carpe diem. «I nostri attimi sono eterni e ci ripagano di tutto», quelli del nonostante tutto, fiori appassiti più che fiori del male, maledetti mancati ma redenti riusciti.
Le parole incedono al rimirar la poesia del gesto, la metrica dell’intenzione che conduceva ad un eroico «andar incontro alla bella morte» di saloina memoria. A metà tra l’imitazione di Marinetti e quella del Vittoriale, non manca persino il lieto fine holliwoodiano che condanna i protagonisti a vivere finalmente ravveduti e contenti. Al di là di tutto, il libro una sua utilità la conserva comunque, poiché consente di comprendere meglio l’intimità corrotta della dissociazione e dei suoi personaggi di maggiore spicco, i suoi aspetti reconditi, un certo malanimo, la molta falsa coscienza.
Esemplare il risentimento schiumoso verso quei militanti che hanno sempre criticato il modello dissociativo. Forse è la prima volta che uno dei maggiori esponenti di quel movimento-istituzione, che fu appunto la dissociazione della lotta armata, affronta apertamente un tentativo di ricostruzione di quel percorso.
Il tentativo c’è stato. La ricostruzione un po’ meno. La storia può attendere. Il film fa schifo
Link
L’esportazione della colpa (1)
Sergio Segio: “Scalzone e i parigini condannino la lotta armata” (2)
“Segio ha dimostrato solo di avere ancora molte cambiali da pagare per la sua libertà” (3)
“Monsieur de la calomnie” (4)
Scalzone: “Caro Segio, non c’ è nulla da cui mi devo dissociare” (5)
Sergio Segio, ovvero chi frequenta l’infamia (6)
Segio e la reinvenzione del passato (7)
Cesare Battisti: ultima udienza in corso…
 Dias Toffoli, giudice appena nominato al Supremo Tribunal Federal di Brasilia, ha formalmente annunciato che non prenderà parte alle votazioni che si terranno oggi e che decideranno se estradare o no Cesare Battisti. Come avvocato generale di stato si era espresso a favore della concessione di status di rifugiato politico concesso dal governo brasiliano; per questo precedente non voterà.
Dias Toffoli, giudice appena nominato al Supremo Tribunal Federal di Brasilia, ha formalmente annunciato che non prenderà parte alle votazioni che si terranno oggi e che decideranno se estradare o no Cesare Battisti. Come avvocato generale di stato si era espresso a favore della concessione di status di rifugiato politico concesso dal governo brasiliano; per questo precedente non voterà.
Senza il suo voto, il pronostico non è certo favorevole per l’ex militante dei PAC che in Italia dovrebbe scontare l’ergastolo.
L’udienza è in corso da meno di un’ora; l’intenzione di alcuni membri del tribunale è di bypassare completamente il presidente brasiliano Lula, che dovrebbe comunque avere l’ultima parola.Durante l’udienza il ministro giudice Cezar Peluso, ha dichiarato che Lula dovrebbe automaticamente inviare l’imputato verso le prigioni italiane.
Il procuratore generale Roberto Gurgel, tra i tanti, sostiene invece che Lula come capo di stato e del governo, responsabile delle relazioni internazionali in Brasile e garante della Costituzione, abbia il diritto di decidere se estradare o no Cesare Battisti in Italia.
Tra poco si saprà qualcosa…
Intervista a Tarso Genro sull’asilo politico a Cesare Battisti
«Anni 70 in Italia, giustizia d’eccezione non fascismo»
di Paolo Persichetti, Liberazione 11 ottobre 2009
 Quando nel gennaio scorso il ministro della Giustizia brasiliana, Tarso Genro, concesse l’asilo politico a Cesare Battisti, una reazione carica di astio coprì la sua decisione. Dai vertici istituzionali, sui media, dalla magistratura, senza mai veramente controargomentare vennero risposte spesso fuori dalle righe. Addirittura nel corso di una cerimonia, il ministro della Difesa Ignazio La Russa, rivolto carabinieri, disse: «se ci potesse essere un gruppetto che vuole andare in Brasile…». Oggi, per la prima volta, il guardasigilli brasiliano si spiega su un quotidiano italiano. Lo fa estesamente e con molta pacatezza. Evita le riposte polemiche. Tempo fa, Armando Spataro, il pm milanese che condusse l’inchiesta contro i Pac, noto per essere uno dei cuori di pietra dell’emergenza, domandò ai giudici brasiliani di «decidere col cuore». In Brasile, a leggere questa intervista, pare che continuino a preferire il Diritto, la Filosofia, la Storia.
Quando nel gennaio scorso il ministro della Giustizia brasiliana, Tarso Genro, concesse l’asilo politico a Cesare Battisti, una reazione carica di astio coprì la sua decisione. Dai vertici istituzionali, sui media, dalla magistratura, senza mai veramente controargomentare vennero risposte spesso fuori dalle righe. Addirittura nel corso di una cerimonia, il ministro della Difesa Ignazio La Russa, rivolto carabinieri, disse: «se ci potesse essere un gruppetto che vuole andare in Brasile…». Oggi, per la prima volta, il guardasigilli brasiliano si spiega su un quotidiano italiano. Lo fa estesamente e con molta pacatezza. Evita le riposte polemiche. Tempo fa, Armando Spataro, il pm milanese che condusse l’inchiesta contro i Pac, noto per essere uno dei cuori di pietra dell’emergenza, domandò ai giudici brasiliani di «decidere col cuore». In Brasile, a leggere questa intervista, pare che continuino a preferire il Diritto, la Filosofia, la Storia.
Quali sono le fonti giuridiche della sua decisione di concedere l’asilo a Cesare Battisti?
Il Brasile ha sottoscritto la convenzione sullo Statuto dei rifugiati del 1951 e il Protocollo del 1967, che amplia la possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato anche per fatti diversi da quelli accaduti fino al 1951, e legati alla seconda guerra mondiale.
Nella legislazione brasiliana, la mia decisione trova sostegno nella Legge n. 9.474 del 1997, che disciplina il riconoscimento della condizione di rifugiato. Questa legge riconosce l’asilo ad ogni persona che, a causa di fondati timori di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale od opinioni politiche, si trovi fuori dal suo paese di origine e non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese. Sempre secondo questa legge, il ministro della Giustizia è l’istanza di ricorso nella concessioni dell’asilo e la sua decisione è inappellabile.
Inoltre, considerando che la carta delle Nazioni unite e la Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo affermano il principio secondo il quale gli esseri umani senza distinzione alcuna debbano godere dei diritti e delle libertà fondamentali, e che gli stessi principi sono riconosciuti dalla Costituzione brasiliana, ritengo che la mia decisione sia ampiamente fondata.
Nel testo in cui lei concede l’asilo politico cita importanti autori nel campo della filosofia politica e del diritto costituzionale, come Norberto Bobbio, Carl Schmitt, Jurgen Habermas, il sociologo Laurent Mucchielli. Si dilunga con un’analisi molto dettagliata sulla particolare natura dello stato d’eccezione che è venuto a crearsi. Una disamina che assomiglia, per taluni aspetti, alle analisi condotte dall’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel 1991, quando avviò la procedura di grazia (poi bloccata) a Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate rosse. Gran parte delle obiezioni che si sono levate contro le sue argomentazioni riguardano i passaggi sui «poteri occulti», citazione di Norberto Bobbio. I suoi argomenti, tutt’altro che grossolani e affrettati, sono stati stravolti fino ad accusarla di aver definito l’Italia degli anni 70 una dittatura fascista. Può spiegare meglio cosa intendeva?
costituzionale, come Norberto Bobbio, Carl Schmitt, Jurgen Habermas, il sociologo Laurent Mucchielli. Si dilunga con un’analisi molto dettagliata sulla particolare natura dello stato d’eccezione che è venuto a crearsi. Una disamina che assomiglia, per taluni aspetti, alle analisi condotte dall’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel 1991, quando avviò la procedura di grazia (poi bloccata) a Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate rosse. Gran parte delle obiezioni che si sono levate contro le sue argomentazioni riguardano i passaggi sui «poteri occulti», citazione di Norberto Bobbio. I suoi argomenti, tutt’altro che grossolani e affrettati, sono stati stravolti fino ad accusarla di aver definito l’Italia degli anni 70 una dittatura fascista. Può spiegare meglio cosa intendeva?
Non ho mai definito l’Italia degli anni 70 un regime dittatoriale o fascista. I fatti da me richiamati sono pubblici e ampiamente argomentati dagli autori sopracitati. Ho sostenuto invece la legittimità della reazione dello Stato di diritto italiano di fronte ad una situazione storica di rivolta sociale. Quella reazione venneportata avanti applicando le norme giuridiche in vigore all’epoca. Tuttavia è impossibile negare che avvenne anche ricorrendo alla creazione di un regime di eccezioni che ha ridotto le prerogative di difesa degli accusati di sovversione o di azioni violente. L’introduzione del “pentitismo remunerato” è un esempio di queste eccezioni restrittive del diritto di difesa, e, nel caso in questione, fu la base principale della condanna di Cesare Battisti. Inoltre è notorio che i meccanismi di funzionamento dell’eccezione operarono, a quell’epoca, anche fuori dalle regole della stessa eccezionalità prevista dalla legge. Circostanza che suscitò ripercussioni in diversi paesi, anche fuori dall’Europa, che per questo concessero asilo politico ad attivisti italiani, e che spinse organismi internazionali che si occupano dei diritti umani, come Amnesty International e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, a elaborare dei rapporti su quanto accadeva.
La decisione del presidente Lula di nominare il giurista José Antonio Dias Toffoli nuovo giudice del Supremo tribunal federal al posto di Carlos Alberto Menezes Direito, deceduto il primo settembre, ha suscitato polemiche perché considerato vicino al Pt (partito del presidente ndr). Secondo i critici, questa nomina modificherebbe gli equilibri interni al tribunale a ridosso di un voto controverso, come quello sul caso Battisti. E’ vero?
L’indicazione di un nome per ricoprire l’incarico nel Stf suscita sempre polemiche. E’ impossibile che un nome sia gradito a tutti i settori politici. E’ però una prerogativa attribuita dalla Costituzione al Presidente della Repubblica. Lo stesso presidente del Stf, Gilmar Mendes, ha dichiarato che Toffoli è una persona “qualificata” per divenire componente della Corte, e che ha “un buon dialogo nel tribunale”. L’indicazione attuale non provocherà cambiamenti significativi nell’equilibrio interno della corte. Il Presidente Lula ha già designato in passato 8 ministri del Tribunale, il che non significa che ciò gli permetta una qualsiasi ingerenza nel lavoro del Stf. Perché mai la designazione di Toffoli dovrebbe avere conseguenze diverse dalle precedenti? Anche Menezes Direito era stato designato dal Presidente Lula, eppure allora nessuno sollevava critiche.
 La stampa di destra, riprendendo un’opinione del presidente del Tribunale Gilmar Mendes, ha sostenuto che Toffoli difficilmente potrà votare sul caso Battisti perché non ha assistito fin dall’inizio alla discussione. Cosa dice la legge in proposito?
La stampa di destra, riprendendo un’opinione del presidente del Tribunale Gilmar Mendes, ha sostenuto che Toffoli difficilmente potrà votare sul caso Battisti perché non ha assistito fin dall’inizio alla discussione. Cosa dice la legge in proposito?
Fino alla nomina al Stf Toffoli ha esercitato il ruolo di avvocato generale dell’Unione. Vi potrà essere un impedimento a votare solo sull’eccezione di incostituzionalità, poiché l’Avvocatura generale si è espressa in proposito. Ma nel processo di estradizione non esiste nessun ostacolo alla sua partecipazione.
In caso di parità tra i voti dei Ministri all’interno del Tsf, cosa succede?
Sarà il presidente della corte ad esprimere il voto decisivo.
Secondo il presidente del Tsf, Gilmar Mendes, è il Tribunale e non l’Esecutivo che deve dire l’ultima parola sulla procedura di estradizione. A suo avviso è corretta questa interpretazione? E’ in corso un conflitto istituzionale?
In concreto, l’estradizione rappresenta la proiezione del diritto di punire di uno Stato sul territorio di un altro Stato. Proprio per questo suo costituire un atto di disposizione sulla propria sovranità, si tratta di un fatto politico, e dunque di competenza del capo del potere esecutivo, che è il legittimo rappresentante del paese negli affari internazionali. Ciò non è una novità nel Diritto: né di quello brasiliano, né di quello straniero. Anche l’Italia possiede un sistema simile. Il procedimento esaminato dal Tsf è diviso in due fasi distinte. Una giudiziaria, dove il Tribunale funziona come garante dei diritti individuali della persona richiesta per l’estradizione, e verifica la possibilità giuridica di mandare avanti la procedura di estradizione. E’ una fase di autorizzazione, in cui la decisione è senza dubbio di competenza del tribunale. La decisione finale, invece, è di competenza dell’autorità amministrativa. Conseguenza del potere politico conferito dal voto al suo rappresentante, eletto anche per rappresentare il paese nelle sue relazioni esterne.
Il procuratore generale Antonio Fernando De Souza, che pure nell’aprile 2008 si era detto favorevole all’estradizione di Battisti, a patto che l’Italia commutasse la pena dell’ergastolo a 30 anni, aveva riconosciuto che la concessione dell’asilo estingueva la procedura d’estradizione. Il presidente del Tsf, Gilmar Mendes, ha ritenuto il contrario. Esiste una diversità di vedute anche all’interno del mondo giudiziario?
Nel mondo giuridico ci saranno sempre divergenze interpretative. Tuttavia la posizione del Procuratore generale non è una interpretazione isolata.Corrisponde al giudizio dei più capaci giuristi del nostro paese e fa parte della tradizione giuridica del nostro paese. Ciò che sorprende. in questo caso, è l’incompatibilità tra questa decisione e la giurisprudenza precedente del Stf. Ad esempio, nel caso Medina (esponente delle Farc), dove la richiesta di estradizione da parte del governo colombiano venne estinta dalla concessione dell’asilo.
Se, come ha detto il relatore Cesar Peluso nella sua requisitoria, la legge del 1997, che attribuisce al potere politico il compito di concedere l’asilo politico, è corretta, perché la corte pretende di sindacare nel merito della singola concessione?
La verifica di merito da parte di un altro potere costituisce senz’altro un danno al regime costituzionale della separazione dei poteri.
In Brasile, la vicenda Battisti non corre il rischio di favorire un’offensiva del potere giudiziario contro quello politico-elettivo? In Italia, la supplenza giudiziaria concessa dal potere politico alla magistratura sul finire degli anni 70, per combattere la sovversione politica della sinistra armata, si è poi trasformata in una “interferenza” teorizzata dagli stessi giudici, autoinvestitisi “nuovo soggetto” politico negli anni 90, fino a paventare scenari di «democrazia giudiziaria», di «repubblica penale», per dirla con Antoine Garapon. C’è il rischio che in Brasile si arrivi ad uno scenario simile?
La Costituzione del 1988 garantisce un ampio ricorso al potere giudiziario. La giudiziarizzazione è un fenomeno interessante perché promuove un ampio dibattito pubblico su temi importanti. Ovviamente c’è sempre il rischio di cadere in una giudiziarizzazione della politica, cosa che non sarebbe salutare. Però non credo che questo processo sia in corso. Il Brasile è una democrazia recente, e ancora in fase di maturazione, ma avanziamo rapidamente nel consolidamento delle nostre istituzioni.
Poche ore alla sentenza Battisti
 Si è aperto poche ore fa il dibattimento sul caso Cesare Battisti a Brasilia, di fronte al Supremo Tribunale del Brasile (STF) che dee pronunciarsi sul ricorso presentato dall’Italia contro la concessione dell’asilo politico all’ex militante dei PAC (proletari armati per il comunismo) per cui è stata invece chiesta l’estradizione. Cesare non è presente in aula, al contrario di un rappresentante del ministero di Grazia e Giustizia italiano, Italo Ormanni e l’ambasciatore italiano a Brasilia Gherardo La Francesca.
Si è aperto poche ore fa il dibattimento sul caso Cesare Battisti a Brasilia, di fronte al Supremo Tribunale del Brasile (STF) che dee pronunciarsi sul ricorso presentato dall’Italia contro la concessione dell’asilo politico all’ex militante dei PAC (proletari armati per il comunismo) per cui è stata invece chiesta l’estradizione. Cesare non è presente in aula, al contrario di un rappresentante del ministero di Grazia e Giustizia italiano, Italo Ormanni e l’ambasciatore italiano a Brasilia Gherardo La Francesca.
Il ministro della giustizia Tarso Gendro ha ribadito questa mattina la sua posizione a riguardo, augurandosi che sia mantenuta la giurisprudenza in vigore, sulla quale lui aveva basato la concessione dell’asilo politico.
Cosa che ci auguriamo tutti… anche il Procuratore generale del Brasile, Roberto Gurgel, ha affermato che la decisione del ministro della Giustizia Genro di concedere l’asilo politico a Battisti «è fondata sulla Costituzione, le leggi e i trattati internazionali».
IN BOCCA AL LUPO!
Per amore della storia…
Sono passati diversi giorni dall’editoriale di Magris sul Corriere della Sera e da alcune risposte comparse su altre testate. Volevo riportare questa di Marco Clementi, comparsa qualche giorno dopo sulle pagine de L’Altro. La libertà di parola, la libertà di fare storia va difesa a denti stretti!
La storia è plurale. La memoria vittimaria rientra nella sfera privata e sembra più vicina alla vendetta che alla giustizia, se usata come rivendicazione
Marco Clementi L’Altro 4 agosto 2009
Un’intera generazione italiana, quella che ha fatto la lotta armata negli anni ‘70 e ‘80, scontate quasi tutte le pene dopo i secoli di carcere con i quali lo Stato l’ha punita, deve tacere. Questo, se non ho capito male, è il centro del discorso che sviluppa Claudio Magris sulle pagine del Corriere della Sera del 31 luglio. Lo studioso ammette che il brigatista può recuperare i pieni diritti civili e politici (anche se ciò, una volta scontata la pena, non avviene automaticamente ma bisogna attivare la procedura di “riabilitazione”), può esprimere la sua sulle piattole, se nel frattempo il carcere gli avesse fornito l’istruzione adeguata per farlo, ma non può dire una parola sul suo passato di combattente.  Certo, di fronte ad espressioni come quelle riportate nell’articolo e attribuite al militante di Prima Linea Sergio Segio – giustamente definite «pappa del cuore, vecchio vizio retorico italiano, posta sentimentale rosa vicina al rosso sangue versato» -, consiglierei al suo autore di tacere, ma non si vede perché tale raccomandazione debba essere estesa a tutti gli altri. In letteratura, come nel processo penale, la responsabilità è personale.
Certo, di fronte ad espressioni come quelle riportate nell’articolo e attribuite al militante di Prima Linea Sergio Segio – giustamente definite «pappa del cuore, vecchio vizio retorico italiano, posta sentimentale rosa vicina al rosso sangue versato» -, consiglierei al suo autore di tacere, ma non si vede perché tale raccomandazione debba essere estesa a tutti gli altri. In letteratura, come nel processo penale, la responsabilità è personale.
E così, il brigatista è un brigatista, e non un SS, un mafioso, uno stragista impunito. A ognuno il suo, per cominciare. E di brigatisti e brigatismo si deve allora parlare visto l’elenco di alcune delle vittime che fa Magris (non tutte peraltro colpite dalle Brigare rosse) considerate «le figure dell’Italia migliore, quella più libera e aperta e democratica, che avrebbe potuto e dovuto essere diversa da quella di oggi». Come se il motivo per cui oggi siamo qui è perché in Italia c’è stata la lotta armata. Intanto mi sembra uno strano recupero dei diritti quello di chi, riabilitato, può andare a votare per il Parlamento italiano ma non deve dire una parola sugli anni in cui fu protagonista. Da sempre i reduci hanno raccontato della propria guerra. Ma c’è dell’altro.
I brigatisti, primi e unici nella storia di questo paese, scelsero di rivendicare i propri delitti e di assumersene la responsabilità di fronte alla legge, indipendentemente dal loro coinvolgimento concreto. Al punto che molti sono stati condannati all’ergastolo per il sequestro Moro senza essere stati in via Fani, né in via Montalcini, né in via Caetani. Se avessero deciso di difendersi singolarmente, senza dichiararsi rei, la storia giudiziaria delle Br sarebbe andata molto diversamente e le condanne si sarebbero contate con numeri più piccoli. Che dire, poi, delle continue riforme del codice penale per adeguare la legge alla nuova situazione creata in Italia dalla presenza di questo gruppo armato? Tutto ciò induce a pensare che si trattò di una storia politica. Nessuno degli uccisori di allora lo fece per questioni personali; nessuno aveva un “conto aperto” da chiudere. Come ipotizza Magris, «pensava di costruire un’Italia migliore».
E le vittime, mi si dirà? E i parenti delle vittime? Perché è questo, in fondo, il contesto all’interno del quale si chiede, ovvero si impone ai brigatisti di tacere. Ma a quali brigatisti ci si riferisce? Ai pentiti, ai dissociati o ai cosiddetti “irriducibili”?
Le confessioni dei pentiti e quelle dei dissociati sono state qualitativamente differenti: i pentiti hanno offerto parole utili alle tesi dell’accusa in sede processuale (oltre che permesso in casi clamorosi l’arresto di decine di militanti), I dissociati hanno fornito ricostruzioni politiche della propria esperienza militante in linea con quella desiderata dello Stato. Lo hanno fatto molti anni dopo il loro arresto, contribuendo alla sconfitta politica della lotta armata, non a quella militare. A quanto risulta a chi scrive, i pochi ex-militanti della lotta armata che hanno partecipato in modo attivo alla memorialistica appartengono in maggioranza alla  schiera dei cosiddetti pentiti o dissociati. Per quanto concerne, invece, gli irriducibili, essi per lo più tacciono (e spesso i commentatori li accusano proprio per questo!) e anche quando parlano, come nel caso di Mario Moretti con un libro sulle Br per nulla apologetico, si sottolinea quello che non sarebbe stato ancora detto, perché è una verità predeterminata, quella che si vorrebbe ascoltare, non il pensiero di Moretti. Veniamo alla questione delle vittime e dei loro parenti. Il 9 maggio è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo in Italia. Di tutte le vittime, senza distinzione di matrice, tipologia di attentato, obiettivo. Quest’anno, per l’occasione, la vedova Pinelli è stata invitata al Quirinale, dove ha incontrato la vedova Calabresi. L’iperbole è complessa, e va analizzata e spiegata. Da tempo ormai il calendario italiano si è riempito di giorni della memoria e del ricordo e si cerca di far passare l’idea che la memoria abbia una sorta di dignità parallela a quella della storia. Forse perché la memoria appartiene alle vittime, mentre la storia ai vincitori? In realtà non è così. La differenza è un’altra e ben più sostanziale. La memoria appartiene alla sfera privata, mentre la storia è pubblica. La memoria non si può verificare, laddove la storia attende un riscontro da parte della comunità scientifica. La memoria non sostituisce la storia, né si affianca ad essa; offre delle fonti, tutte da vagliare. Per questo, un incontro tra la vedova Pinelli e la vedova Calabresi può avere luogo solo nel giorno della memoria. Perché nella memoria si perdono i ruoli e Pinelli e Calabresi sono visti semplicemente come vittime. Nella storia, però, i ruoli sono attribuiti in un altro modo. L’assassinio di Pinelli è stato perpetrato all’interno di una struttura dello Stato nel corso di un’indagine sulla strage di piazza Fontana. Quello di Calabresi, in un contesto diverso e qualcuno che potrebbe spiegarcelo non vuole farlo. E, stranamente, a questi non si chiede di tacere. Ora, nel diritto moderno è lo Stato che regola il rapporto tra il reo e la giustizia, tanto che il pubblico ministero non difende i parenti delle vittime, ma sostiene l’accusa in nome del popolo italiano. La vittima, o i suoi parenti, si possono costituire parte civile, con un avvocato a rappresentarli. Il giudice, quindi, è terzo rispetto alle parti e non potrebbe essere altrimenti, da quando la dottrina giuridica e le costituzioni moderne hanno tolto alla famiglia il diritto di vendetta, sostituendolo con quello della giustizia. La memoria rientra nella sfera privata e sembra più vicina alla vendetta che alla giustizia, se usata come rivendicazione. Ovviamente i parenti di una vittima hanno tutto il diritto di scrivere, appellarsi e indignarsi. Non lo ha però lo Stato, che ha compiuto il proprio dovere arrestando i brigatisti e riuscendo a farli condannare, debellando il fenomeno. Dato però che lo Stato non dovrebbe vendicarsi, non può condannare nessuno né al silenzio, né all’oblio. Anzi, ne guadagnerebbe se, ora che la guerra è finita da tempo, si impegnasse per capire il motivo che ha indotto una generazione e una classe sociale a dire «mai più senza fucile», agendo di conseguenza. Gli ex lo possono spiegare, ed è interesse di tutta la comunità che lo facciano.
schiera dei cosiddetti pentiti o dissociati. Per quanto concerne, invece, gli irriducibili, essi per lo più tacciono (e spesso i commentatori li accusano proprio per questo!) e anche quando parlano, come nel caso di Mario Moretti con un libro sulle Br per nulla apologetico, si sottolinea quello che non sarebbe stato ancora detto, perché è una verità predeterminata, quella che si vorrebbe ascoltare, non il pensiero di Moretti. Veniamo alla questione delle vittime e dei loro parenti. Il 9 maggio è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo in Italia. Di tutte le vittime, senza distinzione di matrice, tipologia di attentato, obiettivo. Quest’anno, per l’occasione, la vedova Pinelli è stata invitata al Quirinale, dove ha incontrato la vedova Calabresi. L’iperbole è complessa, e va analizzata e spiegata. Da tempo ormai il calendario italiano si è riempito di giorni della memoria e del ricordo e si cerca di far passare l’idea che la memoria abbia una sorta di dignità parallela a quella della storia. Forse perché la memoria appartiene alle vittime, mentre la storia ai vincitori? In realtà non è così. La differenza è un’altra e ben più sostanziale. La memoria appartiene alla sfera privata, mentre la storia è pubblica. La memoria non si può verificare, laddove la storia attende un riscontro da parte della comunità scientifica. La memoria non sostituisce la storia, né si affianca ad essa; offre delle fonti, tutte da vagliare. Per questo, un incontro tra la vedova Pinelli e la vedova Calabresi può avere luogo solo nel giorno della memoria. Perché nella memoria si perdono i ruoli e Pinelli e Calabresi sono visti semplicemente come vittime. Nella storia, però, i ruoli sono attribuiti in un altro modo. L’assassinio di Pinelli è stato perpetrato all’interno di una struttura dello Stato nel corso di un’indagine sulla strage di piazza Fontana. Quello di Calabresi, in un contesto diverso e qualcuno che potrebbe spiegarcelo non vuole farlo. E, stranamente, a questi non si chiede di tacere. Ora, nel diritto moderno è lo Stato che regola il rapporto tra il reo e la giustizia, tanto che il pubblico ministero non difende i parenti delle vittime, ma sostiene l’accusa in nome del popolo italiano. La vittima, o i suoi parenti, si possono costituire parte civile, con un avvocato a rappresentarli. Il giudice, quindi, è terzo rispetto alle parti e non potrebbe essere altrimenti, da quando la dottrina giuridica e le costituzioni moderne hanno tolto alla famiglia il diritto di vendetta, sostituendolo con quello della giustizia. La memoria rientra nella sfera privata e sembra più vicina alla vendetta che alla giustizia, se usata come rivendicazione. Ovviamente i parenti di una vittima hanno tutto il diritto di scrivere, appellarsi e indignarsi. Non lo ha però lo Stato, che ha compiuto il proprio dovere arrestando i brigatisti e riuscendo a farli condannare, debellando il fenomeno. Dato però che lo Stato non dovrebbe vendicarsi, non può condannare nessuno né al silenzio, né all’oblio. Anzi, ne guadagnerebbe se, ora che la guerra è finita da tempo, si impegnasse per capire il motivo che ha indotto una generazione e una classe sociale a dire «mai più senza fucile», agendo di conseguenza. Gli ex lo possono spiegare, ed è interesse di tutta la comunità che lo facciano.
Link
Magris – Anni di piombo quei terroristi pentiti con la pappa nel cuore
Miccia corta e cervello pure
A Fabrizio Pelli, lasciato morire in carcere…30 anni fa
FABRIZIO PELLI
– Nasce a Reggio Emilia, l’11 luglio 1952
– Lavora come cameriere
– Milita nelle Brigate Rosse
– Viene arrestato a Pavia nel dicembre 1975
– Muore di leucemia nel carcere di San Vittore, Milano, l’8 agosto 1979
Documenti prodotti da organizzazioni armate
– Non ne sono stati prodotti, ma a Fabrizio Pelli vengono intitolate una Brigata e un’organizzazione armata a Salerno
Documenti prodotti da gruppi sociali
– Comitato di lotta del Campo dell’Asinara, “Onore al compagno Fabrizio Pelli” in: Controinformazione 16, Milano 1979
“Per ogni comunista la morte è un evento naturale e Fabrizio Pelli era comunista combattente.
Anche il mare più incurabile per un rivoluzionario è occasione di lotta e Fabrizio, con il suo comportamento, lo ha dimostrato a tutta la sua classe e ai suoi nemici, in quest’ultima, solitaria battaglia.

Fabrizio Pelli _Questa foto aveva le sbarre, quelle che lo hanno tenuto costretto fino alla sua morte: sono state tolto, almeno così è LIBERO_
Invano i corvi borghesi hanno atteso un suo cenno di debolezza per piegarlo, per ricondurlo al compromesso dentro l’ordine dell’oppressione. A nulla è servito tenerlo isolato fino all’ultimo istante, privato della posta e della vicinanza dei suoi compagni, negargli – come neppure il fascismo osava fare – di trascorrere le ultime ore di visita in compagnia dei suoi familiari, a casa sua.
La speranza delle iene è andata delusa di fronte ad un comunista che aveva maturato a fondo un principio essenziale: uomini che si rifiutano di interrompere la loro lotta, o vincono o muoiono, invece di perdere o morire!
Il Tribunale di Milano, così sollecito a concedere la libertà provvisoria per motivi di salute ai fascisti assassini di proletari come Braggion, non è che l’ultimo anello di una catena di infamie, cominciata proprio qui, all’Asinara, dove il medico Silvetti si guardò bene dal rilevare il reale stato di salute del compagno Fabrizio, quando nell’estate dello scorso anno cominciò ad accusare i sintomi della malattia.
I Campi di Trani, Fossombrone e Milano sono altrettanti anelli del suo progressivo annientamento che medici e direttori hanno perseguito con lucida e spietata determinazione in occulta armonia con i funzionari del ministero di Grazia e Giustizia. E non vogliamo dimenticare, in questo elenco di canaglie ancora viventi, carabinieri e poliziotti che hanno sottoposto i familiari di Fabrizio alle perquisizioni più vili e che in ogni modo hanno tramato per interrompere il proseguimento delle cure.
Noi proletari prigionieri del Campo dell’Asinara, che con Fabrizio abbiamo lottato e che, anche per il suo contributo, abbiamo rafforzato la nostra identità e la nostra organizzazione, oggi diciamo, senza alcuna retorica, che i suoi nemici sono anche i nostri, che i suoi assassini non resteranno impuniti!
Onore al compagno Fabrizio Pelli!
Onore a tutti i compagni caduti combattendo per il comunismo!”
Testimonianza al Progetto Memoria
– Renato Curcio, Roma 1994
“Ho conosciuto Fabrizio, Bicio per gli amici, nel 1969.
Aveva 17 anni ma, a Reggio Emilia, già da tempo aveva fatto parlare di sé. “Per un colpo di flobert indirizzato ai glutei di un politico del partito liberale”, mi dissero, tra l’ammirato e l’ironico i suoi compagni di allora.
Non aveva ancora 18 anni quando venne a Milano con tutte le sue curiosità per la metropoli. Ma ciò che veramente lo spingeva, in verità era una cosa sola: l’impegno militante a fianco di studenti e operai, di chiunque in qualsiasi modo lottasse, per cambiare le cose.
Si sentiva un po’ anarchico ma il fascino della rivoluzione bolscevica era su di lui così potente che trascorreva infinite notti a leggere, oltre ai testi canonici, qualsiasi saggio, opuscolo, libello che in qualche modo potesse arricchire le sue conoscenze. E se qualcuno per caso citava un’opera che gli era sfuggita, s’infuriava, non sembrandogli lì per lì possibile che quell’opera esistesse veramente. Se non era a volantinare, in qualche manifestazione o a organizzare qualche azione di lotta potevi star sicure che il suo tempo era speso in letture.
Politiche, s’intende. Una dedizione totale, senza mezze misure. Senza concedere a se stesso nemmeno gli spazi dell’esplorazione della vita.
Quando entrò nella lotta armata, nel 1971, se non era il più giovane certo si contendeva il primato. Proprio in relazione alla sua giovanissima età, con altri due compagni ci chiedemmo se fosse il caso di accoglierlo nella vita clandestina che, per ovvie ragioni, non è tra le più permissive. Ma a Bicio il carattere non faceva difetto e non ne volle sapere di tutti gli argomenti che gli mettevamo davanti per dissuaderlo.
Era molto orgoglioso e un po’ testardo. Capitava così che non accettasse di buon grado che altri gli insegnassero qualcosa. Ricordo che una volta si infuriò con un militante: non ritenendolo adeguatamente colto in dottrina marxista, gli negava il diritto di insegnarli a guidare l’automobile. L’altro, naturalmente, lo mollò giù dalla macchina, in piena campagna, dicendogli “Beh, ora vado a studiare, tu raggiungimi a piedi!”
Quando, nel 1975, dopo l’evasione da Casale, lo incontrai di nuovo, a Milano, Fabrizio si era innamorato. Nella sua vita era la prima volta. E il calore di questa nuova e magnifica esperienza scioglieva tumultuosamente tutte le sue rigidezze. Della sua proverbiale rigorosità, in quei giorni non rimase traccia. A metà della riunione più delicata, lui si alzava e borbottava “Scusate…”, in pieno candore se ne andava a telefonare. Alla vita clandestina il suo stato di grazia causò qualche problema, ma alla sua vita personale certo fece un gran bene.
Ho appreso la notizia del suo arresto alla radio, pochi giorni prima di essere a mia volta arrestato. L’ultimo nostro incontro, dunque, avvenne in carcere, all’Asinara. Alcune divergenze politiche che poco prima del suo arresto lo avevano portato a distaccarsi dalle Brigate Rosse non avevano in alcun modo intaccato il nostro affetto. I giorni trascorsi nella stessa cella, al bunker dell’isola, furono così pieni di confidenze sulla nostra vita privata. Giocammo a scacchi –costruiti con la mollica di pane – ridendocela a più non posso sul nostro incontro qualche anno prima, con quel gioco. Nel tempo della clandestinità, a Torino. Sull’onda del duello tra Carpov e Fisher Bicio aveva deciso di “sapere tutto” sugli scacchi, proprio come qualche anno prima aveva fatto con la rivoluzione bolscevica. S’era quindi comperato una scacchiera , tanti libri, riviste e s’era sprofondato nello studio. Venne finalmente il giorno della prima prova. Si sentiva pronto e col sorriso diceva: adesso ti faccio vedere… Ci provai col fatidico “scacco del barbiere”: scacco matto in pochissime mosse. E la sua inesperienza ebbe la peggio. Come al solito andò su tutte le furie e per un bel po’ di tempo di scacchi preferimmo non parlarne più.
All’Asinara mi disse anche dei malori che poco dopo lo portarono, rapidamente, alla morte. Ma di cosa effettivamente si trattasse, in quel carcere senza alcuna servizio medico, non fu possibile stabilirlo. Non si lamentò mai delle mancate cure: per lui era scontato. E anche questo, ricordando Bicio, non può essere più dimenticato”.

A Dario Bertagna
DARIO BERTAGNA
– Nasce a Comerio (BG) l’8 luglio 1950
– lavora come impiegato presso una ditta di produzione di vernici di Vimercate (MI)
– milita nei Reparti Comunisti d’Attacco
– viene arrestato a Milano il 23 giugno 1980
– muore suicidia nel carcere di Busto Arsizio (VA) il 17 luglio 1988
Scritture di Dario Bertagna
– Dario Bertagna, lettera al Bollettino, 27-8-84, carcere di Fossano:
“Come mai allora questo trasferimento improvviso al manicomio di Reggio Emilia? Le cose stanno così: la dottoressa psichiatra del carcere, dopo una sbrigativa visita, aveva diagnosticato che L.V. era schizofrenico. Ma vi rendete conto?  Una persona legge quattro scartoffie riguardanti un carcerato, lo visita cinque minuti e lo giudica nientemeno che schizofrenico. Mi rendo conto che questa dottoressa probabilmente ha agito in buona fede e che ancora più facilmente le responsabilità maggiori stanno in qualche altro ingranaggio dell’apparato di potere. Sta di fatto che questi signori si rendono conto che non sono altro che dei meccanismi di una macchina mostruosa, ingranaggi più o meno determinanti, ma ciascuno facendo parte di un congegno degenerato che a sua volta genera le singole parti.
Una persona legge quattro scartoffie riguardanti un carcerato, lo visita cinque minuti e lo giudica nientemeno che schizofrenico. Mi rendo conto che questa dottoressa probabilmente ha agito in buona fede e che ancora più facilmente le responsabilità maggiori stanno in qualche altro ingranaggio dell’apparato di potere. Sta di fatto che questi signori si rendono conto che non sono altro che dei meccanismi di una macchina mostruosa, ingranaggi più o meno determinanti, ma ciascuno facendo parte di un congegno degenerato che a sua volta genera le singole parti.
Sia chiaro comunque che anche singoli proletari possono benissimo essere incorporati in questo brutale meccanismo e, anche se saranno rotelle di poco conto, si renderanno pur sempre funzionali al sistema. Mi riferisco tra l’altro specialmente ai vari dissociati, di nome o di fatto, o tutti e due. Certo lo Stato non manda costoro a Reggio Emilia e magari concede loro anche qualche zuccherino.
Facciamo bene i contri e vedremo con chiarezza che schizofrenico è questo sistema e tutti i suoi ingranaggi e non certo il compagno L.V.”
– I Compagni del movimento e i familiari dei detenuti, Volantino, 23 luglio 1988, Busto Arsizio
“Domenica scorsa, 17 luglio, il compagno Dario Bertagna si è tolto la vita nel carcere di Busto Arsizio, dopo aver scontato 8 anni di galera per reati politici. Malgrado la marginalità delle responsabilità penali, nel processo che ha deciso la messa in collaborazione dei pentiti come Barbone e di altri imputati che hanno scelto la strada della collaborazione e l’abiura, Dario subì una condanna a 15 anni di carcere. E’ questa l’ennesima dimostrazione di come le leggi e le prassi giuridiche nate dall’emergenza abbiano legato l’entità della condanna all’identità politica e al comportamento degli imputati, malgrado le autorità e gli intellettuali più o meno di regime, insieme ai partiti, abbiano ripetuto fino alla noia che “tutto si è sempre svolto nella legalità e nel rispetto delle regole della democrazia.”
 Dario non era né pentito né dissociato ed ha sempre lottato, con tutte le sue forze, per salvaguardare la propria dignità umana e la propria identità politica. Per 8 anni ha lottato contro la macchina di distruzione che è il carcere, in condizioni psicofisiche sempre più instabili, come i medici del carcere hanno avuto modo di constatare più volte. La sua morte, come tutte le morti avvenute in carcere, peserà come un macigno anche sui responsabili della disastrosa gestione dell’assistenza sanitaria, su quanti permettono che passino giorni e settimane prima di un ricovero, su chi tra la salute del detenuto e la sicurezza dell’istituzione sceglie sempre quest’ultima.
Dario non era né pentito né dissociato ed ha sempre lottato, con tutte le sue forze, per salvaguardare la propria dignità umana e la propria identità politica. Per 8 anni ha lottato contro la macchina di distruzione che è il carcere, in condizioni psicofisiche sempre più instabili, come i medici del carcere hanno avuto modo di constatare più volte. La sua morte, come tutte le morti avvenute in carcere, peserà come un macigno anche sui responsabili della disastrosa gestione dell’assistenza sanitaria, su quanti permettono che passino giorni e settimane prima di un ricovero, su chi tra la salute del detenuto e la sicurezza dell’istituzione sceglie sempre quest’ultima.
Oltre a tutto ci preme ricordare che non più di un mese fa il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva negato a Dario la semilibertà, nonostante gli 8 anni di galera scontati, le sue precarie condizioni di salute e l’ottenimento di un posto di lavoro in una fabbrica del suo territorio. In carcere non avevano pesato sul suo contro gravi rapporti disciplinari o denunce. (…)
Con il suo ultimo gesto Dario ha gridato ancora una volta il suo rifiuto a piegarsi al patto infame che impone la svendita della propria dignità in cambio della scarcerazione.
Noi siamo oggi davanti al carcere di Busto Arsizio e poi in piazza per ricordare alla gente che l’angolo di barbarie costruito negli anni dell’emergenza e nel quale sono già morti troppi detenuti non deve continuare la sua opera di distruzione.”
– Giulio Petrilli, Testimonianza al Progetto Memoria, L’Aquila 1995
“Ricordare Dario è ricordare un compagno col quale ho condiviso dei momenti, delle lotte, dei sogni, in una realtà particolare come il carcere di San Vittore, dal dicembre ’80 alla metà dell’83. Un momento di grandi lotte in uno dei carceri metropolitani più particolari, più complessi. Dario l’ho conosciuto esattamente il 6 gennaio 1981, in una cella del secondo raggio, la nostra cella per tanto tempo, poi i trasferimenti ci hanno diviso.
Ricordo quel pomeriggio del 6 gennaio, dopo diversi giorni nelle celle d’isolamento fui fatto salire su in sezione, stavo un po’ sbandato tra arresto e isolamento, ma entrando in cella subito mi sentii a mio agio in un ambiente caldo; eravamo in cinque, un po’ stretti ma stavamo bene. E’ lì che conobbi Dario, mi sembrò subito così come poi l’ho conosciuto nel tempo: un ragazzo riservato ma estremamente dolce, il suo aspetto rispecchiava il suo carattere, con quel sorriso un po’ triste negli occhi azzurri. Ricordo mi offrì subito una birra, e preparò insieme agli altri una bella cenetta; e poi quelle birre che hanno accompagnato tanti nostri pomeriggi e tante serate. Ricordo che mi riempì di domande, sai appena arriva uno nuovo è un po’ d’abitudine in carcere sentire i racconti della vita fuori. Lui disse che era stato arrestato nel giugno precedente, e che da poco si trovava a San Vittore. In precedenza era stato a Fossano, un carcere penale e mi raccontò della vita lì, delle diversità con San Vittore anche perché poi lì al secondo raggio eravamo tutti politici, mentre lì, con i comuni c’era un’altra realtà, più da logica carceraria. Poi iniziò a raccontarmi della sua vita fuori; era tecnico di una piccola azienda di elettrodomestici, vicino a Milano; mi raccontò del paese vicino Varese, dove abitava e quando ne parlava si capiva che lui preferiva vivere lì e non in una grande città, anche perché da piccolo aveva vissuto in un paesino del bergamasco. Poi mi raccontò della sua esperienza politica a Milano, la sua politicizzazione passata attraverso la sindacalizzazione nella fabbrica dove lavorava, i contrati, le lotte, l’inasprimento del padronato, la coscienza sempre più approfondita che lui andava maturando, lo scontro con le logiche di totale mediazione, che lui chiamava “arrendevolezza del vertice del sindacato”, il suo travaglio e la rottura completa con il sindacato. La sua incredulità nel raccontare che molti dirigenti d’industria e capi reparto tra i più duri erano iscritti al PCI.  Lui non se ne faceva capace che chi imponeva la produttività, il sacrificio, la logica di lottare, ma portando sempre il profitto all’azienda, erano quelle le persone che a parole si dicevano comuniste. Questa cosa per lui era totalmente inammissibile, da lì maturò la scelta della lotta armata. E questa sua scelta, maturata proprio partendo dall’avversione verso la cultura stalinista e produttivista del PCI, se l’è portata dietro sempre, con coerenza fino alla fine.
Lui non se ne faceva capace che chi imponeva la produttività, il sacrificio, la logica di lottare, ma portando sempre il profitto all’azienda, erano quelle le persone che a parole si dicevano comuniste. Questa cosa per lui era totalmente inammissibile, da lì maturò la scelta della lotta armata. E questa sua scelta, maturata proprio partendo dall’avversione verso la cultura stalinista e produttivista del PCI, se l’è portata dietro sempre, con coerenza fino alla fine.
Dario era chiuso, un po’ introverso ma estremamente determinato e lucido; io non concordavo alcune questioni del suo ragionamento ma in fondo ero con lui, soprattutto in quegli anni a San Vittore. Poi le nostre strade si sono divise, ci siamo scritti qualche lettera, lui non concordava la mia scelta critica al metodo della lotta armata che secondo me non si adattava più, ma c’è sempre stato dell’affetto.
Poi siamo nati lo stesso giorno, l’8 luglio festeggiavamo i compleanni insieme, sognavamo insieme, io ci scherzavo un po’ su, sulla sua rigidità. Abbiamo studiato tanti libri, documenti, insieme, nelle lunghe e interminabili discussioni e passeggiate nel cortile, dove lui, tra una sigaretta e l’altra, si faceva chilometri a piedi, molto spesso da solo, assorto nel suo mondo. E io scherzavo dicendo: “Torna in terra, vieni a giocare a pallavolo, a correre”. Con l’ironia e lo scherzo molto spesso comunicavo con lui , con quel suo modo d’essere reticente nel parlare anche della sua vita privata, dei suoi amori. Con quel suo bene grande che voleva alla sorella, che spesso veniva a trovarlo, portandogli anche dei pacchi che consumavamo insieme.
Poi, come spesso accade, ci siamo persi. E ci siamo ritrovati tanti anni dopo, nel maggio dello scorso anno, sfogliando una pagina del libro La mappa perduta, ho letto il suo nome e l’ho rivisto nel cuore, in quel suo grande cuore che non voleva mai manifestare, che voleva quasi coprire, proteggere, con un po’ di scontrosità”.
Un bell’articolo su Vincenzo Guagliardo e Nadia Ponti
TRANQUILLI! VINCENZO GUAGLIARDO DOPO 33 ANNI RESTA IN CARCERE
di Mario Dellacqua
“Il mondo di None” 6/7 GIUGNO-LUGLIO 2009
Mensile di None TO
Questa storia non mi da pace, non interessa quasi nessuno e non ci posso fare niente. Quando Vincenzo Guagliardo è sparito nella lotta armata, non me ne sono accorto. Ero distratto. Quando ne è uscito passando attraverso il carcere –ora sono una vita di 33 anni – ero ancora più distratto e le sue foto sul giornale dietro le sbarre smuovevano al massimo la mia curiosità, ma finiva lì. Poi vennero i suoi libri. Li ho letti e ne ho parlato su queste ospitali colonne. Venne anche la dimessa lotta solitaria, sua e di sua moglie Nadia Ponti, per ottenere il diritto all’affettività in carcere, condotta con implacabile serenità, anche a costo di rinunciare ai benefici di una legislazione che premiava i detenuti a condizione che esprimessero atti di contrizione, esibizioni pubbliche di pentimento, richieste spettacolari di perdono. La giustizia italiana non concesse i benefici e neppure l’affettività, perché l’umanità del trattamento carcerario prescritta dalla Costituzione si accontenta di considerare i detenuti ancor meno di animali rinchiusi in uno zoo.
Vincenzo e Nadia continuarono a rivendicare la loro dignità di persone senza pretese e rifiutarono persino di tentare la via della spettacolarizzazione massmediatica del loro caso. Scelsero la via del silenzio che reputarono la forma di mediazione più consona alla tragedia della quale erano stati corresponsabili.
Perciò i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Roma respinsero nel settembre scorso la prima istanza di liberazione condizionale: Guagliardo era colpevole della “scelta consapevole di non prendere contatti con i familiari delle vittime”.
Ma un incontro era avvenuto nel 2005, come Sabina Rossa ha testimoniato in un libro uscito ben prima che la figlia dell’operaio comunista ucciso a Genova nel 1979 diventasse parlamentare del PD.
Semplicemente avvenne senza chiamare Bruno Vespa (senza la benedizione televisiva del quale anche i fatti accaduti sono revocati), perché Vincenzo e Nadia non volevano che un così drammatico faccia a faccia apparisse “merce strumentale a interessi individuali, simulazione e perciò ulteriore offesa.”
L’onorevole Rossa, anzi, si rivolse spontaneamente al magistrato di sorveglianza, riferì dell’avvenuto colloquio, chiese la liberazione dei due detenuti e presentò addirittura una proposta di legge che non subordinava la concessione della condizionale alla imponderabile verifica pubblica della sfera interiore del detenuto come prova dell’autenticità del ravvedimento. Ma i giudici non si sono accontentati e ad aprile hanno respinto per la seconda volta la richiesta di Guagliardo. Non bastano più i contatti con le persone offese: ora si decide che essi assumono “valenza determinante” solo se “accompagnati dall’esternazione sincera e disinteressata”. Poco importa se Sabina Rossa, la figlia della vittima, ha chiesto la liberazione del condannato all’ergastolo dopo 33 anni di carcere: la sua è una “manifestazione isolata non rappresentativa delle persone offese”.
Anche noi anarchici siamo tenuti a rispettare la giustizia e le sentenze di uno Stato che non amiamo, ma nessuno ci toglierà dalla testa che “il tema del perdono –come scrive il giornale comunista Liberazione del 15 aprile scorso – o meglio la mediazione riparatrice o riconciliatrice, attiene alla sfera privata, non a quella dello Stato.” Lo Stato democratico, se non vuole diventare Stato etico, non dovrebbe spoliticizzare il pubblico e politicizzare il privato: piuttosto dovrebbe, come stabilisce la Costituzione, misurare se le pene inflitte – che non devono essere contrarie al senso di umanità – hanno raggiunto l’obiettivo della rieducazione del condannato al quale devono sempre tendere (art. 27).
La lotta di Nadia e Vincenzo continua con esemplare e magistrale serenità: essa non cancella l’inamovibile tormento, ma lo scioglie e lo distribuisce sotto forma di una domanda e di un’offerta di umanità che colpisce e turba anche i distratti come me, sempre impegnati in cose più importanti, che non so quanto siano effettivamente più importanti.
AD ANNAMARIA MANTINI
ANNAMARIA MANTINI
-Nacque a Fiesole, l’11 aprile 1953
-Frequenta le scuole a Firenze e nel 1973 si iscrive a Lettere e Filosofia
– Nel 1975 si trasferisce a Roma
– Milita nei Nuclei Armati Proletari
– Viene uccisa dai carabinieri a Roma l’8 luglio 1975
Documenti prodotti da organizzazioni armate per la per persona o per l’evento in cui ha incontrato la morte:
– Nuclei Armati Proletari, Comunicato 9-7-75 in: Soccorso Rosso napoletano (a cura di), I nap, Milano 1976, Collettivo Editoriale Libri Rossi.
“9 luglio 1975: Ieri in un agguato teso dalla polizia, è stata uccisa a freddo la compagna Annamaria. La volontà del potere di chiudere la partita con i compagni che si organizzano clandestinamente, ha armato la mano del killer di turno, che con la precisa coscienza di uccidere, ci ha privato di una compagna eccezionale.
Annamaria era uno dei compagni che hanno dato vita al nucleo “29 ottobre”. Ha fatto parte del gruppo che ha sequestrato sotto casa il magistrato Di Gennaro, e il contributo che ha dato alla costruzione ed esecuzione di questa azione, dimostrando il livello politico militare che aveva raggiunto. E’ enorme l’abisso che separa una compagna rivoluzionaria da uno sbirro. Non basterebbero la vita di cento Tuzzolino per pagare la vita di Annamaria.
Questo non significa che dimenticheremo i Tuzzolino, i Barberis, così come non abbiamo dimenticato i Conti e i Romaniello.
La mano che uccide un proletario ci è nemica come i porci che la armano. Ma lo ripetiamo, non è uccidendo uno o più sbirri che i proletari si possono ripagare del prezzo che stanno pagando per liberarsi. E per questo prezzo altissimo, in noi come in tutti i rivoluzionari, non c’è solo la rabbia ma anche la coscienza che il movimento si sta arricchendo in maniera definitiva del patrimonio di importantissime esperienze che questi compagni ci lasciano.
Le giornate di aprile, le innumerevoli azioni armate, gli espropri per autofinanziamento, le azioni nelle carceri, dimostrano la crescita di una nuova generazione di combattenti, e non bastano gli omicidi e gli arresti per distruggerla.
La nostra esigenza di comunismo è indistruttibile.
Luca Mantini, Sergio Romeo, Bruno Valli, Vito Principe, Gianpiero Taras, Margherita Cagol, Annamaria Mantini.
Non siete i soli e non sarete gli ultimi, ma rappresentate per tutti i rivoluzionari una scelta irrinunciabile.
Lotta armata per il comunismo
Nucleo Armato 29 ottobre.
Documenti prodotti da gruppi sociali
– Anna Maria Mantini, in: Nuclei Armati Proletari, Quaderno n.1 di Controinformazione, Milano 1976
“Comunista da sempre, ma solo a 17 anni inizia ad interessarsi attivamente di politica sull’onda della contestazione studentesca del ’68. Quando il fratello viene arrestato (’72) entra a far parte dell’allora Soccorso Rosso fiorentino. L’esperienza diretta, la grande sensibilità nei confronti delle esigenze del proletariato detenuto la portano alla spontanea scelta verso questo settore di intervento.
Vive dall’interno le contraddizioni dei “nuclei carceri” di Lotta Continua.
 Di sua iniziativa prende contatti con altri detenuti ed ex-detenuti, con i quali mantiene rapporti sempre più intensi: sono loro lo stimolo principale alla sua maturazione politica, il suo punto di riferimento ed è con loro che critica le posizioni attendeste di LC.
Di sua iniziativa prende contatti con altri detenuti ed ex-detenuti, con i quali mantiene rapporti sempre più intensi: sono loro lo stimolo principale alla sua maturazione politica, il suo punto di riferimento ed è con loro che critica le posizioni attendeste di LC.
Dopo una breve militanza in Potere Operaio ne esce per dar vita insieme ad altri compagni al Collettivo G. Jackson.
Il radicalizzarsi delle posizioni all’interno e all’esterno del carcere la rendono cosciente della necessità di operare sui livelli più avanzati dello scontro, ciò la spinge ad approfondire i rapporti con i compagni dei NAP.
Con l’assassinio di due di loro durante un’azione di autofinanziamento viene a rompersi un legame politico e umano fortissimo. “E’ inutile che io nasconda dietro la mia fede politica la mutilazione grossissima che ho avuto” scrive ad un mese dalla morte del fratello.
Ma non per questo affretta o decelera una scelta che già da tempo aveva fatto. La maturità politica, la carica umana, l’odio profondo per l’istituzione carceraria la vedono fondatrice del nucleo 29 Ottobre. Verrà assassinata a 22 anni, ma come spesso ripeteva lei stessa: “E se la morte ci sorprende all’improvviso, che sia la benvenuta, purchè il nostro grido di guerra giunga ad un orecchio che lo raccolga, un’altra mano si tenda per impugnare le nostre armi e altri uomini si apprestino ad intonare canti funebri con il crepito delle mitragliatrici e nuove grida di guerra e di vittoria.”
QUI, il mio omaggio agli altri compagni uccisi dallo stato: omaggio che giorno dopo giorno cerco di completare per non dimenticare nessun@
A loro, sangue nostro.
Ad Antonio Lo Muscio
ANTONIO LO MUSCIO
– Nasce a Trinitapoli (FG) il 28 marzo 1950
– Non risponde alla chiamata per il servizio militare ed è quindi arrestato nel 1970 dove rimane per 2 anni
– torna in carcere più volte
– nel 1975 lavora alla Fargas di Novate milanese per qualche tempo
– milita nei Nuclei Armati Proletari
– viene ucciso dai carabinieri a Roma, il 1 luglio 1977
Scritture di Antonio Lo Muscio
– “Lettera ad un amico”, carcere di Procida, 5 Marzo 1974
Caro compagno spero tanto che tu stia sempre bene. Quando uscirò oltre a lavorare normalmente, cercherò di svolgere anche un certo lavoro politico coinvolgendo se sarà possibile gli stessi elementi che ieri come me vivevano al di fuori della realtà. In un mondo diverso da quello reale dove si vede nel denaro la sola via d’uscita, così come ci ha insegnato la borghesia, che con i soldi fa e disfa a suo piacimento. Bisogna far capire loro come ho capito io che chi ha il potere di fare e disfare a suo piacimento è uno solo, il popolo. E’ questa la vera forza che fa cambiare il mondo, e non il denaro. Tutte le soddisfazioni ce le potremo prendere una volta abbattuti gli sporchi capitalisti e tutte le forze reazionarie esistenti. Solo quando questo sarà attuabile tutti gli uomini si potranno ritenere uomini, oggi siamo sulla via di transizione, cioè uomini lo stiamo diventando solo ora.
– “Lettera ad un amico”, carcere di Perugia, 5 Gennaio 1975
Carissimo compagno, come sai fra non molto sarò fuori precisamente fra 18 giorni. Di questo sono contentissimo per il fatto che uscendo potrò veramente dedicarmi alla lotta politica e in questo modo darò un significato alla mia stessa vita. Dico questo in riferimento a ciò che ero prima, cioè prima che entrassi in carcere. Sono del parere, se il tempo della detenzione viene usato bene, che, almeno una volta, tutti, senza escludere nessuno, dobbiate venire in carcere a vedere da vicino quello che veramente è l’istituzione carceraria e la sua violenza.
Testimonianze al Progetto Memoria
– Silvana Innocenzi, Testimonianza al Progetto Memoria, Firenze 1995
“Un ragazzo intelligente, timido e sensibile. Un sorriso spontaneo, carico di tenerezza e di entusiasmo per la vita. Così la mia mente ricorda il primo incontro con Antonio. Mi colpì la disponibilità e la generosità che aveva nei confronti degli altri, la sua capacità di ascoltare.
Bello, dicevano le compagne che lo incontravano o che hanno avuto modo di conoscerlo nella sua passione politica. Io ero rimasta affascinata dal suo carattere, dal suo mondo interiore. […]
Arrivò il servizio militare e venne inviato a Como proprio mentre era nata un’intensa storia d’amore. La ragazza rimane incinta ( un figlio che poi non nascerà a causa di un aborto spontaneo )… e lui la raggiunge… la classica fuga.
Viene raggiunto a casa e dichiarato in stato di arresto. Ne nasce un tafferuglio… processato e condannato venne rinchiuso nel carcere di Forte Boccea e poi a Gaeta. E’ l’inizio dell’impatto con il carcere.
Il padre iscritto al PCI discuteva spesso con lui. Discussioni animate in cui Antonio, con la passione politica che aveva maturato contestava al padre la politica riformista e revisionista del PCI. In quegli anni lui era ideologicamente più vicino alla sinistra extraparlamentare. Fin da ragazzo era alla continua ricerca di un mondo diverso, più giusto, con meno differenze sociali, con meno sfruttamento e meno emarginazione.
Il suo primo sguardo l’ho incrociato dietro un bancone di una sala colloqui del carcere di Perugia. Era finito lì, dopo la detenzione militare, per un reato definitivo di furto.
 A Perugia insieme ad altri compagni aveva dato vita al Collettivo delle Pantere Rosse, sull’onda del movimento delle Black Panthers americane. […]
A Perugia insieme ad altri compagni aveva dato vita al Collettivo delle Pantere Rosse, sull’onda del movimento delle Black Panthers americane. […]
I nostri incontri a colloquio, erano dei momenti intensi di confronto e scambio, di comunicazione tra realtà diverse. Io che frequentavo il movimento di liberazione della donna e lui che mi parlava dell’assurda vita coatta. Delle vite e delle sofferenze che erano rinchiuse all’interno delle mura di un carcere. Dell’uso dei letti di contenzione e dei manicomi giudiziari per le persone che meno si adattavano alla vita del carcere, alle sue regole.
Era felice quando poteva comunicarmi una piccola conquista interna, sia che si trattasse di spazi di socialità, di condizioni lavorative migliori o della possibilità di far entrare libri e altro materiale scritto senza l’intervento della censura.
Era felice perché stava cambiando qualcosa e si rendeva contro che poteva farlo anche all’interno di un’istituzione così totale come è, ed era, il carcere.
Mi regalò il libro Col sangue agli occhi di Jackson. “Leggilo, mi disse, dimmi cosa ne pensi, secondo me è stupendo”.
Lo lessi e capii che lui lì ritrovava tutte le sue emozioni più forti: rabbia, odio, amore. Non amava il sottoproletariato di Marx, amava il proletariato di Fanon.
Intanto le rivolte nelle carceri aumentavano e quella del carcere di Alessandria fece discutere più di tutte. C’erano stati dei morti tra il personale civile sequestrato.
Alcuni detenuti della rivolta finirono anche a Perugia e iniziò anche lì un’attiva campagna di controinformazione su quanto era realmente accaduto durante il sequestro degli ostaggi,
Sognare, realizzare un’evasione è il desiderio più vivo di ogni recluso per sottrarsi ad una situazione che, per quanto può essere vivibile, toglie il bene più importante: la libertà dell’individuo.
“Liberare tutti” era il messaggio più radicato tra i detenuti di quegli anni.
Alla rabbia istintiva, individuale, cosciente di molti detenuti, i Nuclei Armati Proletari diedero una progettualità collettiva e rivoluzionaria.
Antonio ci si ritrovò.
Un giorno con discrezione mi diede un foglietto dattiloscritto, voleva sapere cosa ne pensavo. Erano delle riflessioni sulla lotta armata, sulla sua possibilità e necessità. Non riuscii subito a dargli una risposta, ero solo cosciente che lì, in carcere più che altrove, le mediazioni non erano possibili.
Uscì nel 1974. Mi presi dei giorni di ferie dal lavoro e l’aspettai all’uscita. Fu sorpreso. Aveva i capelli lunghi, la barba e un cappotto lungo che gli davano un aspetto particolare, tra l’originale e il demodé. […] Furono momenti stupendi. E solo oggi che ho anche io vissuto l’esperienza del carcere posso coglierne ulteriori sfumature.
Cercò i compagni che conosceva, gli amici che da tempo non rivedeva. Alcuni lavoravano in fabbrica e lo invitarono alle loro riunioni. Io a Roma, lui a Milano, ma continuammo a vederci circa ogni 15 giorni.
Il carcere però non lo aveva dimenticato, soprattutto non aveva dimenticato le persone che aveva lasciato e che voleva aiutare ad uscire da quei luoghi di non vita. Continuammo ad andare ai colloqui e a seguire alcuni compagni nei bisogni più immediati.
Intanto nel suo cuore c’era la speranza di entrare in contatto con i compagni dei NAP che iniziavano a fare le loro prime azioni.
Ma il passaggio decisivo alla lotta armata avvenne quando la polizia uccise a Roma, sul pianerottolo di casa, la compagna Anna Maria Mantini (presto questo blog dedicherà una pagina anche a lei). L’aveva conosciuta, apprezzata, stimata moltissimo. Ne discutemmo a lungo di questa sua morte. Non ci volle molto a capire che avrebbe continuato la sua lotta. […] La mia scelta non tardò ad arrivare.
Vivere con lui un periodo della mia militanza nei NAP è stato di un’enorme ricchezza. Era la prima volta che dividevamo insieme più cose, dalla quotidianità al grande sogno di un mondo diverso. Non c’è mai stata tra noi una grande divisione di ruoli, ci alternavamo in molte cose; quello che detestava era fare acquisti, anche quanto le cose servivano a lui. Non viveva la sua scelta separata alle altre dimensioni della vita. La sua concezione di guerriglia conciliava con tutto: azioni, amore, famiglia e figli. Tutto era un unico grande filo rosso.
Viaggiavamo sempre molto uniti, tanto da diventare oggetto di simpatica ironia per gli altri compagni.
L’ultima immagine che ho di lui vivo è quella della separazione alla stazione Termini. Io partivo per Torino, per incontrare dei compagni, e lui mi aveva accompagnato. Non voleva farmi partire, ma io insistetti. Mi girai più volte a guardarlo andare via e giurammo che al ritorno avremmo mollato tutto per festeggiare il mio compleanno.
Ma non potemmo farlo. Appena arrivata a Torino fui arrestata.
Mi raggiunge anche in carcere con simpatiche cartoline, brevi, affettuose, cariche di emotività, quasi a voler colmare il vuoto e la distanza che si era creata materialmente tra noi.
Intanto i compagni continuavano ad essere arrestati, la caccia all’uomo era diventata sempre più accerchiante, e la vita per lui e per gli altri non deve essere stata facile negli ultimi periodi.
Poi un giorno, il primo luglio 1977, la terribile notizia appresa da un banale giornale radio tra le mura di una cella di Marassi, a Genova.
Ucciso durante un conflitto a fuoco con i carabinieri a Roma, piazza san Pietro in Vincoli, vicino alla facoltà di ingegneria, all’età di 27 anni, mentre tentava di sfuggire all’arresto con altre due compagne.
Falciato dalle raffiche di mitra fu poi freddato con una pallottola sparata a pochi centimetri dalla nuca. Non volevano arrestarlo, ma ucciderlo.
Non ci rivedemmo più.
Da una testimonianza raccolta da un giornalista del Corriere della Sera e pubblicata il 2 luglio: “Prima è passato di corsa quel giovane, Lo Muscio, inseguito da un carabiniere che sparava raffiche di mitra. E’ caduto proprio a pochi metri dall’ingresso della facoltà, cercando di sostenersi con le braccia e urlando per il dolore.
E’ a questo punto che il carabiniere, fatti pochi passi, ha lasciato partire un’altra raffica e Lo Muscio è stato fulminato. Gli ultimi colpi sono stati sparati dal carabiniere con una pistola.”
– Amici di Antonio, testimonianza collettiva al Progetto Memoria, Roma 1995
“Antonio l’ho conosciuto in carcere, nelle prime lotte. E’ diventato un compagno dei NAP proprio stando insieme a noi. Antonio era un compagno generoso, molto disciplinato. Quando si accostò al collettivo di Perugia doveva uscire di lì a poco. Gli dissi, se vuoi conoscere un compagno eccezionale, vai a questo indirizzo, e gli diedi l’indirizzo di Luca Mantini (anche di Luca ne parleremo presto ). Lui uscì. E per quanto sembri incredibile, era la sera di Piazza Alberti, del giorno in cui Luca era morto in piazza Alberti. Naturalmente non poteva saperlo e andò in casa di Luca. Lì trovò Annamaria.
Vennero a casa mia insieme quella sera e fu la prima volta che lo vidi. Dopo di allora ci siamo incontrati molte volte. Con me non aveva un rapporto politico, era una cosa un po’ strana, un rapporto molto umano. Antonio era un tipo gioviale, festoso. Cantava. In macchina cantava sempre. Ricordo di un viaggio con Antonio.
Me lo ricorderò tutta la vita. Prendemmo un vassoio, pesante come un macigno. E partimmo. Attraversando mezza Italia. E durante tutto il viaggio, sebbene spossato di stanchezza, cantava. […] Si fermò all’alba in un negozio di alimentari, comprò un po’ di gnocchi di patate. Poi, da un’altra parte, del pomodoro crudo. Li condimmo così, a mano. Al controllo dei cibi, in carcere, comunque mi restituirono il vassoio con tutti quegli gnocchi, e mi dissero seraficamente di metterli in un contenitore di plastica… Mi ricordo quest’ episodio perché dice come era fatto Antonio: se c’era da fare una cosa, lui partiva all’una di notte, attraversava l’Italia e la faceva, con allegria. Antonio era subito disponibile, sempre allegro, ti sapeva mettere subito a tuo agio.
QUI, un’intervista a Franca Salerno, arrestata e pestata (con un bel pancione) insieme Maria Pia Vianale mentre Antonio veniva giustiziato.
A Lorenzo Bortoli, 30 anni dopo la sua morte
LORENZO BORTOLI
– Nasce a Torrebelvicino (VI) il 23 dicembre 1954
– Si diploma e lavora come operaio decoratore alla Blue Bell di Bassano
– milita nel movimento studentesco
– convive con Maria Antonietta Berna, nella casa di Thiene dove avviene l’esplosione dell’11 febbraio 1979
-viene arrestato il 12 febbraio 1979 nell’inchiesta sui Collettivi Politici Veneti
-muore suicida nel carcere di Verona, il 19 giugno 1979
Scritture di Lorenzo Bortoli
– Verbale di confronto tra coimputati, Padova 15-6-79
“Il Bortoli al P.: “Ripeto ancora una volta che è falso quello che tu hai detto; ricordati di questo particolare: nella comune cella, mentre giocavamo a carte io ho estratto di tasca l’ultimo mandato di cattura notificatomi e nel leggerne la motivazione dove si faceva cenno a dichiarazioni di coimputati ebbi un moto di sorpresa; tu spontaneamente mi dicesti che eri stato tu e che avevi riferito su confidenze non vere perché ti era stata promessa dagli inquirenti la derubricazione delle imputazioni e la concessione della libertà provvisoria.”
– Foglio di richiesta, Carcere di Verona 18-6-79
“Al signor direttore della casa circondariale di Verona.
Le sarei veramente grato se potesse far pervenire ai miei familiari il seguente telegramma: “Raggiunto Antonia. Vi prego di essere sepolto con lei. Vi assicuro che sto bene così. Un abbraccio. Dite a Vanna di non piangere, ma di ricordarsi come eravamo felici come ora che siamo nuovamente insieme. Lorenzo”
La pregherei di far pervenire anche il gruppo di fotografie, difalcando le spese dal mio conto personale. La ringrazio vivamente.
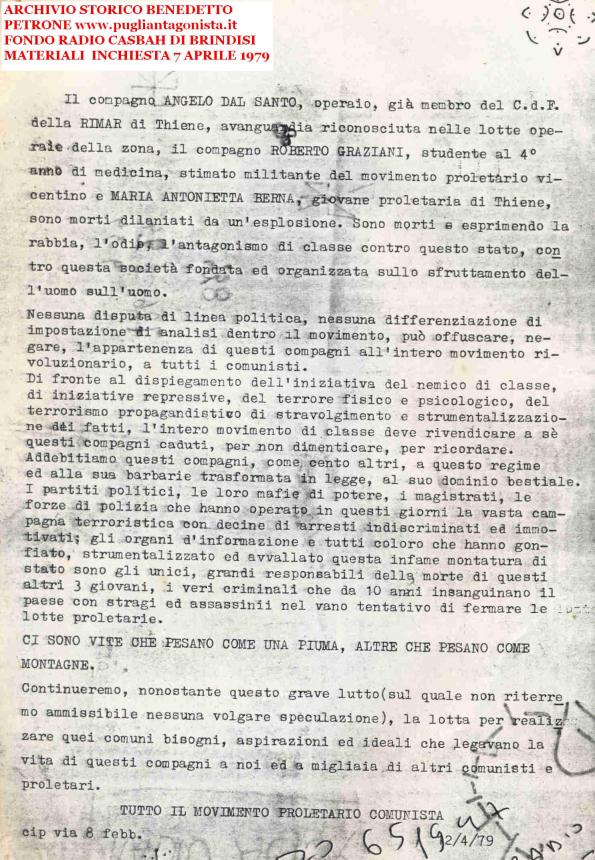 Documenti prodotti da organizzazioni armate:
Documenti prodotti da organizzazioni armate:
-Movimento Comunista Organizzato, Manifesto A Lorenzo Bortoli 19-6-80
“Questo non vuole essere un epitaffio commemorativo, tu per primo non lo vorresti. Lasciamo alla società borghese la misera forma ipocrita di commemorare i propri morti.
Noi vogliamo ricordarti da comunista, da proletario in lotta contro la barbarie del capitale, dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, delle morti “bianche” e per aborto, del rifiuto ad una vita invivibile. Questo è un filo rosso che unisce la tua vita alla nostra, la tua militanza comunista alla vita di milioni di proletari che quotidianamente lottano contro i propri sfruttatori. La tua vita continua in noi nella volontà e nell’impegno che ci assumiamo nel non voler dimenticare chi ti ha costretto al suicidio.
Certo credevano attraverso la tua morte di annientare e terrorizzare centinaia di compagni che come te lottavano e soffrivano in carcere mentre in realtà la tua morte ha smascherato ancora una volta e per sempre chi si nasconde dietro il paravento della legge e della democrazia.
La tua scelta è stata una forma di lotta, non una sconfitta. Questo tutti i rivoluzionari ed i veri comunisti lo hanno capito.
Mai dimenticheremo con quanto odio le bande armate di Dalla Chiesa ti hanno aggredito; come il PM Rende ha pianificato sin dall’inizio la tua morte, attraverso l’isolamento, il non ricovero in ospedale dopo il tuo primo tentativo di suicidio, con la provocazione dell’inserimento con te in cella del burattinaio vigliacco C.P.
Vogliamo gridare guardandoli in faccia tutto il nostro odio verso queste figure, vogliamo che sentano continuamente tutto il nostro disprezzo proletario: spregevoli giocattoli nelle mani dei loro padroni.
Certamente questo non ti farà essere fisicamente tra noi. Tu vivi nella nostra irriducibilità al sottometterci allo Stato del capitale, vivi nel nostro bisogno di comunismo. Per tutto questo ti onoriamo e ricordiamo.
O tutti o nessuno.
Onore a Lorenzo, Angelo, Alberto e Antonietta.
Per il comunismo.
Documenti prodotti da gruppi sociali:
– Comitato di zona Partito Comunista Italiano, “Un suicidio che riempie di sdegno, Thiene 21-6-79
“Apprendiamo con profondo sgomento e indignazione la notizia della morte, nel carcere di Verona, di Lorenzo Bortoli. E’ accaduto ciò che si temeva e ciò che le forze dell’amministrazione della giustizia erano tenute ad evitare. Era infatti evidente che dopo 2 tentativi di suicidio Lorenzo Bortoli si trovava in uno stato psicofisico di estrema prostrazione e che, in mancanza di cure adeguate, di un’attenta assistenza e sorveglianza, di un trattamento più umano e non assolutamente segregante, non avrebbe desistito nel suo intento di togliersi la vita. Proprio queste cure, questa assistenza, avevamo 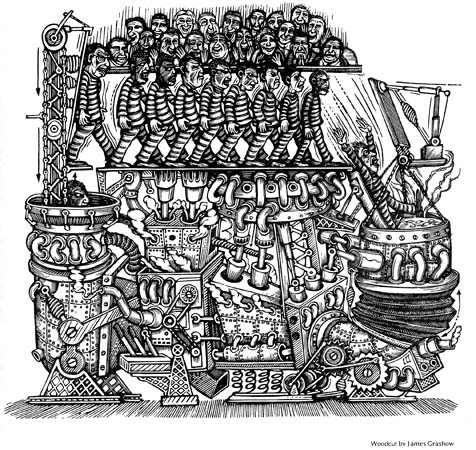 sollecitato aderendo all’appello del 30 Maggio lanciato da alcune personalità e cittadini democratici sul Giornale di Vicenza. Anche alla luce di ciò, il comportamento delle autorità giudiziarie e dell’amministrazione carceraria è tale da suscitare sdegno e riprovazione, in quanto si è dimostrato insensibile e incurante verso il diritto fondamentale di ogni essere umano: il diritto alla vita, e verso i diritti costituzionali di un imputato di potersi difendere, nella pienezza delle proprie facoltà intellettuali e fisiche, dalle accuse mossegli. Il suicidio di Lorenzo Bortoli è quindi un fatto di eccezionale gravità. Le responsabilità nel comportamento delle autorità carcerarie e giudiziarie vanno perciò indgate e punite, per salvaguardare i valori dello stato di diritto e le garanzie che la Costituzione da ad ogni cittadino.”
sollecitato aderendo all’appello del 30 Maggio lanciato da alcune personalità e cittadini democratici sul Giornale di Vicenza. Anche alla luce di ciò, il comportamento delle autorità giudiziarie e dell’amministrazione carceraria è tale da suscitare sdegno e riprovazione, in quanto si è dimostrato insensibile e incurante verso il diritto fondamentale di ogni essere umano: il diritto alla vita, e verso i diritti costituzionali di un imputato di potersi difendere, nella pienezza delle proprie facoltà intellettuali e fisiche, dalle accuse mossegli. Il suicidio di Lorenzo Bortoli è quindi un fatto di eccezionale gravità. Le responsabilità nel comportamento delle autorità carcerarie e giudiziarie vanno perciò indgate e punite, per salvaguardare i valori dello stato di diritto e le garanzie che la Costituzione da ad ogni cittadino.”
– AA.VV. Frammenti di coordinamenti, collettivi, radio.
“Lorenzo Bortoli, operaio decoratore alla Blue Bell di Bassano, arrestato dopo l’esplosione dell’11 febbraio di Thiene dove era tragicamente morta la sua compagna Maria Antonietta Berna, si è tolto la vita impiccandosi nel carcere di Verona. E’ un suicidio che noi chiamiamo assassinio e del quale riteniamo responsabili tutti coloro che hanno abbandonato Lorenzo a se stesso, spingendolo prima alla disperazione con l’accusa di omicidio nei confronti della persona che amava di più, diffamandolo poi come dedito alla droga quando tentò di suicidarsi una prima e una seconda volta ingerendo dei medicinali, rifiutando infine il suo ricovero in ospedale come da tempo richiesto dal collegio di difesa e sollecitato anche da organismi sindacali e sociali della provincia, ma negato dai giudici del tribunale di Vicenza.
Tutto ciò è stato fatale per Lorenzo. L’obiettivo di questo Stato, cioè la distruzione fisica dei suoi avversari, ancora una volta è stato raggiunto. (…).
A tutte le strutture di movimento, a tutti i proletari della provincia proponiamo che la mobilitazione continui e si allarghi ponendosi come obiettivo centrale la messa in stato di accusa di tutti i responsabili della morte di Lorenzo. (…)”
Il coraggio dell’amnistia
Oggi il nuovo quotidiano L’Altro, ha aperto con un editoriale di Sansonetti decisamente importante, che riporterò qui sotto.
In questi giorni proverò a mettere un po’ di materiale sull’amnistia: perchè è una battaglia che dovremmo sentire nel sangue.
Per allontanare “dar catenaccio” chi ancora è costretto dentro un carcere…
IL CORAGGIO DELL’AMNISTIA di Piero Sansonetti (editoriale del quotidiano L’Altro di sabato 16 maggio 2009)
Giampiero Mughini ha raccontato ieri al Corriere della Sera (articolo di Aldo Cazzullo) i suoi ricordi e le sue riflessioni sull’uccisione del commissario Luigi Calabresi (anno 1972), Mughini all’epoca era vicino al gruppo dirigente di Lotta Continua, e quindi basa la sua ricostruzione (ipotetica) dei fatti su elementi di conoscenza personale (di abitudini, idee, rapporti, modi di comportarsi di quel periodo).  Mughini avanza l’ipotesi che Sofri non sia colpevole diretto, ma che sapesse. E che conosca i nomi di chi uccise Calabresi. Tesi che già in passato aveva sostenuto. Personalmente questa ricostruzione non mi convince. Penso che Sofri sia innocente. E constato che, in ogni caso, contro di lui non sono state raccolte prove, e i processi che si sono conclusi con la sua condanna erano processi indiziari, tutti fondati sulle dichiarazioni di un pentito (non verificate e non verificabili) il quale in cambio della condanna di Adriano Sofri ha ottenuto per se la libertà dopo pochissimi mesi di prigione (pur essendo stato condannato come autore materiale dell’uccisione).
Mughini avanza l’ipotesi che Sofri non sia colpevole diretto, ma che sapesse. E che conosca i nomi di chi uccise Calabresi. Tesi che già in passato aveva sostenuto. Personalmente questa ricostruzione non mi convince. Penso che Sofri sia innocente. E constato che, in ogni caso, contro di lui non sono state raccolte prove, e i processi che si sono conclusi con la sua condanna erano processi indiziari, tutti fondati sulle dichiarazioni di un pentito (non verificate e non verificabili) il quale in cambio della condanna di Adriano Sofri ha ottenuto per se la libertà dopo pochissimi mesi di prigione (pur essendo stato condannato come autore materiale dell’uccisione).
Sono assolutamente convinto del principio secondo il quale in mancanza di prove non si può condannare. E credo che un certo numero dei processi che si sono svolti negli anni ’80 (e in parte ’90) contro gli imputati di lotta armata o di reati politici, siano stati processi “zoppi”, poco convincenti, senza garanzie. Influenzati dal clima politico dell’epoca e condizionati da una legislazione speciale, basata sull’esaltazione del pentitismo, che non dava garanzie né di verità né di equanimità. Che le cose stiano così è abbastanza evidente. E ce ne accorgiamo ogni volta che le nostre autorità chiedono l’estradizione di qualcuno che fu condannato in quegli anni, con quei processi, e non la ottengono (recentissimo caso Battisti), Come mai non l’ottengono? Perché la Francia, il Brasile, il Canada, la Gran Bretagna, la Svezia, la Spagna eccetera eccetera sono paesi filo terroristi? Non mi pare una spiegazione ragionevole. Non la ottengono perché i processi sono considerati non affidabili. Tutto qui. Vedete bene che il problema esiste, e va affrontato seriamente. In che modo? Riprendendo la riflessione su quegli anni di fuoco, nei quali la lotta politica, in Italia, convisse con la lotta armata; e trovando il modo dì uscire definitivamente da quel clima e da quella storia. C’è un solo modo di uscire da quel clima e da quella storia.
Chiudendone tetti gli strascichi giudiziari e penali. Cioè con l’amnistia. Solo l’amnistia può relegare finalmente nel passato gli anni di piombo e di conseguenza permettere l’apertura di una discussione e di una riflessione seria. Quali sono gli argomenti contro l’amnistia?
In genere se ne sentono tre.
Il primo è il cosiddetto “diritto dei parenti delle vittime”.
Il secondo è la certezza della pena e il rischio che gente che ha seminato il male non paghi per il male, la faccia franca.
Il terzo è la paura che l’amnistia ci impedisca di scoprire cosa davvero è successo in quegli anni, cosa c’era dietro i delitti,
Il primo argomento mi sembra che non riguardi il diritto. Riguarda semmai la politica. I parenti delle vittime non hanno il diritto dì influire sulle pene dei colpevoli (o, talvolta, dei sospetti). Hanno il diritto ad essere risarciti, aiutati, assistiti. E spesso questo diritto non viene loro riconosciuto dallo Stato, ma l’amnistia non c’entra niente.
Il secondo argomento è sbagliato. Per un motivo molto semplice: la lotta armata degli anni settanta è l’unico capitolo della storia del delitto italiano che ha prodotto un numero altissimo di condanne e di pene. I ragazzi che furono coinvolti nella lotta armata, nella loro quasi totalità hanno pagato con anni e anni di galera. Non esistono altri “rami” del delitto dei quali si possa dire altrettanto.  Qualcuno ha pagato per le stragi di Stato? Qualcuno per la corruzione politica? Qualcuno per le responsabilità dell’ecatombe sul lavoro? Ho fatto solo tre esempi, ì più clamorosi» ma potrei continuare. E allora è curioso che si chieda la cer-tezza della pena per gli unici che la pena l’hanno scontata. Giusto?
Qualcuno ha pagato per le stragi di Stato? Qualcuno per la corruzione politica? Qualcuno per le responsabilità dell’ecatombe sul lavoro? Ho fatto solo tre esempi, ì più clamorosi» ma potrei continuare. E allora è curioso che si chieda la cer-tezza della pena per gli unici che la pena l’hanno scontata. Giusto?
Il terzo argomento è il più controverso. E’ la famosa questione del complotto. Qual è il problema? Una parte dell’opinione pubblica italiana (specialmente di sinistra) si era convinta, negli anni scorsi, che il fenomeno della lotta armata fosse troppo grande e vasto e potente per potere essere il semplice prodotto dell’impegno diretto e un po’ delirante di alcune migliaia di giovani. E che allora dovesse essere il risultato di un complotto nazionale o internazionale. Devo dire che per molti anni anche io mi ero convinto di qualcosa del genere. Avevo sospettato che il rapimento e l’uccisione di Moro fosse una losca congiura del potere. Però poi, di fronte alla realtà, bisogna arrendersi. I colpevoli sono stati tutti arrestati, sono state raccolte tonnellate di testimonianze, prove, documenti. Sono passati 30 anni. È chiaro che non ci fu complotto. Semplicemente avevamo sottovalutato la forza della rivolta armata. E allora perché negare l’amnistia con la scusa della ricerca della verità? È chiaro che le cose stanno in modo molto diverso. La verità che ancora non conosciamo, che vorremmo conoscere, è quella sulle stragi di Stato (da piazza Fontana 1969 fino alla Stazione di Bologna 1980). Cioè su quella parte di lotta armata (di controguerriglia) che fu organizzata direttamente dalle istituzioni e dal potere e che, tra l’altro, ebbe un peso forte nella nascita – per reazione – delle brigate rosse e delle altre formazioni eversive di sinistra. Nessuno è in prigione per quelle stragi (tranne alcuni estremisti d destra per la strage di Bologna, ma moltissimi esperti ritengono che essi siano innocenti). Con questi misteri l’amnistia non c’entra niente. E probabilmente se ci si decidesse a vararla potrebbe essere un aiuto per riaprire la discussione e la ricerca su quel buco nero della storia italiana.





























































Commenti recenti