Archivio
Rivolta al C.I.E. di Gradisca
Mentre il paese intero si raccoglie nel lutto per i sei soldati morti in Afghanistan, mentre la Croce Rossa piange sulla vernice versata sulla facciata della sede di Roma, scoppia una rivolta nel Cie di Gradisca di Isonzo, provincia di Gorizia. Non sappiamo come sia cominciata, per ora le notizie sono frammentarie e confuse. Quel che è certo è che in una sezione è stato appiccato un incendio, e che la polizia sta picchiando forte chiunque gli capiti sotto tiro. Al momento, si contano almeno 15 feriti tra i reclusi, portati in infermeria sanguinanti.
Ascolta una breve conversazione con un recluso: http://www.autistici.org/macerie/?p=19743
Aggiornamento. Piano piano stiamo riuscendo a ricostruire la dinamica di questa rivolta.

In foto la sede della Croce di Rossa di Roma, attaccata da lanciatori di palloncini ed escrementi questa mattina. La Croce Rossa è complice nella gestione dei Centri di identificazione ed Espulsione
Tutto comincia questa notte, quando in 35 tentano la fuga dal Cie. Purtroppo il tentativo è sventato dalla polizia, che comincia a picchiare brutalmente i fuggiaschi. A questo punto gli altri reclusi, anche chi non aveva partecipato all’evasione fallita, iniziano a protestare e salgono sui tetti, rimanendoci fino alle 6 di questa mattina. Pare che siano anche giunti sul posto dei giornalisti, che forse hanno preferito mantenere il riserbo sulla vicenda (sono sempre giorni di lutto, questi…). All’alba, dietro la promessa della polizia di non fare rappresaglie, i reclusi scendono dai tetti, e la situazione ritorna tranquilla. Fino alle 13, quando scatta una perquisizione. I poliziotti si lasciano andare ad offese pesanti, strappando in due un Corano, e pare che durante il loro passaggio siano spariti anche dei soldi e dei cellulari. Di lì a poco, scoppia la rivolta.
Al momento, e sono le cinque di pomeriggio, la rivolta è ancora in corso. Il numero di feriti è salito a una ventina. La polizia continua a picchiare e tirare lacrimogeni nelle celle. Dall’altro lato, i reclusi tentano di spaccare i lucchetti per arrivare ai poliziotti, “tanto qui siamo morti lo stesso”.
Ascolta una conversazione con un altro recluso http://www.autistici.org/macerie/?p=19743
Un altro aggiornamento. Pare che ora, verso le sette di sera, la situazione sia tornata relativamente tranquilla. Certo bisognerà presto capire la situazione dei feriti, alcuni dei quali sembrano davvero in gravi condizioni.
macerie @ Settembre 21, 2009
PER LE IMMAGINI: UN VIDEO GIRATO DENTRO QUALCHE GIORNO DOPO, PER VEDERE ” I RESTI” DELLA RIVOLTA
Comunicato del comitato d’occupazione 8 Marzo
LIBERTA’ PER LA COMPAGNA E I COMPAGNI ARRESTATI!
NON ABBIAMO NULLA DA NASCONDERE!
NOI NON PAGHIAMO IL PIZZO, NOI LOTTIAMO!
Lunedi 14 settembre 5 compagni di lotta dell’8 Marzo occupata di Magliana
sono stati prelevati dai carabinieri in modo coatto alle ore 4.40 di
mattina e portati a Regina Coeli e a Rebibbia.
Le forze del dis-ordine si sono introdotti con la forza nell’edificio della
ex-scuola che ospita tutti noi: famiglie di sfrattati, precari,
disoccupati; ci hanno costretto a rifugiarci sul tetto per difendere il
nostro spazio.
Ci hanno detto che era solo una perquisizione, ma il modo di agire era
quello di uno sgombero ben organizzato. Non ci sono riusciti e per
ritorsione hanno portato via 5 occupanti. Hanno sfondato le porte della
varie stanze spaventando anche i bambini che sono stati perfino costretti a
saltare il primo giorno di scuola.
Proseguono così il gioco e gli interessi dei consiglieri del Pdl come Luca
Gramazio, Augusto Santori, Luca Malcotti e dei palazzinari romani, in
primis Gaetano Caltagirone e Domenico Bonifici che usano l’arma della
diffamazione mezzo stampa, attraverso “Il Messaggero” e “Il Tempo”
per colpire al fianco un movimento che fa paura a questa classe politica
incapace di risolvere problemi come la casa, il lavoro, la precarietà, il
reddito, e che teme che queste questioni mobilitino lotte generalizzate.
Non abbiamo nulla da nascondere.
Le diffamazioni diffuse da sedicenti giornalisti, che qui non sono mai
venuti a fare un’inchiesta, non ci hanno fatto recedere dalla nostra lotta
perché questa nasce dalla necessità di abitare in una casa e dal
desiderio di un diverso convivere, di riprenderci la vita e non
sopravvivere.
Per questo, in questi due anni di occupazione, abbiamo recuperato uno
spazio pubblico abbandonato al degrado da ben 30 anni, riaprendolo a tutto
il quartiere. E’ così che ci siamo guadagnati la solidarietà degli
abitanti, molti dei quali, oggi sotto sfratto, si sono conquistati, anni fa
e con la lotta, la loro casa.
Gabriele, Francesca, Simone, Sandro e Sandrone devono essere immediatamente
rimessi in libertà, perché l’unica colpa che hanno è quella di essere
lavoratori precari e non potersi permettere di acquistare una casa.
In particolare chiediamo con forza la liberazione di Sandrone, attualmente
recluso presso il centro clinico di Regina Coeli che proprio ieri e’ stato
medicato d’urgenza. Affetto da un tumore per il quale e’ in attesa di un
terzo intervento chirurgico al San Camillo, dovrebbe ricevere a breve
notizie sulla data dell’operazione ma il sequestro del suo cellulare ne
rende difficile, se non impossibile, la reperibilità.
Questi 5 compagni rischiano di dover passare ancora dei giorni privati
della loro libertà personale per un’inchiesta costruita senza nessun
fondamento concreto, tanto che le accuse più gravi sono già cadute così
come cadranno tutte le altre!
GIOVEDÌ 17 ALLE ORE 17.30 A PIAZZA DE ANDRÈ : ASSEMBLEA CITTADINA
VENERDÌ 18 ALLE ORE 17.30 A VIA DELL’IMPRUNETA 51:
CORTEO CITTADINO A MAGLIANA
Per adesioni:
occupa@inventati.org
Comitato d’occupazione 8 Marzo
Ora soluzione politica per i prigionieri politici in Perù…e non solo!
«Ora soluzione politica»
Intervista dal carcere del Callao, dove è sepolto vivo da quasi 20 anni, a Victor Polay, leader dell’Mrta, il Movimento rivoluzionario Túpac Amaru. «La nostra lotta era giusta e non è stata vana. Ma il tempo delle armi è finito: in Perú e in una America latina che va vista con speranza e ottimismo»
Sepolti vivi da molti anni per aver lottato contro una dittatura militare riconosciuta di recente colpevole di aver commesso crimini di stato e di lesa umanità: sono gli ex-guerriglieri peruviani del Mrta (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), gruppo non inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche dall’Unione europea che lo qualifica come «insorgente». Abbiamo intervistato, attraverso i suoi avvocati, il fondatore e leader del Mrta Víctor Polay. Che chiede una campagna internazionale per una soluzione politica.
Era in corso una festa diplomatica quel 17 dicembre 1996 alla residenza di Lima dell’ambasciatore giapponese nel Perú dell’autocrate Alberto Fujimori (ancora enfant gâté degli Usa e dell’occidente), quando 14 guerriglieri del Mrta guidati da Néstor Cerpa Cartolini fecero irruzione prendendo in ostaggio i partecipanti, contro i quali non fu usato alcun tipo di violenza. Gli «emmeretisti» chiedevano la liberazione di 400 prigionieri politici del Movimento, da anni rinchiusi nelle carceri del paese. Al gelo dei 4.000 metri come a Yanamayo o in «celle tomba» come nella base navale del Callao, una specie di «la Guantanamo peruviana». Là erano già rinchiusi, fra i molti altri, il leader supremo di Sendero luminoso, il «presidente Gonzalo» (Abimael Guzman) e l’ideologo e capo politico-militare del Mrta Víctor Polay Campos.
Dopo quattro mesi, nel contesto di un’America latina allora immersa nei governi della destra neo-liberista, tutti i guerriglieri furono uccisi a sangue freddo in un blitz delle forze speciali peruviane. Era il 22 aprile 1997. Dodici anni fa. Un secolo fa. Molto è cambiato in America latina. In Perú non è così.
Nel 2003 la Commissione nazionale per la verità e la riconciliazione ha evidenziato che la guerriglia dei Tupac Amaru si differenziava da quella di Sendero luminoso «per metodi ed obiettivi», perché «rivendicava sempre le sue azioni, si asteneva dall’attaccare le popolazioni inermi, e in alcune occasioni aveva dato segnali di essere aperta a negoziati di pace». Il Mrta, ritenuto dalla stessa Commissione responsabile dell”1.8% delle morti e sparizioni di persona avvenute durante l’intero conflitto armato tra gli anni 1980 e 2000 (contro il 54% causato da Sendero luminoso e il 37% dalle forze armate), ha combattuto contro due dei governi più controversi della storia del paese.
Victor Polay, ora cinquantottenne, ha ormai trascorso in carcere quasi venti anni della sua vita. Si trova nella prigione militare del Callao dal 1993. Dapprima condannato all’ergastolo da un tribunale di giudici «senza volto» (incappucciati per evitare le ritorsioni e poter comminare condanne a mano libera), la sentenza fu poi annullata per la pressione delle organizzazioni internazionali per i diritti umani. Ma un nuovo processo «regolare» nel 2006 lo ha condannato a 32 anni, poi aumentati a 35 anni dalla Corte suprema nel 2008. Anche al resto dei vertici del Mrta sono state aumentate le pene. Per quasi un decennio ha vissuto in condizioni che la Croce rossa internazionale definì «inumane»; secondo la denuncia fatta da sua moglie alla Commissione interamericana dei diritti umani, fu tenuto prima in gelide celle andine dove la temperatura scendeva a zero gradi senza abbigliamento adeguato, poi in celle sotterranee con luce artificiale per 23 ore e mezza al giorno, fra torture e minacce.
Victor Polay ha affidato ai suoi due avvocati le risposte alle nostre domande. Un modo per rompere il silenzio che circonda la sua vicenda e quella dei suoi compagni. E per lanciare quanto meno una campagna, in Perû a America latina, per il trasferimento di Polay e degli altri in un carcere civile.  Di recente l’Unione europea ha rifiutato la richiesta da parte del governo peruviano di inserire il Mrta nella lista delle organizzazioni terroristiche. E il 7 aprile scorso la Corte suprema di giustizia del Perú ha condannato Alberto Fujimori a 25 anni di carcere per aver commesso crimini di stato per violazioni dei diritti umani. Come legge queste due decisioni?
Di recente l’Unione europea ha rifiutato la richiesta da parte del governo peruviano di inserire il Mrta nella lista delle organizzazioni terroristiche. E il 7 aprile scorso la Corte suprema di giustizia del Perú ha condannato Alberto Fujimori a 25 anni di carcere per aver commesso crimini di stato per violazioni dei diritti umani. Come legge queste due decisioni?
Esistevano prove schiaccianti e inconfutabili della partecipazione di Fujimori a diversi crimini in cui furono uccisi civili inermi. Certo, è stato solo condannato per omicidio e non per terrorismo di stato come avrebbe dovuto essere. Comunque la Corte ha riconosciuto l’esistenza di una politica generale di guerra sucia, guerra sporca, che violava i diritti umani, organizzata e diretta dal governo ai suoi massimi livelli. Quanto all’Unione europea rispetto al Mrta, oggi mi sembra irrilevante come gli enti internazionali possano considerarlo perché esso non esiste più come organizzazione politico-militare. La destra del Perú grida allo scandalo perché l’Europa non ci ha inseriti fra le organizzazioni terroristiche. Si vuole denigrare per sempre chi ha osato prendere le armi contro un sistema ingiusto: temono che possa fare scuola.
E infatti la Corte suprema del Perú ha aumentato le condanne ai vertici del Mrta…
Esiste nel paese quello che chiamerei un «populismo penale»: far credere che la protesta o i conflitti sociali possano risolversi aumentando le pene. Non è certo un caso: fa parte dell’arsenale ideologico del neo-liberismo che utilizza a questo scopo la quasi totalità dei mezzi di informazione. Prima e durante il nostro processo sono apparse sui giornali valanghe di dichiarazioni, relazioni, articoli molto negativi contro di noi. I giudici devono aver temuto la condanna mediatica. Infliggere la pena massima di 35 anni risponde alla logica del vae victis!
Dopo la caduta di Fujimori, lei e gli altri detenuti politici avete visto un miglioramento delle condizioni carcerarie?
Si è gradualmente ridotto l’isolamento interno dei prigionieri. Oggi le porte delle celle si aprono alle 9 del mattino e si richiudono alle 20. Ma è mantenuto l’isolamento esterno: ad esempio le possibilità di visite sono limitatissime, sono permesse solo quelle dei familiari diretti. Io ricevo la visita di mia sorella; mia madre è in cattiva salute e mia moglie e i miei figli vivono in Francia come rifugiati. Inoltre trovandomi in un carcere militare ci sono restrizioni aggiuntive. Infine, mentre generalmente con il trascorrere degli anni vengono concessi benefici, il mio status carcerario è sempre lo stesso. Il mio mondo si riduce a mia sorella e ad altri tre prigionieri.
Alla luce della condanna di Fujimori, crede che il paese sia pronto per un’amnistia per i prigionieri politici come lei e i suoi compagni?
Nei quasi 200 anni di storia repubblicana le amnistie sono state un modo per arrivare alla riconciliazione dopo un conflitto armato interno. Accadde con i rivoluzionari apristi nel 1932 e nel 1948 e poi con i guerriglieri negli anni ’60. Oggi il problema è principalmente politico. C’è bisogno di una campagna molto forte affinché l’opinione pubblica nazionale e internazionale possa esercitare la pressione necessaria per una soluzione politica del conflitto. E’ giunto il momento di prospettare questo al paese perché sono sicuro che noi che fummo capaci di affidare le nostre vite a un ideale di giustizia, nelle condizioni attuali del Perú possiamo contribuire alla costruzione di una società più solidale e meno ingiusta, senza l’uso delle armi. Al paese non basta una democrazia formale, ha bisogno di una vera democrazia, economica, sociale e partecipativa. Centinaia di prigionieri dell’ex Mrta che hanno ottenuto la libertà si stanno rifacendo una vita, stanno risolvendo i loro problemi di sopravvivenza, studio, familiari ecc. Non è facile, dopo 10-15 anni di prigione. I reazionari li vorrebbero in ginocchio, e dimentichi del loro anelito di giustizia sociale. Ma questo è impossibile per chi ha affidato la propria vita a un ideale. E poi, nonostante tutte le campagne di demonizzazione contro di noi, il popolo conserva rispetto e affetto per chi ha combattuto con coerenza e non si è sottomesso alla dittatura.
E quanto alla reintegrazione degli ex Mrta nella vita politica del paese? Lei ha affermato davanti alla Comissione per la verità e riconciliazione che la lotta armata non è più la soluzione per risolvere i problemi del popolo.
Purtroppo molte delle cause che avevano provocato la nostra lotta armata sono tuttora presenti nel mio paese. La crescita economica non ha portato sviluppo sociale. Il modello neo-liberista basato sulla manodopera a basso prezzo, sullo sfruttamento delle materie prime e sull’export continua a rendere i ricchi più ricchi e perpetua l’esclusione delle maggioranze. Il compito odierno è formare una forza sociale e politica capace di sviluppare un programma di trasformazione. Oggi molti membri dell’ex Mrta, insieme a nuove generazioni di militanti, stanno organizzando il Movimiento Patria Libre, che intende partecipare alla lotta politica e alle prossime elezioni nel 2011. Chiedo solo che non siano perseguitati come sta succedendo: le libertà democratiche non possono essere a geometria variabile. La democrazia è per tutte e tutti.
Dal Callao, che speranze ripone nel processo in corso in America latina, dove paesi come Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba propongono un altro modello di organizzazione sociale, di giustizia ecologica interna e internazionale, un modello dove gli ideali e le conoscenze indigene sono essenziali?
Governi come quelli citati stanno dimostrando che un altro mondo è possibile insieme ai lavoratori delle campagne e delle città, alle donne, ai popoli indigeni, alle minoranze, agli ambientalisti, ai dimenticati. Sono un punto di riferimento di un movimento che avanza impetuosamente alla conquista dei diritti storici.
Con l’occupazione dell’ambasciata giapponese oltre dieci anni fa il Mrta cercò di parlare al mondo. Nessuno ascoltò. Ora sarebbe diverso? E quale sarebbe il messaggio?
La condanna penale di Fujimori ha dimostrato che la guerriglia del Mrta era giusta. Oggi darei un messaggio di ottimismo e speranza perché gli anni peggiori della repressione sono passati. Retrospettivamente, gli anni della lotta dei nostri popoli, degli uomini e delle donne per la liberazione non sembrano passati invano. I loro sogni vivono in nuove braccia che si stanno alzando in America latina e anche in Perú.
di Marinella Correggia e Annalisa Melandri , Il Manifesto 10 settembre 2009
Alle donne argentine, e ai loro bimbi nati in cattività…
 “Arrivarono alle 3 del mattino. Aprii la porta, tentai di accendere la luce. Mi colpirono. Erano incappucciati. Mi caricarono su un’auto, scalza e bendata. Mi portarono al “Famaillà”, un centro di detenzione clandestino. Mi legarono le mani dietro la schiena e mi buttarono per terra. Ero incinta di quattro mesi. Poi vennero a prendermi per interrogarmi. Mi torturarono. Impazzivo all’idea di perdere il bambino. Provavo odio e un senso di impotenza, avrei voluto urlargli lo schifo che sentivo per loro, ma non potevo. Dopo una settimana mi trasferirono in un altro campo di concentramento, il “Fronteirita”. Lì continuarono a torturarmi. Mi picchiavano soprattutto sul ventre, volevano a tutti i costi farmi perdere il bambino. Stavo malissimo, non facevano che minacciare di uccidermi, mi umiliavano. Giorno e notte sentivo i lamenti di altre persone sotto tortura. Al sesto mese di gravidanza fui trasferita al carcere di Villa Urquiza. Quando venne il momento del parto, non mi portarono in maternità: mio figlio nacque in cella grazie all’aiuto di alcune compagne. Inés recise il cordone ombelicale con un paio di forbici arrugginite. Appena iniziarono le doglie, implorai che per favore mi portassero in maternità. Ma niente. Venne la levatrice e mi fece un’iniezione per addormentarmi. Se non fosse stato per le compagne che lo estrassero a forza, mio figlio sarebbe morto soffocato. Questione di qualche minuto.” HORTENSIA
“Arrivarono alle 3 del mattino. Aprii la porta, tentai di accendere la luce. Mi colpirono. Erano incappucciati. Mi caricarono su un’auto, scalza e bendata. Mi portarono al “Famaillà”, un centro di detenzione clandestino. Mi legarono le mani dietro la schiena e mi buttarono per terra. Ero incinta di quattro mesi. Poi vennero a prendermi per interrogarmi. Mi torturarono. Impazzivo all’idea di perdere il bambino. Provavo odio e un senso di impotenza, avrei voluto urlargli lo schifo che sentivo per loro, ma non potevo. Dopo una settimana mi trasferirono in un altro campo di concentramento, il “Fronteirita”. Lì continuarono a torturarmi. Mi picchiavano soprattutto sul ventre, volevano a tutti i costi farmi perdere il bambino. Stavo malissimo, non facevano che minacciare di uccidermi, mi umiliavano. Giorno e notte sentivo i lamenti di altre persone sotto tortura. Al sesto mese di gravidanza fui trasferita al carcere di Villa Urquiza. Quando venne il momento del parto, non mi portarono in maternità: mio figlio nacque in cella grazie all’aiuto di alcune compagne. Inés recise il cordone ombelicale con un paio di forbici arrugginite. Appena iniziarono le doglie, implorai che per favore mi portassero in maternità. Ma niente. Venne la levatrice e mi fece un’iniezione per addormentarmi. Se non fosse stato per le compagne che lo estrassero a forza, mio figlio sarebbe morto soffocato. Questione di qualche minuto.” HORTENSIA
QUESTE RIGHE agghiaccianti sono tratte da un libro MEMORIA DEL BUIO estremamente interessante, malgrado la sua lettura sia difficile per il dolore e la rabbia che si prova, riga dopo riga. E’ un libro documento, un racconto corale di 112 donne argentine che hanno vissuto insieme l’esperienza della prigionia nelle carceri argentine durante la dittatura, fra il 1974 e il 1983.
Poche ore alla sentenza Battisti
 Si è aperto poche ore fa il dibattimento sul caso Cesare Battisti a Brasilia, di fronte al Supremo Tribunale del Brasile (STF) che dee pronunciarsi sul ricorso presentato dall’Italia contro la concessione dell’asilo politico all’ex militante dei PAC (proletari armati per il comunismo) per cui è stata invece chiesta l’estradizione. Cesare non è presente in aula, al contrario di un rappresentante del ministero di Grazia e Giustizia italiano, Italo Ormanni e l’ambasciatore italiano a Brasilia Gherardo La Francesca.
Si è aperto poche ore fa il dibattimento sul caso Cesare Battisti a Brasilia, di fronte al Supremo Tribunale del Brasile (STF) che dee pronunciarsi sul ricorso presentato dall’Italia contro la concessione dell’asilo politico all’ex militante dei PAC (proletari armati per il comunismo) per cui è stata invece chiesta l’estradizione. Cesare non è presente in aula, al contrario di un rappresentante del ministero di Grazia e Giustizia italiano, Italo Ormanni e l’ambasciatore italiano a Brasilia Gherardo La Francesca.
Il ministro della giustizia Tarso Gendro ha ribadito questa mattina la sua posizione a riguardo, augurandosi che sia mantenuta la giurisprudenza in vigore, sulla quale lui aveva basato la concessione dell’asilo politico.
Cosa che ci auguriamo tutti… anche il Procuratore generale del Brasile, Roberto Gurgel, ha affermato che la decisione del ministro della Giustizia Genro di concedere l’asilo politico a Battisti «è fondata sulla Costituzione, le leggi e i trattati internazionali».
IN BOCCA AL LUPO!
Lettera dal lager di Ponte Galeria…
«Quando sono entrato qui mi hanno detto che dovevo stare tranquillo, che qui ero libero… Ho visto la Croce Rossa e mi sono detto: “meno male, almeno non vedo la polizia intorno”. Invece mi sono sbagliato tanto, mi sono sbagliato tanto a pensare così…
La Croce Rossa mi ha dato un paio di ciabatte, un paio di lenzuola di carta di quelle che si usano sui treni, quelle usa e getta. Mi ha aperto un cancello e… lunghe sbarre, lunghe sbarre alte quattro metri. Tutto a sbarre. Avete presente gli zoo, come sono divisi gli animali? Una gabbia sono negri, una gabbia sono arabi, una gabbia sono del Bangladesh, una gabbia sono indiani, una gabbia sono europei… Da lontano ho visto i militari, e come girano intorno coi mezzi che usano lì in Afghanistan – armati! Subito mi sono reso conto che mi hanno detto una bugia, che non ero libero io: una persona chiusa in una gabbia 16 per 20 non può essere libera, non può essere libera!
 Qui non c’è la vita, non si può vivere così: ci danno il vitto solo per tenerci in vita. Sapete come ci sentiamo, sapete come ci sentiamo noi? Persone sequestrate! Una cosa è sentirla – vedete, mi viene la pelle d’oca – e un’altra cosa è trovarsi solo cinque minuti in una gabbia… e no, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, sei mesi… E intorno a noi girono militari che sono tornati dall’Afghanistan. Vigili urbani, Polizia, Finanza, Carabinieri, Polizia stradale, militari… tutte le divise abbiamo qua. E in più abbiamo la Croce Rossa: per me il nome della Croce Rossa è infangato, infamato!, perché sotto le divise della Croce Rossa si nascondono gli ex militari. E questo lo posso confermare davanti a tutti, anche davanti al Presidente della Repubblica.
Qui non c’è la vita, non si può vivere così: ci danno il vitto solo per tenerci in vita. Sapete come ci sentiamo, sapete come ci sentiamo noi? Persone sequestrate! Una cosa è sentirla – vedete, mi viene la pelle d’oca – e un’altra cosa è trovarsi solo cinque minuti in una gabbia… e no, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, sei mesi… E intorno a noi girono militari che sono tornati dall’Afghanistan. Vigili urbani, Polizia, Finanza, Carabinieri, Polizia stradale, militari… tutte le divise abbiamo qua. E in più abbiamo la Croce Rossa: per me il nome della Croce Rossa è infangato, infamato!, perché sotto le divise della Croce Rossa si nascondono gli ex militari. E questo lo posso confermare davanti a tutti, anche davanti al Presidente della Repubblica.
Qui non è come fosse Guantanamo: è Guantanamo. È Guantanamo. È Guantanamo del signor Berlusconi, del signor Bossi, del signor Maroni, del signor Fini, del signor Casini e del signor Calderoli. Noi vogliamo che nostra voce si senta da qua a tutto il mondo come si è sentita per Guantanamo.Trasmettetela e ve ne saremo molto grati: le nostre sofferenze qua non si possono descrivere. Non si possono descrivere, non si possono descrivere…» Ponte Galeria, Roma, 30 agosto 2009
La teoria e la pratica della “detenzione amministrativa” in undici minuti di intervista: QUI
(Sono giornate agitate, queste, a Ponte Galeria. Aumenta la sofferenza ed aumenta la voglia di urlare. Un recluso oggi si è sentito male ed è stato portato via, un altro ha inghiottito due pile e non l’hanno portato in ospedale perché avevano paura che scappasse. Tra l’urlo e la lotta, forse, ancora qualche giorno.)
macerie @ Agosto 31, 2009
Si scioglie il planton Molino de Flores
All’Altra Campagna
Alle organizzazioni, ai popoli, ai collettivi e alle individualita’.
Compagne, compagni.
Come tutt* sapete, a partire dalla repressione del 3 e 4 maggio 2006 a Texcoco ed Atenco da parte dei tre livelli di governo rappresentati dai tre principali partiti politici (PRI, PAN, PRD) contro gli uomini e le donne che lottavano per il proprio diritto al lavoro e contro le organizzazioni solidali, l’Altra Campagna ha intrapreso una serie di azioni e mobilitazioni in varie citta’ del Messico e del mondo per esigire la liberta’ di tutt* i/le prigionier*.
Una di queste azioni e’ stata quella di stabilirci in pianta stabile di fronte alle porte del penitenziario dove si trovavano imprigionati i/le nostr* compagn*, prima a Santiaguito e a partire dal maggio 2007 a Molino de Flores, assumendoci in questo modo la priorita’ di accompagnarli politicamente.
Questo e’ stato un modo di esigere la loro liberta’, e di dargli, nella misura possibile, inizialmente appoggio economico e successivamente, per alcuni prigionieri, del materiale per lavorare; e in maniera costante appoggio materiale (beni di prima necessita’, schede telefoniche), cosi’ come il sostegno alla lotta giuridica dei compagni del Collettivo Avvocati Zapatisti.
Allo stesso tempo come movimento, organizzazioni, collettivi, villaggi, popoli ed individualita’ ci siamo assunti questa responsabilita’ aderendo alla Sesta Dichiarazione della Selva Lacandona, mano nella mano in una lotta grande ed ardua quale e’ quella di cambiare la realta’, trasformare le nostre vite e costruire un mondo che sia nostro, di tutti/e.
Crediamo che sia importante non dimenticare nessuno di questi due aspetti, e che uno non faccia dimenticare l’altro, perche’ i signori del potere e del denaro cercano distruggerci con le carceri, riempiendoci di paura ed togliendoci la memoria, strozzando le idee e le lotte.
E’ proprio qui che si da l’importanza di non permettere che il carcere divori i/le nostr* compagn*, sapendo che fuori delle sue mura ci siamo noi stess*, in lotta per la liberta’ dei/lle prigionier* e dei popoli.
Durante il processo di lotta, vari/e compagn* hanno ottenuto la liberta’, principalmente i militanti dell’Altra Campagna, e sono rimasti rinchiusi a Molino de Flores i compagni non interni al movimento.
Di conseguenza il Planton ha discusso e deciso di continuare con la sua azione, dato che questa è una lotta per la liberta’ di tutti i nostri compagni e pensiamo che tutte le persone arrestate quel giorno siano tali, perche’ arrestati per una azione politica e catturati durante la repressione contro il nostro movimento.
Con il tempo pero’ ci siamo resi conto che uno dei nostri principali errori e’ stato quello di non aver cercato di concretizzare una relazione politica con i compagni non militanti, errore a cui abbiamo cercato di rimediare provando a tessere tale relazione. Questa relazione risultava vitale, dato che senza di essa il Planton perde molto del proprio senso d’essere. Dobbiamo riconoscere che in questo cammino abbiamo commesso molti errori, e questo ha provocato irregolarita’ nella relazione con i compagni prigionieri, ma nonostante cio’ abbiamo sempre cercato di mantenerla viva senza cadere nella trappola concettuale di considerarli “povere vittime della repressione”, ma trattandoli sempre come compagni con cui si puo’ essere o meno d’accordo, senza promettergli piu’ di quello che era nelle nostre possibilita’, senza sopravvalutarli o sottostimarli, cercando di non imporgli le nostre posizioni e richiedendo da parte loro lo stesso atteggiamento nei nostri confronti.
 Questa relazione non è stata intrapresa con tutti i prigionieri, piuttosto con quelli che erano interessati a farlo.
Questa relazione non è stata intrapresa con tutti i prigionieri, piuttosto con quelli che erano interessati a farlo.
Abbiamo continuato a riflettere sul lavoro politico del Planton e sappiamo che sono stati vari gli errori commessi, tuttavia c’è qualcosa di cui siamo sicuri che non sia stato un errore: abbiamo tenuto fede agli impegni presi al nostro meglio, agendo in modo etico secondo le nostre idee e principi politici anche se per molt* questo possa sembrare un errore.
In questo percorso sono stati parecchi i problemi riscontrati e i disaccordi dati dalle posizioni e concezioni di lotta diverse nostre e dei prigionieri, perche’ sebbene rispettiamo le loro idee, difendiamo anche le nostre.
Questo pero’ non e’ mai stato un motivo che ha condizionato il nostro appoggio nei confronti di nessuno dei prigionieri, a prescindere con chi avesse relazioni e sempre senza imporre le nostri posizioni politiche e rispettando le sue.
Tuttavia, a causa di una serie di malintesi e differenze che si sono dati dal mese di aprile di quest’anno si e’ determinato un allentamento di questa relazione tra il presidio ed i prigionieri. Per questo ci siamo cominciati a interrogare sul senso della permanenza del presidio davanti al penitenziario dato che, come gia’ abbiamo menzionato, per noialtri/e e’ vitale avere, fosse anche solo un tentativo, una relazione politica con i prigionieri per i quali stiamo lottando.
Di fronte alle risposte che sono state date a una domanda specifica che abbiamo posto ( “Volete mantenere un rapporto con il presidio?” ) e’iniziata una riflessione da parte delle organizzazioni presenti al Planton come l’UNIOS, il FPFVI-UNOPII e la Commissione Sesta dell’EZLN, cosi’ come dei/delle compagn* che hanno attraversato questo spazio.
A partire da questo bilancio fatto separatamente è stata presa una decisione congiunta sul fatto che fosse giunto il momento di smobilitare il presidio e promuovere altri spazi di lotta per tutti/e i/le nostri/e prigionieri/e.
In tal senso si e’ deciso di smontare il Planton Molino de Flores il prossimo 30 agosto, senza che questo significhi l’abbandono della lotta per la liberta’ che abbiamo condotto con l’Altra Campagna nei vari stati del paese e nelle differenti citta’ del mondo.
Per piu’ di 3 anni ci siamo sostenuti fuori il carcere, prima a Santiaguito, poi a Molino de Flores, prendendoci l’impegno con l’Altra Campagna di non smettere di lottare per la liberta’ dei nostri compagni. 
Il Planton non e’ stata l’azione di un gruppo di compagn*, ma un’azione condivisa realizzata da tutt* quell* che hanno partecipato con le loro differenti forme di solidarieta’: partecipando al presidio, inviando viveri, appoggiando le attivita’ di raccolta fondi per obiettivi specifici, promuovendo azioni per la liberta’ nei propri territori. Quest’azione è stata realizzata dall’Altra Campagna, non senza errori, non senza inciampare, pero’ siamo sicuri che questo camminare insieme ci abbia aiutato nella lotta e nel portarla a termine ogni volta in modo migliore.
Con l’annuncio in cui i compagni direttamente coinvolti nel mantenimento del Planton hanno deciso di terminare quest’azione, annunciamo anche la conclusione degli ultimi appelli e campagne economiche con cui si sono comprate le tele del presidio e si e’ sostenuto il lavoro legale degli avvocati nella realizzazione del ricorso contro la sentenza dei nove compagni prigionieri a Molino de Flores e del compagno Ignacio del Valle, detenuto nel carcere di massima sicurezza del Altiplano.
Riguardo ciò ricordiamo che si e’ deciso di sostenere il Collettivo Avvocati Zapatisti (CAZ), come sempre abbiamo fatto, essendo il loro lavoro realizzato in solidarietà e senza lucro: al CAZ abbiamo consegnato un contributo economico affinche’ intraprendano il ricorso per i 7 compagni che rappresentano.
Allo stesso modo si e’ deciso di appoggiare con la stessa somma gli altri due compagni che non sono difesi dal CAZ, consegnando il denaro direttamente alle rispettive famiglie; la stessa cifra e’ stata versata anche alla famiglia del compagno Ignacio del Valle per il suo ricorso.
Smantellando il presidio il 30 agosto di quest’anno smetteranno di apparire convocazioni e campagne a nostro nome, cosi’ come consideriamo conclusi i nostri impegni presi con i prigionieri in quanto Planton: a questi impegni cercheremo di dare seguito come Altra Campagna.
Compagn*, con queste parole oltre che informarvi della decisone di smontare questo spazio che abbiamo mantenuto per tutto questo tempo, vogliamo invitarvi a continuare la lotta per tutt* i/le nostr* prigionier*, a costruire e rafforzare spazi e sforzi diretti a questa lotta.
 Abbiamo sempre creduto che la forma di ottenere la liberta’ dei compagni sia quella della mobilitazione, del lavoro nelle strade, nelle scuole, nei quartieri etc, e che il presidio in questo senso sia solo una delle tante azioni che si realizzano come Altra Campagna: la lotta va molto oltre l’esistenza del Planton stesso, e’ un arduo lavoro che come militanti ci e’ toccato, quello di non smettere di lottare per la liberta’ dei prigionieri, senza dimenticare le lotte di ognun@.
Abbiamo sempre creduto che la forma di ottenere la liberta’ dei compagni sia quella della mobilitazione, del lavoro nelle strade, nelle scuole, nei quartieri etc, e che il presidio in questo senso sia solo una delle tante azioni che si realizzano come Altra Campagna: la lotta va molto oltre l’esistenza del Planton stesso, e’ un arduo lavoro che come militanti ci e’ toccato, quello di non smettere di lottare per la liberta’ dei prigionieri, senza dimenticare le lotte di ognun@.
A riguardo sentiamo il bisogno di costruire spazi di lotta per la liberta’ dei/lle nostri/e prigionieri/e, non solo per i giorni del 3 e 4 maggio 2006, ma per tutt* i/le compagn* detenut* nei diversi luoghi del paese: i compagni incarcerati in Chiapas, Oaxaca, Campeche, Veracruz, stato del Mexico, in ogni angolo di questa terra. Spazi che non permettano l’oblio, dove ci organizziamo nei distinti luoghi per continuare la lotta per i/le nostr* compagn*.
Sappiamo che esistono sforzi diretti a questo fine, compagn* che hanno intrapreso queste lotte; la necessita’ di intrecciarle e’ costante, per cui, stiamo tentando di costruire uno spazio che le accolga, cercando di costruirlo allargato, dentro i parametri della Sesta Dichiarazione della Selva Lacandona e dell’Altra Campagna, coordinandoci per portare a termine azioni ed attivita’ per la liberazione dei/lle nsotr* prigionier*, cosi’ come per creare e rafforzare dinamiche antirepressive.
E’ per questo che stiamo convocando gli/le aderenti alla Sesta e all’Altra Campagna a una serie di riunioni dalla fine delmese scorso che si stanno realizzando nel locale di UNIOS (Dr Carmona y Valle #32, a un isolato dal metro Cuahutemoc) e che continueremo a realizzare sperando che ogni volta siano sempre di piu’ i/le compagn* che vogliano costruire insieme questo sforzo che ci portera’ a proseguire la lotta per la liberta’ di tutt* i/le nostr* prigionier*.
Compagn*: a tutti quelli che ci hanno accompagnato per tutto questo tempo, sia da vicino che da lontano, rompendo le distanze con la solidarieta’, a tutti quelli che ci hanno accompagnato in quest’azione in un modo o nell’altro, non ci resta altro che ringraziarvi e dirvi che e’ stato un piacere enorme ed un onore avervi con noi, condividendo quest’iniziativa.
A coloro che non sono mai potuti venire vogliamo dire che nonostante le distanze la solidarieta’ ci unisce, facendoci sentire vicini e rompendo le leggi della fisica, lottando, costruendo e sognando, e che la distanza non e’ una barriera quando esiste la solidarieta’. A quelli che ci hanno sostenuto in uno e mille modi, sappiate che la vostra solidarieta’ e’ stata per noi una presenza e che e’ stata usata come di dovere.
Sappiate, compagn*, che ci sentiamo soddisfatt* di questa azione, di voi, di noi, e che gli errori che abbiamo commesso ci aiuteranno a camminare e lottare fino ad ottenere la liberta’ dei/lle nostr* compagn*, ed ad ottenere la trasformazione del mondo.
Sappiamo e facciamo nostre le decisioni, gli errori e le soluzioni. Li facciamo nostri perche’ sono il risultato delle nostre decisioni e posizioni, che magari a molti non sono piaciute. Sappiamo che ci hanno criticato e che continueranno a farlo; a quelli che l’hanno fatto da compagn* diciamo che la loro parola e’ stata ricevuta come un abbraccio.
Allo stesso tempo vi invitiamo a partecipare al Planton Molino de Flores il giorno 29 agosto dalla mattina, visto che realizzeremo un evento politico e culturale sulla lotta del Planton, a partire dalle 11 am, cosi’ come parte dell’inizio di queste attivita’ e questa campagna per i/le nostr* compagn*; allo stesso tempo vi invitiamo lo stesso giorno a cominciare a smontare il presidio fino al 30 agosto.
Planton Molino de Flores
Per la liberta’ dei/lle prigionier* politic*!
Stop alla persecuzione delle Comunita’ Autonome Zapatiste!
Prima di tutto… i/le nostr* prigionier*!
Tradotto da Nodo Solidale
Indulto e crollo della recidiva: una lezione che non piace a Marco Travaglio
 Oggi a pagina 6 di liberazione Paolo Persichetti fa un riassunto ottimo e velenoso sulla rivolta che sta infiammando ( in tutti i sensi ) la maggior parte delle carceri italiane, sovraffollate, indecenti, lontane dall’immaginario della vivibilità.
Oggi a pagina 6 di liberazione Paolo Persichetti fa un riassunto ottimo e velenoso sulla rivolta che sta infiammando ( in tutti i sensi ) la maggior parte delle carceri italiane, sovraffollate, indecenti, lontane dall’immaginario della vivibilità.
Ieri un suicidio, diversi incendi appiccati da detenuti stremati dalle condizione di vita imposte, un detenuto che si è cucito le labbra per ottenere una cosa che gli spettava per legge, l’acqua che manca al Don Bosco di Pisa … insomma: i gironi danteschi all’ordine del giorno.
Non pubblico interamente l’articolo con l’elenco del bollettino di guerra perchè proverò a fare una panoramica un po’ più tardi…
metto però, ASSOLUTAMENTE, l’ultima parte dell’articolo, perché focalizza la sua attenzione su uno dei personaggi che più disprezzo nel panorama italiano, della destra italiana: Marco Travaglio, qui giustamente soprannominato Don Manetta.
E’ un commento, breve perché sarebbe uno spreco allungarlo, delle righe apparse sull’Espresso a firma di questo questurino mancato che commentavano -ancora!- l’indulto.
Lascio le parole alla firma dell’articolo…buona lettura 😉
Ci mancava proprio lui, don Manetta. La calura ci aveva liberato per un po’ dalle sue requisitorie.
Marco Travaglio è tornato a prendersela con l’indulto. Sull’Espresso (20 agosto) definisce un «presunto ragionamento portentoso» l’analisi dei dati della ricerca di Giovanni Torrente, dell’università di Torino, che hanno dimostrato come indulto, benefici e misure alternative, abbiano abbattuto la recidiva delittuosa. Insomma fatto calare i reati. Una cocente sconfitta per i giustizialisti della sua risma.
A Travaglio i numeri non piacciono. Li preferisce solo se declinati in anni di galera, altrimenti adora le parole, ma solo dei pentiti, soprattutto se de relato. È uno da buco della serratura che si trastulla con le intercettazioni telefoniche. Per il pubblico ministero d’Italia, se la recidiva è crollata è solo perché i furfanti non sono stati ancora presi. Aspettate e vedrete, dice. Un vero puzzone, uno di quelli che pur di non starci è disposto a fare carte false.
Caro dottor Manetta a essere calati sono i fatti-reato. Se ci sono meno denunce vuole dire che ci sono stati meno delitti, non meno persone arrestate. Anzi quelle aumentano per effetto di leggi che puniscono l’uso di droghe e la migrazione clandestina. Così le carceri scoppiano.
Ci sono due cose che Travaglio non capirà mai: la prima è che solo a metà degli anni 70 l’Italia tocca il suo minimo storico di detenuti. Quando la gente ha una speranza e lotta, non ruba. La seconda è che la pensa come Martelli e Craxi, che per primi introdussero la politica della tolleranza zero.
Nelle carceri è rivolta: “Amnistia”!
Dopo la prigione di Lucca, fuochi e tumulti al Bassone di Como e Solliciano
Paolo Persichetti, Liberazione 19 agosto 2009
Al calar della sera si sono accesi i primi bagliori di rivolta. È successo lunedì scorso, nemmeno 24 ore dopo la più grande visita parlamentare mai avvenuta nelle carceri italiane dal dopoguerra. Prima nella casa circondariale Bassone di Como, poi in quella di Sollicciano a Firenze. Ieri è stato il turno di Capanne, il penitenziario di Perugia. È allarme generale ma non una sorpresa: «Da giorni, settimane, mesi ripetiamo che la situazione penitenziaria del Paese, a causa del costante sovraffollamento, è ogni giorno sempre più critica», ha ribadito in un comunicato il segretario del Sappe, una delle maggiori sigle sindacali della polizia penitenziaria. L’incendio scoppiato all’interno di una cella del carcere di Capanne ha richiesto l’intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ad appiccare le fiamme sarebbero stati alcuni detenuti. A quanto pare l’episodio sarebbe circoscritto, a differenza di quanto è invece accaduto a Sollicciano tra le 23 e l’una di notte di lunedì. La battitura delle inferiate, programmata dai detenuti per dare voce alla protesta contro il sovraffollamento e rivendicare l’amnistia, si è rapidamente trasformata in una mezza sommossa.
Per far sentire oltre le mura il respiro affannato di chi è rinchiuso, l’impasto di sudore e afa, le brande infuocate, l’aria densa e immobile che affoga gli spazzi stracolmi delle celle, i detenuti hanno deciso la protesta del rumore, una delle più classiche e antiche manifestazioni che danno voce al mondo dei rinchiusi. Una battitura ritmica delle inferiate realizzata con pentole, coperchi, bombolette del gas vuote, sgabelli e quant’altro si può percuotere contro le sbarre delle finestre o i blindati. Il tutto accompagnato da urla, fischi, slogan in favore dell’amnistia e dell’indulto. Presi dall’adrenalina altri hanno, invece, cominciato a dare fuoco a tutto quello che si poteva incendiare: giornali, lenzuola, stracci da mostrare alla città. No, non c’era nessun piano, nessun complotto in una situazione dove spesso manca la stessa grammatica per organizzare una protesta. Solo disperazione, tanta rabbia che esplode e accende gli animi. Provate voi a stare accatastati in quel modo, in pochi metri quadrati anche solo per qualche giorno. 950 persone rinchiuse in una struttura che ha una capienza massima di 400. In quelle stanze non circola aria ma grisù. Basta un nulla che prende fuoco. Lo sanno gli agenti di custodia, e lo dicono ormai da diverso tempo. Lo sanno i direttori degli Istituti, lo sanno i dirigenti del Dap.
Lo sa il ministro Alfano. Lo sanno tutti. E sanno anche qual’è l’unica soluzione. Ma fino ad oggi hanno deciso di fare finta di nulla accampando un piano carceri che, anche se solo riuscisse a decollare in parte dopo i tanti rinvii, non risolverebbe nulla se non gonfiare i portafogli di quegli imprenditori che avranno gli appalti. A Sollicciano lunedì sera la tensione è salita alle stelle. Le cronache raccontano l’attivazione di un immediato piano sicurezza. La casa circondariale è stata subito circondata da gazzelle del nucleo radiomobile dei carabinieri e da agenti delle volanti. Altri rinforzi sono arrivati dal reparto mobile della polizia. Attorno al carcere è stato costituito un fitto cordone di sicurezza, neanche avessero dovuto fare fronte a una guerra civile. Ma forse è un po’ a questa idea che i governanti vogliono prepararci. Già ad ogni crocicchio e semaforo di strada si vedono mimetiche dell’esercito armate di tutto punto. Nell’immediato dopoguerra alcune rivolte esplose in diverse carceri sovraffollate come oggi vennero sedate a colpi di cannone. Ci fu un massacro.
Stiamo attenti, dunque. Per fortuna l’altra sera la situazione si è placata nel giro di alcune ore, la polizia penitenziaria è entrata sezione dopo sezione per spegnere i focolai d’incendio. La protesta è di nuovo ripresa alle 10 e 30 del mattino successivo con una nuova battitura. Il garante per i detenuti Franco Corleone dopo un sopralluogo ha spiegato che le proteste nascono da una somma di carenze, diffuse un po’ ovunque nei penitenziari della penisola, aggravate dall’affollamento: la riduzione dei colloqui con familiari e delle ore di passeggio causa ferie del personale di custodia, la mancanza di docce, l’impossibilità di avere visite mediche rapide, sommata alla mancanza di spazi, l’impossibilità di lavorare o svolgere attività, la sordità delle magistrature di sorveglianza che negano i benefici penitenziari. Non stupisce allora se anche a Como, una delle strutture penitenziarie più degradate d’Italia, la protesta è durata tre giorni. Dalla battitura iniziale e lo sciopero della fame intrapreso da alcuni, si è passati nei giorni successivi all’esplosione delle bombolette di gas in dotazione per i fornellini da cucina fino alla rottura dei neon delle celle col tentativo di provocare cortocircuiti, almeno secondo quanto riferito da un esponente della Uil penitenziaria.
Angelo Urso, in una nota ha ricordato come nel carcere di Como «in questi anni non sono mai stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Pertanto la fatiscenza e l’insalubrità dei locali non può che aggravare la condizioni detentive». Qualcosa di simile era già accaduto nella prigione di Lucca nei primi giorni di agosto. Anche lì, una protesta dimostrativa si era trasformata in un piccolo tumulto con il lancio di bombolette e focolai d’incendio nelle sezioni. Insomma si assiste ad una fisiologica tendenza all’inasprimento delle forme di lotta conseguenza dell’esasperazione suscitata dalle condizioni d’invivibilità. Nonostante questi ripetuti segnali e i continui appelli lanciati da tutti gli operatori del settore, dal cielo della politica non vengono risposte. Il governo è in vacanza, come i vertici del Dap e del ministero. Intervistato dal Gr della Rai, Ionta ha ribadito le virtù del suo piano straordinario d’edilizia carceraria, senza però indicare date precise sulla sua presentazione. Un’incertezza dietro la quale si nasconde l’assenza di copertura finanziaria e una sostanziale mancanza di credibilità. L’opposizione dovrebbe mobilitarsi con una grande iniziativa politica per impedire che nelle carceri avvengano tragedie. È ora di riaprire la vertenza sull’amnistia
Per ascoltare la battitura dei detenuti del carcere di Sollicciano
L’Italia e le incarcerazioni facili: siamo da Guinness
Dal ‘45 a oggi 4 milioni e mezzo vittime di errori giudiziari. Meno della metà dei detenuti è in carcere per una condanna definitiva. Un terzo è in attesa del processo di primo grado processo
Paolo Persichetti
Liberazione 14 agosto 2009
Dal dopoguerra ad oggi sono circa quattro milioni e mezzo le persone vittime di “errori di giustizia”. All’interno di questa categoria piuttosto ampia rientrano (per una parcentuale molto bassa) gli errori giudiziari classici, quelli cioè che dopo una procedura di revisione del processo danno luogo al riconoscimento dell’errore e dell’ingiusta condanna; i casi di ingiusta detenzione cautelare; ci sono poi i casi di prescrizione ma soprattutto chi ha visto concludersi con un proscioglimento il procedimento penale aperto nei suoi confronti.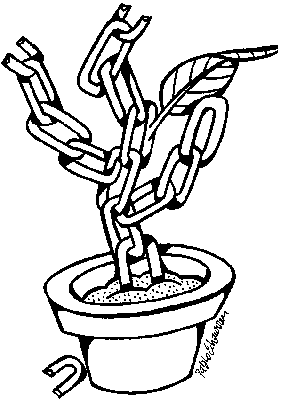
Il numero delle persone coinvolte in queste defaillances della giustizia è pari alla popolazione di un’intera regione. Solo dal 1980 al 1994 quasi un imputato su due è stato prosciolto, oltre un milione e mezzo di cittadini sui tre e mezzo passati davanti ad un giudice. E tra questi ben 313 mila sono finiti prosciolti con formula piena.
Si tratta di una cifra immensa che solleva quello che, a questo punto, è il vero “allarme sicurezza”: il cattivo funzionamento della Giustizia, dell’inchiesta e del processo penale.
Un vero paradosso, se è vero questi dati dimostrano come una delle maggiori fonti di rischio per la libertà viene proprio da quella magistratura che secondo la Costituzione dovrebbe, al contrario, tutelare e garantire la persona.
La casistica degli errori è immmensa, include casi di omonimia, distrazioni, perizie errate, errori di calcolo, ma sarebbe fuorviante restare a quelli che appaiono solo motivi di superficie. Le cause hanno ragioni sistemiche ben più profonde, legate alla funzione svolta dal corpo giudiziario in Italia, al peso delle ripetute emergenze, alla supplenza sistematica assunta dalla magistratura. Modificazioni di natura politica e sistemica a cui si aggiungono anche la tradizionali discriminazioni di natura classista.
In una intervista rilasciata alcuni anni fa, l’allora magistrato istruttore Ferdinando Imposimato metteva l’indice contro il carattere pressoché indiziario che caratterizza gran parte dei procedimenti penali. Avendo lui stesso praticato per decenni questo metodo d’indagine, l’ex giudice riusciva a descriverne molto bene la logica perversa: «troppo spesso – spiegava – le inchieste sono basate su fatti desunti dall’esistenza di altri fatti. In pratica il risultato di una deduzione logica. Terreno ideale per l’errore. Troppo spesso – aggiungeva – l’indizio altro non è che un sospetto tramutatosi troppo velocemente, e che a sua volta finisce ancora più rapidamente per trasformarsi in prova».
Eppure il senso comune, quello che i media raccontano orientando l’opinione pubblica, dicono l’esatto contrario. L’insicurezza, intesa come mera percezione, sensazione sociale, stato d’animo, è in costante aumento; come la convinzione, rilanciata dalla cronaca di questi ultimi giorni, che vi sia in giro troppo lassismo della legge, un dilagare d’impunità garantita e scarcerazioni facili.
Una dettagliata indagine dell’Eurispes, resa nota all’inizio dell’anno, racconta tuttavia una realtà ben diversa. Al 30 giugno 2008, dei 55.057 mila detenuti presenti nelle carceri italiane soltanto 23.243 stavano scontando una sentenza definitiva. Poco più di un terzo. Tutti gli altri, ovvero la maggioranza, erano in attesa di giudizio. Tra questi la quota più alta riguarda coloro che sono ancora in attesa del processo di primo grado, ben 15.961. Il numero di quelli che hanno interposto appello sono, invece, 9.115. I ricorrenti in cassazione 3.451.
Da allora la situazione non è mutata. Secondo gli ultimi rilievi del ministero della Giustizia, ad un anno di distanza, con una popolazione reclusa che è salita a 63.460(20 mila olre la soglia di capienza), i candannati in via definitiva sono 30.186, meno della metà. A questo dato va aggiunto un elemento ulteriore che mette in rilievo la condizione di discriminazione sociale vissuta dai detenuti stranieri, ormai 23.530.
Il 58,75% di questi è in custodia cautelare, mentre gli italiani in carcerazione preventiva sono invece il 43,77% del totale dei connazionali detenuti, ossia circa il 15% in meno degli stranieri. Un altro aspetto da sottolineare è che statisticamente quasi la metà dei detenuti in attesa di primo grado finiranno prosciolti o in prescrizione. Ciò vuol dire che per un’altissima porzione di popolazione penitenziaria la custodia cautelare è un passaggio inutile, oltre che dannoso.
Un altro aspetto da sottolineare è che statisticamente quasi la metà dei detenuti in attesa di primo grado finiranno prosciolti o in prescrizione. Ciò vuol dire che per un’altissima porzione di popolazione penitenziaria la custodia cautelare è un passaggio inutile, oltre che dannoso.
Quest’ultimo dato ribalta completamente l’opinione diffusa di una giustizia dalle “scarcerazioni facili”. Siamo, in realtà, il paese delle incarcerazioni fin troppo facili, dovute ad un sistema penale che nonostante la riforma del codice di procedura del 1989 vede tuttora presente un forte squilibrio in favore della pubblica accusa. Non è un caso se le regioni dove più alta è la percentuale di errore, e maggiore è l’impiego della custodia cautelare, siano quelle meridionali. La legislazione penale speciale applicata contro le forme di criminalità organizzata facendo leva sul reato associativo amplifica il carattere pregiudiziale delle inchieste. Ne consegue che la definizione della responsabilità personale diventa più incerta, mentre il livello di tutela delle garanzie giuridiche si abbassa paurosamente.
Una legge del 1988, contrastata duramente dalla magistratura, ha disciplinato la responsabilità civile dei giudici. Da allora è possibile avviare delle procedure di risarcimento per «ingiusta detenzione». Il legislatore ha affrontato, in modo tuttavia ancora molto insoddisfacente (il testo al momento esclude i ricorsi retroattivi), solo un aspetto del problema. Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste una norma che indennizza “l’ingiusta imputazione”. Incorerre in un procedimento penale, anche quando non si somma all’ingiusta detenzione, risulta in ogni caso estremamente pregiudizievole e oneroso per la persona messa sotto accusa. Oltre al costo umano (morale, esistenziale e economico), gli errori giudiziari hanno un prezzo sociale e erariale importante per la stessa conunità.
Nel corso degli ultimi 5 anni lo Stato ha pagato circa 213 milioni di euro di risarcimento, la quasi totalità per ingiusta detenzione cautelare, molto meno per gli errori giudiziari. I giudici no, non pagano mai. Nel proteggere la loro autonomia, l’ordinamento arriva a tutelare anche le responsabilità più gravi, fino a farne la categoria più impunità in assoluto. Quella che si erge a giudizio degli altri, forte del fatto che non sarà mai giudicata. La commissione disciplinare del Csm altro non è che una commissione di colleghi magistrati. La madre di tutte le caste tutela bene se stessa. A fronte di un numero travolgente di errori, custodie cautelari ingiuste e immotivate, procedimenti penali finiti nel ridicolo di proscioglimenti pieni, sono rarissimi i casi di azioni disciplinari terminate con sanzioni punitive.
In genere la sanzione avviene attraverso una promozione di carriera con uno spostamento in altra sede. Le sanzioni sugli stipendi o i blocchi di carriera sono pressoché inesistenti.
Sprigionare la società, un libro di Alain Brossat
Alain Brossat, Scarcerare la società, Elèuthera 2003
Recensione di Paolo Persichetti , Hortus Musicus 2005
Versione francese
C’è un solo problema filosofico veramente serio, scriveva Camus: «il suicidio». Dal gennaio 2002 al luglio 2003 nelle carceri italiane si sono verificati 83 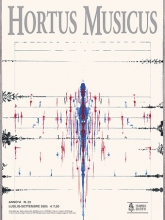 suicidi e 25 tentati suicidi, altri 19 detenuti sono morti per cause non chiarite e 9 per overdose. Totale: 136 morti. E chi non si uccide si ammala: al 30 giugno 2003 – secondo una stima avanzata dal Forum nazionale per la tutela della salute dei detenuti e l’applicazione della riforma della medicina penitenziaria (Manifesto11 marzo 2005) – erano rinchiusi 14.507 tossicodipendenti, circa un terzo dell’intera popolazione carceraria. Tra questi, 1.737 in trattamento metadonico e 887 alcoldipendenti. Gli affetti da Hiv erano 1.473 (il 2,6% del totale), 5.000 i sieropositivi, 9.500 quelli colpiti da epatite cronica e 7.500 i reclusi con turbe psichiatriche. Gli istituti di pena sono oramai enormi lazzaretti, ospizi per derelitti, vaste discariche dove viene confinato ogni dolore e malessere sociale, nelle quali si ammassano umiliati e offesi, vite rottamate, sfigati senza speranza. Immigrati e neolumpen alienati dalla società dei consumi che promette quello stesso benessere che li esclude. Veri e propri sedotti e abbandonati dalle chimere di un capitalismo che li ha relegati ai margini.
suicidi e 25 tentati suicidi, altri 19 detenuti sono morti per cause non chiarite e 9 per overdose. Totale: 136 morti. E chi non si uccide si ammala: al 30 giugno 2003 – secondo una stima avanzata dal Forum nazionale per la tutela della salute dei detenuti e l’applicazione della riforma della medicina penitenziaria (Manifesto11 marzo 2005) – erano rinchiusi 14.507 tossicodipendenti, circa un terzo dell’intera popolazione carceraria. Tra questi, 1.737 in trattamento metadonico e 887 alcoldipendenti. Gli affetti da Hiv erano 1.473 (il 2,6% del totale), 5.000 i sieropositivi, 9.500 quelli colpiti da epatite cronica e 7.500 i reclusi con turbe psichiatriche. Gli istituti di pena sono oramai enormi lazzaretti, ospizi per derelitti, vaste discariche dove viene confinato ogni dolore e malessere sociale, nelle quali si ammassano umiliati e offesi, vite rottamate, sfigati senza speranza. Immigrati e neolumpen alienati dalla società dei consumi che promette quello stesso benessere che li esclude. Veri e propri sedotti e abbandonati dalle chimere di un capitalismo che li ha relegati ai margini.
Nel sistema penitenziario, quelle che con un eufemismo sociologico vengono definite «nuove povertà» ammontano oramai a circa l’80% della popolazione reclusa. Che le prigioni fossero una purulenta sentina della società è stato scritto, detto e ribadito fino alla nausea. Un’ovvietà che suona come una vuota retorica dell’indignazione, non più udibile da chi vi è costretto a trascorrere periodi sempre più lunghi della propria esistenza. La durata della detenzione è aumentata del 50% negli ultimi quindici anni, il tasso di recidiva del 70%. L’area penale è esplosa nel corso del decennio Novanta, la popolazione carceraria è raddoppiata fino a superare le 57 mila unità, a cui vanno sommati quelli che usufruiscono delle misure alternative e scontano la loro pena nel cosiddetto «carcere diffuso» (arresti domiciliari, comunità terapeutiche, affidamento sociale in prova, semilibertà, lavoro esterno), per una somma complessiva che raggiunge le 100 mila persone, in un contesto che vede una media annua di 300 mila condanne penali.
Una parte della popolazione è predestinata a convivere con la reclusione. Guarda caso sempre la stessa: il 30% degli attuali rinchiusi sono stranieri, il 45% proviene dall’Italia meridionale. Il profilo classico è quello del giovane privo d’istruzione e con propensione alla tossicodipendenza. Chi viene dal Sud, non ha titoli di studio, appartiene ai ceti sociali più bassi. Chi arriva dai paesi d’emigrazione, vede aumentare, molto di più che nel passato, la probabilità di finire imprigionato. Il carcere rinvia ad uno degli aspetti più crudi della discriminazione di classe ed il richiamo alla legalità è la macchina ideologica che legittima e riproduce questa dominazione.
Nuove tecnologie della pena
Contrariamente a quanto sancito dall’art.27 della Costituzione, la pena non esercita alcuna funzione rieducativa. Mai auspicio è risultato più risibile. L’ambigua e rachitica normativa varata nei flebili anni dell’ammodernamento penitenziario di marca catto-comunista, la cosiddetta legge Gozzini, è di fatto disapplicata ed elusa. Quella riforma era viziata fin dalle origini da un’insanabile contraddizione interna, poiché l’apertura verso le nuove politiche penitenziarie, mirate al parziale reinserimento e alla ricostruzione sociale del sanzionato, seguì in parallelo il dispiegamento delle politiche differenziali dell’emergenza, trasfigurando il carcere in una sorta di commedia dantesca, dove l’inferno della differenziazione e della specialità sprofondava in gironi spettrali, all’infuori dei quali permanevano limbi, terre di nessuno, zone detentive che presagivano un possibile accesso negli Istituti purgatorio, dove la punizione s’alleviava lasciando intravedere la speranza di salire un domani in paradiso. Una scalata verso la redenzione, possibile solo dopo aver mostrato attiva cooperazione alla propria punizione, attraverso un dispositivo d’interiorizzazione della colpa che ha integrato alle tradizionali discipline di sorveglianza e controllo una nuova tecnologia fondata sull’adesione alla pena da parte del recluso. La politica carceraria non si è più accontentata di una puntigliosa presa in carico dei corpi (prehendere, prisio, prisum), ma ha scoperto «le virtù dell’uso mediatore della parola». Nel corso di alcuni incontri il detenuto è sollecitato a «fare il punto» sulla situazione, sull’evoluzione della percezione che ha dei suoi delitti e dei suoi crimini, sui suoi progetti per l’avvenire. Ad avvalersi di queste nuove strategie trattamentali sono stati quei reclusi in possesso di un maggiore capitale culturale, di una più alta perspicacia nell’uso della parola e di una superiore scaltrezza strategica, che consente loro di destreggiarsi con gli operatori trattamentali (educatori, psicologi, assistenti sociali) e il magistrato di sorveglianza, a scapito degli altri del tutto incapaci e abbandonati a se stessi, doppiamente discriminati da quegli handicap sociali e culturali che ne hanno facilitato prima l’ingresso in carcere e poi la reclusione perpetua, escludendoli una seconda volta con politiche trattamentali inaccessibili.
La successiva involuzione politica intervenuta nel corso del decennio Novanta ha reso questa critica ai balbettii del riformismo carcerario un lusso superfluo. Il sovraffollamento e le nuove politiche repressive hanno spolpato la Gozzini, introducendo nuove e sempre più articolate eccezioni, moltiplicando i «reati ostativi» (quelli inclusi nel 4 bis) per i quali le misure alternative, oltre ad essere ritardate, vengono rese praticamente impossibili. Gli anni dell’oppio giudiziario e della bulimia penale hanno riportato in auge il principio dell’incompressibilità della pena, una nenia che ha cullato le nuove generazioni di giudici di sorveglianza. E così il carcere è tornato a svolgere, anche nei discorsi degli specialisti della correzione, quella cruda funzione sociale per cui era nato.
Il «sentimento d’insicurezza»
Il carcere non redime, la prigione non corregge, serve solo a confinare dietro spesse mura di cinta problemi e contraddizioni che l’ipocrisia collettiva preferisce rimuovere. L’economia del castigo è ormai diventata una «tecnica d’invisibilizzazione dei problemi sociali». Siamo nuovamente di fronte a quell’assunto iniziale duramente combattuto negli anni Settanta: la modernità non ha saputo escogitare altre risposte al delitto diverse dall’internamento. Il carcere è via via emerso come la soluzione più semplice ed economica al disordine sociale diffuso. L’ideologia penitenziaria è così divenuta uno dei pilastri della cultura politica contemporanea che, non riuscendo più a far vivere la speranza, ha fatto della paura e dell’angoscia uno dei suoi repertori più redditizi, nutrendo la psicologia sociale con gli impulsi più bui dell’animo umano, divenuto ostaggio del risentimento e della vendetta. Questa corrente è descritta da Loïc Wacquant (Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité, Agone, Paris 2004). come un groviglio confuso di sentimenti che intrecciano la paura per l’avvenire, l’ossessione per il declino sociale e l’angoscia di non poter trasmettere il proprio status sociale ai figli, a causa di una competizione per titoli e posti sempre più incerta e sfrenata.
Questa insicurezza sociale e mentale, diffusa e multiforme, colpisce direttamente le famiglie delle classi popolari sprovviste del capitale culturale richiesto per accedere ai settori protetti del mercato del lavoro; essa tuttavia investe anche larghi strati delle classi medie, e i nuovi discorsi marziali dei politici e dei media sulla delinquenza la captano e la fissano sulla sola questione dell’insicurezza fisica o della minaccia criminale, ed in effetti più dell’insicurezza domina il «sentimento d’insicurezza», ovvero lo stato d’animo, la percezione sociale del disagio, divenuto uno degli indicatori statistici di maggior rilievo, capace di decidere della carriera di un ministro degli Interni e della Giustizia, o dei vertici delle forze dell’ordine. Trattandosi di una percezione sociale, ovvero di un sentimento, accade che essa sia spesso sprovvista di consistenza reale, ma risulti frutto di correnti irrazionali, di pulsioni orientate, solleticate da chi controlla i media e le fonti della comunicazione. A dominare è l’interpretazione pubblica più forte, il sentimento d’insicurezza più consono ai gruppi sociali che vedono il proprio punto di vista meglio rappresentato e veicolato.
La perdita di posti di lavoro, i licenziamenti, la disoccupazione e la precarizzazione dell’impiego, con i drammi e i disagi sociali ed esistenziali che ne conseguono per famiglie intere, non sono percepiti e assunti come aspetti di un sentimento d’insicurezza collettivo, ma vengono relegati a stati d’animo di ceti sociali specifici, colpevoli di rifiutare condizioni di lavoro che altrimenti permetterebbero di sostenere la concorrenza ed assicurare stabilità sociale e crescita economica. Non si tratta dunque di un’incertezza del futuro derivante da una nuova condizione di precarizzazione sociale, da un modello darwinista di società che dilaga, ma di un’ingiustificata volontà di conservare privilegi e vantaggi. Ecco che questa insicurezza scade a sentimento illegittimo, privo di quella dignità scientifica che gli consentirebbe d’essere rilevato dagli indicatori statistici, introducendo un dato nuovo nell’agenda politica. A suscitare allarme sono altri fenomeni, come le rapine selvagge nei villini del Nord-Est, gli attacchi nelle gioiellerie o nelle stazioni di benzina con pistole giocattolo, le rapine in banca con i taglierini. Accade così che il sentimento d’insicurezza, misurato unicamente su parametri di questa natura, risulti più elevato nelle zone urbane agiate, dove le infrazioni sono quasi inesistenti.
Appunto perché di sentimento si tratta, non d’insicurezza vera. Ma una volta propagato dai media, esso arriva a produrre un paradossale aumento dell’indice d’inquietudine persino nelle massaie dei quartieri popolari, non più preoccupate di tornare dal mercato con la busta della spesa vuota, ma di subire fantomatici assalti nelle cucine delle loro case popolari.
Da un regime di sensibilità all’altro
Si sente la perdita di un pensiero forte che sappia nuovamente rompere questa spirale, che sottoponga ad una critica spietata l’ideologia penale e rilanci un nuovo progetto politico capace d’affermare un modello di società dove l’idea della penalità non trovi più posto. «La questione non è sapere cosa fare del carcere, come migliorarlo, oppure come adeguare l’ordine penitenziario alle norme generali dello Stato di diritto, si tratta invece di domandarsi come sbarazzarsene e al più presto, perché è evidente che saremo senza dubbio considerati con repulsione e disprezzo dalle generazioni future», è quanto ci invita a fare il filosofo Alain Brossat nel suo stringato libretto, Pour en finir avec la prison, apparso in Francia nel 2002 e pubblicato nel 2003 in Italia da Elèuthera col titolo Scarcerare la società.
L’invito a rimettere in discussione eredità di pensiero, abitudini filosofiche che pensavamo intoccabili, solleva questioni scomode e spigolose, ma forse è proprio da un diverso sguardo dei fondamenti che occorre ripartire. Ripercorrendo la genealogia della penalità, Brossat avanza una disincantata lettura dell’Illuminismo che nell’ambito del sistema delle pene si presenta con un decisivo momento di passaggio da un regime di sensibilità all’altro. Rielaborando la tesi di Norbert Elias sulla domesticazione della violenza, egli nota l’emergere di un’iperestesia sociale, ovvero l’apparizione di un «soggetto ipersensibile della nostra modernità» che non sopporta in primo luogo la propria sofferenza di fronte allo spettacolo della brutalità estrema e della crudeltà. Ciò spiegherebbe l’avvento di una sensibilità umana egocentrica più che altruista. Analisi che ci offre nuovi strumenti per comprendere meglio, per esempio, quella cosmesi linguistica che ha camuffato l’essenza di alcuni dei conflitti bellici degli ultimi anni. La «guerra etica» di Tony Blair, le ingerenze umanitarie armate, le operazioni di polizia internazionale, le occupazioni militari camuffate sotto formule come «peace making» e «peace keeping», le «bombe intelligenti», i bombardamenti «chirurgici», gli «effetti collaterali», il mito della «guerra pulita a costo zero», sono parte di un innovativo dizionario che intercetta l’inorridita sensibilità occidentale. Il paradosso di questa moderna impressionabilità sta nella presenza di un sentimento d’orrore che non mette fine alla violenza ma s’accontenta unicamente di renderla invisibile, e ciò non vale solo per le azioni ma ancor di più per il pensiero. Si è imposta insomma una paradossale indignazione selettiva che in materia penale, mostrando avversione per l’esplicita violenza dei supplizi, trae sollievo dall’internamento dei corpi sottratti alla vista, in questo modo votati all’oblio e «presto privati della pietà».
La messa in scena del supplizio
Più che celebrare una «litania del progresso», Michel Foucault, rintracciando le diverse tappe dei castighi e delle pene, dei supplizi e delle prigioni, mirava a mostrare come nella punizione fosse insita una «funzione sociale complessa» che oltrepassa il semplice ruolo repressivo. Non solo problema giuridico, dunque, conseguenza dell’applicazione del diritto, ma anche fatto pienamente politico. L’economia del castigo, secondo l’autore di Sorvegliare e punire, appartiene a quel vasto campo in cui intervengono le procedure di potere. I supplizi dell’ancien régime, più che ristabilire la giustizia, riparare un danno, avevano la funzione di riattivare il potere offrendo al popolo lo spettacolo della sofferenza. Il supplizio di Damiens, «il regicida», è uno degli esempi storici di cui ci è pervenuta traccia. Così descrive la vicenda Monsieur Alexandre André le Breton, greffier criminel du Parlement, ossia cancelliere penale della suprema corte giudiziaria, nel Précis historique annesso ai quattro volumi delle pièces originales et procedures du proces fait à Robert-François Damiens: correva l’anno 1757 e Parigi era traversata da una delle solite faide fra corona e vertici del potere togato. Mercoledì 5 gennaio, al buio, qualcuno «in fondo alle scale, presso la volta», ha sfiorato il re alla quinta costola, con un coltello; il danno è minimo, paragonabile alla puntura d’uno spillo, ma sul santo corpo del sovrano l’offesa diventa enorme. L’attentatore è Robert-François Damiens, disoccupato, già domestico in varie case, con discrete referenze e qualche anomalia. I precedenti segnalano un frenetico taciturno, curioso «frondeur» elucubrante, che parla da solo; consapevole «dell’effervescenza del suo sangue», cercava sollievo in abbondanti salassi. Parlando dell’imputato, Le Breton coniuga i verbi all’imperfetto perché «le scelerat» non appartiene più a questo mondo. Ha reso l’anima a Dio, lunedì 28 marzo, a «place de la Grève» (l’attuale place de l’Hotel de Ville), dopo un lunghissimo supplizio tecnicamente difettoso, come pare accada spesso ai pazienti condannati alla «peine d’être tirés à quattre chevaux». Non bastava la trazione dei cavalli a squartarlo, né vi sarebbero riusciti se, dopo un consulto medico, l’équipe patibolare, impugnati i coltelli, non avesse reciso qualche tendine. «Poiché accade d’ordinario che i tendini e i legamenti resistono e non cedono affatto, malgrado gli sforzi dei quattro cavalli, e anche nel caso d’un numero più grande, alla fine occorre recidere i legamenti alla giuntura delle ossa»; solo allora «i cavalli riescono a strappare via ciascuno un arto». Il supplizio durò soltanto «deux heures, lui vivant». L’arnese impiegato per l’aggressione non era idoneo a procurare ferite mortali. Scrive Franco Cordero, dal cui manuale di Procedura Penale abbiamo tratto queste citazioni: «Tra i fannulloni che frequentavano corridoi e aule giudiziarie del Palais, Damiens era diventato un fan dei signori in toga, campioni delle cosiddette “libertà gallicane”, insidiate dalla politica ministeriale; non ha complici e tanto meno mandanti, ma iMonsieurs (il cui consesso, in tali occasioni, include princes du sang e alti dignitari), indirettamente chiamati in causa, purgano i sospetti con una sentenza memorabile».
L’occultamento della pena e lo spettacolo del processo
A partire dal 18° secolo, declinata la religione della confessione ed emersa la laica fiducia nella prova, la reclusione sostituisce torture, mutilazioni, supplizi esemplari. Desacralizzata la giustizia, disincantata la procedura penale, scomparsi i delitti immaginari, raddrizzare e correggere, prima ancora di punire, diventano le parole d’ordine dell’illuminismo penale e del riformismo giudiziario. Le teorie del contratto sociale non concepiscono più il crimine come un attentato al corpo mistico del sovrano ma come una rottura del patto sociale. L’entità della punizione deve apparire allora commisurata all’infrazione commessa e soprattutto essere certa, perché possa esercitare un effetto dissuasivo.
Questa trasformazione conduce all’occultamento della punizione, alla cancellazione dello spettacolo punitivo. Il cerimoniale della pena entra nell’ombra, per diventare un’oscura pratica amministrativa, sostituita dalla pubblicità dirompente del processo e della sentenza, momenti in precedenza segreti. Il capovolgimento è radicale. Processo e condanna, prima ancora della pena, diventano lo stigma negativo che deve marcare il delinquente. L’esecuzione della sanzione sembra quasi un’ignominia supplementare che la giustizia ha vergogna di mostrare. Se ne tiene a distanza. La pena fuoriesce dal campo delle percezioni quotidiane per entrare in una dimensione astratta, sconosciuta, immaginata, non vista. L’efficacia è demandata alla sua ineluttabile fatalità, non più alla sua intensità percettibile. La certezza d’essere punito e non l’abominevole teatro, la «scène dégoûtante», viene a rappresentarne il monito. Il corpo non è più esposto ma interminabilmente recluso. «L’impressionabilità non è più legata all’effimera intensità del supplizio, alla sua illusoria esemplarità, ma fondata sulla durata». Ciò consente alla giustizia di non assumere più pubblicamente la parte di violenza che è insita nel suo esercizio. La punizione non appare più come tale perché le nuove tecniche mirano a rimettere in riga il deviante. Ma dietro la pretesa di «guarire», si rimuove in realtà l’aspetto più concreto dell’espiazione, ovvero il castigo.
L’apologetica carceraria
Nasce così un nuovo genere: l’apologetica carceraria, un edificante progetto votato al reinserimento della parte deviante della società. Con Beccaria e Bentham si dispiega un processo di razionalizzazione delle dottrine come dell’architettura punitiva non più fondato sulla degradazione dei corpi ma sulla correzione delle menti. «Non il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti»: è la citazione di un passaggio da Dei delitti e delle pene, che Brossat propone, notando come la filosofia penale illuminista inventi con la prigione una nuova fabbrica dell’inumano che viene a sostituirsi ai mattatoi del tormento, definendo il passaggio dal regime del supplizio sui corpi a quello del loro abbandono, dalla crudeltà all’insensibilità. Ma già un vecchio padre del liberalismo moderno, Benjamin Constant, metteva in guardia contro l’illusione umanitaria: «le punizioni che si sono volute sostituire alla pena di morte non sono che questa pena inflitta con minuzia, quasi sempre in maniera più lenta e dolorosa». Sparisce il boia ma aumentano i carcerieri. Finalmente nel carcere dell’Occidente moderno e opulento i detenuti non sperimentano più fame e stenti; al contrario deprimono, marciscono, si svuotano, s’immiseriscono, si suicidano appunto. Fanno della vita stessa una malattia. L’istituzione penitenziaria non uccide quasi più di propria mano, lascia uccidersi, mentre col dilagare del liberismo economico, dopo il decennio Ottanta, il numero degli incarcerati ha cominciato ad aumentare a dismisura, e le pene a lievitare senza freno. Il numero dei reati è cresciuto perché si è allargata la rosa dei comportamenti sanzionati. Il carcere si è riproposto come un’istituzione criminogena, una fabbrica della devianza che sottende la paranoica idea di una società in libertà condizionale.
Il paradigma vittimario
A questo punto Brossat segnala un’ulteriore configurazione della sensibilità, investita dal sopraggiungere del paradigma vittimario. Un processo di sostanziale neutralizzazione e depoliticizzazione della figura della vittima che, divenuta un’icona della martirologia statale, cancella «perdenti e vinti della storia». Dietro ciò emerge una nuova opinione umanitaria che, capovolgendo i presupposti della critica illuminista (circolazione libera delle idee in uno spazio pubblico autonomo dalla sfera statale e religiosa), si concepisce come baluardo avanzato della legge e dell’ordine invocando una nuova forma d’intolleranza. Ecco che senza più remore ed ipocrisie si torna ad affermare l’obiettivo unicamente afflittivo della pena. Proprio come riconosceva più di un secolo fa il sociologo Emile Durkheim: «la pena è rimasta un’opera di vendetta. Si dice che non facciamo soffrire il colpevole solo per farlo soffrire. Non è meno vero tuttavia che troviamo giusto che egli soffra», per questo non mancava di prescrivere che «la condizione penitenziaria deve essere più draconiana di quella dell’uomo libero più indigente».
La retribuzione simbolica
Il carcere non cambia. Resta il luogo in cui lo Stato regola con freddezza i suoi conti con le classi pericolose, in cui mostra senza emozioni né debolezze chi comanda, ricordando ai vinti quanto costa continuare a pretendere d’ignorare le regole del gioco. Questa sua essenza politica suggerisce allora di cambiare la nostra prospettiva d’osservazione e non guardare più alla prigione soltanto dal punto di vista dell’«opinione umanitaria», sulla base d’un approccio compassionevole che riversa la sua critica unicamente sulla sofferenza del detenuto, ma osservando il carcere come manifestazione della violenza dello Stato, luogo dell’eccezione sovrana. Esso svolge una decisiva funzione politica poiché riunisce la comunità contro colui che ha infranto le regole. La reclusione dunque rinforza il legame sociale, prepara la sicurezza futura. Ogni pena inflitta inscena una retribuzione, una restaurazione, rivestendo una funzione lenitiva per la coscienza collettiva colpita dal crimine. Non c’è riformismo penitenziario che abbia realmente insidiato questa filosofia. Allora di fronte all’abissale fallimento dell’umanesimo penale, Brossat invita a rigettare definitivamente l’inganno fondativo del carcere. La prigione non serve e la speranza che il diritto vi faccia un ingresso pieno e maturo – conclude – non ci condurrà comunque nell’era del «dopo carcere», ma solo in quella di un diritto incarcerato. Per l’intanto non è lo stato di diritto che si estende nelle prigioni ma il modello carcerale che avanza nella società, come i centri di permanenza temporanea e le nuove strutture di detenzione attenuata dimostrano.
Incarcerare il diritto o abolire il carcere?
Pensare che «per eliminare lo scandalo delle carceri sia sufficiente adeguare il loro regime interno alle norme generali dello Stato di diritto», pensare che sia sufficiente garantire il sia pur fondamentale livello minimo d’integrità e immunità della persona detenuta, per ritenere la prigione uno spazio finalmente «umanizzato» e giuridicamente corretto, oltre a rinviare ad una concezione puramente passiva dei diritti, intesi unicamente come pura tutela della persona, al pari di un organismo vegetale, muto e sprovvisto di pensiero proprio (come la flora tutelata dagli ambientalisti), mostra l’incomprensione assoluta degli effetti dell’internamento. L’ingresso in carcere provoca una degradazione giuridico-politica dell’internato, ridotto a semplice corpo. «La detenzione è la prova più radicale che ci sia di non appartenenza alla comunità civile». Il detenuto è privo di «diritti soggettivi», può rispondere con sfacciata sicumera, e tanto di timbro dell’amministrazione in calce, il vicedirettore di un istituto di pena ad un detenuto che gli chiede su quali fondamenti giuridici poggi il trattamento penitenziario che gli è riservato. Una condizione che rinvia a quella dell’ostracizzato, del bandito, dell’esiliato interno. È impensabile immaginare l’esercizio delle libertà politiche all’interno di un sistema disciplinare che considera la sanzione consustanziale, non solo alla privazione della libertà fisica, alla riduzione brutale delle possibilità di movimento, al «disciplinamento» dei corpi, al controllo dei sentimenti, delle emozioni, degli affetti, alla privazione di alcune funzioni essenziali della vita umana, ma anche al diritto di riunione e discussione.
Luogo concentrazionario per eccellenza, la prigione non prevede l’esistenza di uno «spazio pubblico» interno alla cinta muraria. Le sezioni sono strettamente separate tra loro, le celle restano chiuse per l’intera giornata, fatta eccezione per alcuni tipi d’istituti di pena. Non c’è libera circolazione, i soli luoghi d’incontro restano i passeggi durante le ore d’aria, le palestre (negli istituti che ne sono provvisti), le eventuali attività trattamentali, i luoghi di culto. La comunicazione sceglie allora flussi sotterranei, segue traiettorie carsiche, s’inabissa lungo percorsi discreti e riservati che cercano d’evitare gli occhi dell’amministrazione, servendosi dell’antico savoir-fairedegli schiavi. In sostanza, l’ipotesi di una «vita attiva», per usare un’espressione arendtiana, o in altri termini, l’esercizio della cittadinanza, all’interno della quale l’individuo detenuto si trovi ad essere concepito anche come essere pensante, capace di produrre attività relazionali di tipo sociale, politico e culturale, non è in alcun momento preso in considerazione, anzi se possibile è osteggiato. Se la comunicazione tra detenuti non è formalmente vietata, salvo espliciti provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’intera macchina penitenziaria è costruita per impedirla, intercettarla, sopprimerla.
Quale può essere allora la via di fuga dall’ideologia penitenziaria? Sprigionare la società, vorremmo sentir rispondere. Ma quanti sono pronti a segare le sbarre che imprigionano la loro coscienza?
(23 maggio 2005)
La BBC intervista la torturatrice di Abu Ghraib
“Rispetto a quello che gli iracheni avrebbero fatto a noi, ciò che abbiamo fatto era niente. Quando queste cose succedevano, loro ci decapitavano, bruciavano i corpi, trascinavano i cadaveri per le strade o li appendevano ai ponti” queste le parole usate durante un’intervista alla Bbc da Lynndie England, la soldatessa diventata tristemente famosa per essere una delle protagoniste delle fotografie uscire dal carcere degli orrori di Abu Ghraib.  Sono passati cinque anni da quei giorni in cui la donna si faceva immortalare durante abusi fisici sui detenuti del carcere. Tre degli ultimi cinque anni la donna li ha passati in carcere e sembra di non essere pentita per ciò che ha fatto in passato. “Le umiliazioni sessuali avvengono anche nei college in Usa e se servono a ottenere informazioni allora sono pratiche accettabili”. La giornalista ha incalzato più volte la England con domande ficcanti. “Non le sembra perverso e assurdo ciò che accadeva?” è stato chiesto. “Certo era un po’ strano – ha risposto la soldatessa Usa – ma quelle erano cose che succedevano lì. I superiori ci dicevano che andava tutto bene e che dovevamo continuare”.
Sono passati cinque anni da quei giorni in cui la donna si faceva immortalare durante abusi fisici sui detenuti del carcere. Tre degli ultimi cinque anni la donna li ha passati in carcere e sembra di non essere pentita per ciò che ha fatto in passato. “Le umiliazioni sessuali avvengono anche nei college in Usa e se servono a ottenere informazioni allora sono pratiche accettabili”. La giornalista ha incalzato più volte la England con domande ficcanti. “Non le sembra perverso e assurdo ciò che accadeva?” è stato chiesto. “Certo era un po’ strano – ha risposto la soldatessa Usa – ma quelle erano cose che succedevano lì. I superiori ci dicevano che andava tutto bene e che dovevamo continuare”.
La donna dice di sentirsi molo sola e oggi ha paura che qualcuno la possa uccidere. Fa uso di antidepressivi e racconta che anche la madre ha subito minacce per colpa sua.
A Fabrizio Pelli, lasciato morire in carcere…30 anni fa
FABRIZIO PELLI
– Nasce a Reggio Emilia, l’11 luglio 1952
– Lavora come cameriere
– Milita nelle Brigate Rosse
– Viene arrestato a Pavia nel dicembre 1975
– Muore di leucemia nel carcere di San Vittore, Milano, l’8 agosto 1979
Documenti prodotti da organizzazioni armate
– Non ne sono stati prodotti, ma a Fabrizio Pelli vengono intitolate una Brigata e un’organizzazione armata a Salerno
Documenti prodotti da gruppi sociali
– Comitato di lotta del Campo dell’Asinara, “Onore al compagno Fabrizio Pelli” in: Controinformazione 16, Milano 1979
“Per ogni comunista la morte è un evento naturale e Fabrizio Pelli era comunista combattente.
Anche il mare più incurabile per un rivoluzionario è occasione di lotta e Fabrizio, con il suo comportamento, lo ha dimostrato a tutta la sua classe e ai suoi nemici, in quest’ultima, solitaria battaglia.

Fabrizio Pelli _Questa foto aveva le sbarre, quelle che lo hanno tenuto costretto fino alla sua morte: sono state tolto, almeno così è LIBERO_
Invano i corvi borghesi hanno atteso un suo cenno di debolezza per piegarlo, per ricondurlo al compromesso dentro l’ordine dell’oppressione. A nulla è servito tenerlo isolato fino all’ultimo istante, privato della posta e della vicinanza dei suoi compagni, negargli – come neppure il fascismo osava fare – di trascorrere le ultime ore di visita in compagnia dei suoi familiari, a casa sua.
La speranza delle iene è andata delusa di fronte ad un comunista che aveva maturato a fondo un principio essenziale: uomini che si rifiutano di interrompere la loro lotta, o vincono o muoiono, invece di perdere o morire!
Il Tribunale di Milano, così sollecito a concedere la libertà provvisoria per motivi di salute ai fascisti assassini di proletari come Braggion, non è che l’ultimo anello di una catena di infamie, cominciata proprio qui, all’Asinara, dove il medico Silvetti si guardò bene dal rilevare il reale stato di salute del compagno Fabrizio, quando nell’estate dello scorso anno cominciò ad accusare i sintomi della malattia.
I Campi di Trani, Fossombrone e Milano sono altrettanti anelli del suo progressivo annientamento che medici e direttori hanno perseguito con lucida e spietata determinazione in occulta armonia con i funzionari del ministero di Grazia e Giustizia. E non vogliamo dimenticare, in questo elenco di canaglie ancora viventi, carabinieri e poliziotti che hanno sottoposto i familiari di Fabrizio alle perquisizioni più vili e che in ogni modo hanno tramato per interrompere il proseguimento delle cure.
Noi proletari prigionieri del Campo dell’Asinara, che con Fabrizio abbiamo lottato e che, anche per il suo contributo, abbiamo rafforzato la nostra identità e la nostra organizzazione, oggi diciamo, senza alcuna retorica, che i suoi nemici sono anche i nostri, che i suoi assassini non resteranno impuniti!
Onore al compagno Fabrizio Pelli!
Onore a tutti i compagni caduti combattendo per il comunismo!”
Testimonianza al Progetto Memoria
– Renato Curcio, Roma 1994
“Ho conosciuto Fabrizio, Bicio per gli amici, nel 1969.
Aveva 17 anni ma, a Reggio Emilia, già da tempo aveva fatto parlare di sé. “Per un colpo di flobert indirizzato ai glutei di un politico del partito liberale”, mi dissero, tra l’ammirato e l’ironico i suoi compagni di allora.
Non aveva ancora 18 anni quando venne a Milano con tutte le sue curiosità per la metropoli. Ma ciò che veramente lo spingeva, in verità era una cosa sola: l’impegno militante a fianco di studenti e operai, di chiunque in qualsiasi modo lottasse, per cambiare le cose.
Si sentiva un po’ anarchico ma il fascino della rivoluzione bolscevica era su di lui così potente che trascorreva infinite notti a leggere, oltre ai testi canonici, qualsiasi saggio, opuscolo, libello che in qualche modo potesse arricchire le sue conoscenze. E se qualcuno per caso citava un’opera che gli era sfuggita, s’infuriava, non sembrandogli lì per lì possibile che quell’opera esistesse veramente. Se non era a volantinare, in qualche manifestazione o a organizzare qualche azione di lotta potevi star sicure che il suo tempo era speso in letture.
Politiche, s’intende. Una dedizione totale, senza mezze misure. Senza concedere a se stesso nemmeno gli spazi dell’esplorazione della vita.
Quando entrò nella lotta armata, nel 1971, se non era il più giovane certo si contendeva il primato. Proprio in relazione alla sua giovanissima età, con altri due compagni ci chiedemmo se fosse il caso di accoglierlo nella vita clandestina che, per ovvie ragioni, non è tra le più permissive. Ma a Bicio il carattere non faceva difetto e non ne volle sapere di tutti gli argomenti che gli mettevamo davanti per dissuaderlo.
Era molto orgoglioso e un po’ testardo. Capitava così che non accettasse di buon grado che altri gli insegnassero qualcosa. Ricordo che una volta si infuriò con un militante: non ritenendolo adeguatamente colto in dottrina marxista, gli negava il diritto di insegnarli a guidare l’automobile. L’altro, naturalmente, lo mollò giù dalla macchina, in piena campagna, dicendogli “Beh, ora vado a studiare, tu raggiungimi a piedi!”
Quando, nel 1975, dopo l’evasione da Casale, lo incontrai di nuovo, a Milano, Fabrizio si era innamorato. Nella sua vita era la prima volta. E il calore di questa nuova e magnifica esperienza scioglieva tumultuosamente tutte le sue rigidezze. Della sua proverbiale rigorosità, in quei giorni non rimase traccia. A metà della riunione più delicata, lui si alzava e borbottava “Scusate…”, in pieno candore se ne andava a telefonare. Alla vita clandestina il suo stato di grazia causò qualche problema, ma alla sua vita personale certo fece un gran bene.
Ho appreso la notizia del suo arresto alla radio, pochi giorni prima di essere a mia volta arrestato. L’ultimo nostro incontro, dunque, avvenne in carcere, all’Asinara. Alcune divergenze politiche che poco prima del suo arresto lo avevano portato a distaccarsi dalle Brigate Rosse non avevano in alcun modo intaccato il nostro affetto. I giorni trascorsi nella stessa cella, al bunker dell’isola, furono così pieni di confidenze sulla nostra vita privata. Giocammo a scacchi –costruiti con la mollica di pane – ridendocela a più non posso sul nostro incontro qualche anno prima, con quel gioco. Nel tempo della clandestinità, a Torino. Sull’onda del duello tra Carpov e Fisher Bicio aveva deciso di “sapere tutto” sugli scacchi, proprio come qualche anno prima aveva fatto con la rivoluzione bolscevica. S’era quindi comperato una scacchiera , tanti libri, riviste e s’era sprofondato nello studio. Venne finalmente il giorno della prima prova. Si sentiva pronto e col sorriso diceva: adesso ti faccio vedere… Ci provai col fatidico “scacco del barbiere”: scacco matto in pochissime mosse. E la sua inesperienza ebbe la peggio. Come al solito andò su tutte le furie e per un bel po’ di tempo di scacchi preferimmo non parlarne più.
All’Asinara mi disse anche dei malori che poco dopo lo portarono, rapidamente, alla morte. Ma di cosa effettivamente si trattasse, in quel carcere senza alcuna servizio medico, non fu possibile stabilirlo. Non si lamentò mai delle mancate cure: per lui era scontato. E anche questo, ricordando Bicio, non può essere più dimenticato”.

A Dario Bertagna
DARIO BERTAGNA
– Nasce a Comerio (BG) l’8 luglio 1950
– lavora come impiegato presso una ditta di produzione di vernici di Vimercate (MI)
– milita nei Reparti Comunisti d’Attacco
– viene arrestato a Milano il 23 giugno 1980
– muore suicidia nel carcere di Busto Arsizio (VA) il 17 luglio 1988
Scritture di Dario Bertagna
– Dario Bertagna, lettera al Bollettino, 27-8-84, carcere di Fossano:
“Come mai allora questo trasferimento improvviso al manicomio di Reggio Emilia? Le cose stanno così: la dottoressa psichiatra del carcere, dopo una sbrigativa visita, aveva diagnosticato che L.V. era schizofrenico. Ma vi rendete conto?  Una persona legge quattro scartoffie riguardanti un carcerato, lo visita cinque minuti e lo giudica nientemeno che schizofrenico. Mi rendo conto che questa dottoressa probabilmente ha agito in buona fede e che ancora più facilmente le responsabilità maggiori stanno in qualche altro ingranaggio dell’apparato di potere. Sta di fatto che questi signori si rendono conto che non sono altro che dei meccanismi di una macchina mostruosa, ingranaggi più o meno determinanti, ma ciascuno facendo parte di un congegno degenerato che a sua volta genera le singole parti.
Una persona legge quattro scartoffie riguardanti un carcerato, lo visita cinque minuti e lo giudica nientemeno che schizofrenico. Mi rendo conto che questa dottoressa probabilmente ha agito in buona fede e che ancora più facilmente le responsabilità maggiori stanno in qualche altro ingranaggio dell’apparato di potere. Sta di fatto che questi signori si rendono conto che non sono altro che dei meccanismi di una macchina mostruosa, ingranaggi più o meno determinanti, ma ciascuno facendo parte di un congegno degenerato che a sua volta genera le singole parti.
Sia chiaro comunque che anche singoli proletari possono benissimo essere incorporati in questo brutale meccanismo e, anche se saranno rotelle di poco conto, si renderanno pur sempre funzionali al sistema. Mi riferisco tra l’altro specialmente ai vari dissociati, di nome o di fatto, o tutti e due. Certo lo Stato non manda costoro a Reggio Emilia e magari concede loro anche qualche zuccherino.
Facciamo bene i contri e vedremo con chiarezza che schizofrenico è questo sistema e tutti i suoi ingranaggi e non certo il compagno L.V.”
– I Compagni del movimento e i familiari dei detenuti, Volantino, 23 luglio 1988, Busto Arsizio
“Domenica scorsa, 17 luglio, il compagno Dario Bertagna si è tolto la vita nel carcere di Busto Arsizio, dopo aver scontato 8 anni di galera per reati politici. Malgrado la marginalità delle responsabilità penali, nel processo che ha deciso la messa in collaborazione dei pentiti come Barbone e di altri imputati che hanno scelto la strada della collaborazione e l’abiura, Dario subì una condanna a 15 anni di carcere. E’ questa l’ennesima dimostrazione di come le leggi e le prassi giuridiche nate dall’emergenza abbiano legato l’entità della condanna all’identità politica e al comportamento degli imputati, malgrado le autorità e gli intellettuali più o meno di regime, insieme ai partiti, abbiano ripetuto fino alla noia che “tutto si è sempre svolto nella legalità e nel rispetto delle regole della democrazia.”
 Dario non era né pentito né dissociato ed ha sempre lottato, con tutte le sue forze, per salvaguardare la propria dignità umana e la propria identità politica. Per 8 anni ha lottato contro la macchina di distruzione che è il carcere, in condizioni psicofisiche sempre più instabili, come i medici del carcere hanno avuto modo di constatare più volte. La sua morte, come tutte le morti avvenute in carcere, peserà come un macigno anche sui responsabili della disastrosa gestione dell’assistenza sanitaria, su quanti permettono che passino giorni e settimane prima di un ricovero, su chi tra la salute del detenuto e la sicurezza dell’istituzione sceglie sempre quest’ultima.
Dario non era né pentito né dissociato ed ha sempre lottato, con tutte le sue forze, per salvaguardare la propria dignità umana e la propria identità politica. Per 8 anni ha lottato contro la macchina di distruzione che è il carcere, in condizioni psicofisiche sempre più instabili, come i medici del carcere hanno avuto modo di constatare più volte. La sua morte, come tutte le morti avvenute in carcere, peserà come un macigno anche sui responsabili della disastrosa gestione dell’assistenza sanitaria, su quanti permettono che passino giorni e settimane prima di un ricovero, su chi tra la salute del detenuto e la sicurezza dell’istituzione sceglie sempre quest’ultima.
Oltre a tutto ci preme ricordare che non più di un mese fa il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva negato a Dario la semilibertà, nonostante gli 8 anni di galera scontati, le sue precarie condizioni di salute e l’ottenimento di un posto di lavoro in una fabbrica del suo territorio. In carcere non avevano pesato sul suo contro gravi rapporti disciplinari o denunce. (…)
Con il suo ultimo gesto Dario ha gridato ancora una volta il suo rifiuto a piegarsi al patto infame che impone la svendita della propria dignità in cambio della scarcerazione.
Noi siamo oggi davanti al carcere di Busto Arsizio e poi in piazza per ricordare alla gente che l’angolo di barbarie costruito negli anni dell’emergenza e nel quale sono già morti troppi detenuti non deve continuare la sua opera di distruzione.”
– Giulio Petrilli, Testimonianza al Progetto Memoria, L’Aquila 1995
“Ricordare Dario è ricordare un compagno col quale ho condiviso dei momenti, delle lotte, dei sogni, in una realtà particolare come il carcere di San Vittore, dal dicembre ’80 alla metà dell’83. Un momento di grandi lotte in uno dei carceri metropolitani più particolari, più complessi. Dario l’ho conosciuto esattamente il 6 gennaio 1981, in una cella del secondo raggio, la nostra cella per tanto tempo, poi i trasferimenti ci hanno diviso.
Ricordo quel pomeriggio del 6 gennaio, dopo diversi giorni nelle celle d’isolamento fui fatto salire su in sezione, stavo un po’ sbandato tra arresto e isolamento, ma entrando in cella subito mi sentii a mio agio in un ambiente caldo; eravamo in cinque, un po’ stretti ma stavamo bene. E’ lì che conobbi Dario, mi sembrò subito così come poi l’ho conosciuto nel tempo: un ragazzo riservato ma estremamente dolce, il suo aspetto rispecchiava il suo carattere, con quel sorriso un po’ triste negli occhi azzurri. Ricordo mi offrì subito una birra, e preparò insieme agli altri una bella cenetta; e poi quelle birre che hanno accompagnato tanti nostri pomeriggi e tante serate. Ricordo che mi riempì di domande, sai appena arriva uno nuovo è un po’ d’abitudine in carcere sentire i racconti della vita fuori. Lui disse che era stato arrestato nel giugno precedente, e che da poco si trovava a San Vittore. In precedenza era stato a Fossano, un carcere penale e mi raccontò della vita lì, delle diversità con San Vittore anche perché poi lì al secondo raggio eravamo tutti politici, mentre lì, con i comuni c’era un’altra realtà, più da logica carceraria. Poi iniziò a raccontarmi della sua vita fuori; era tecnico di una piccola azienda di elettrodomestici, vicino a Milano; mi raccontò del paese vicino Varese, dove abitava e quando ne parlava si capiva che lui preferiva vivere lì e non in una grande città, anche perché da piccolo aveva vissuto in un paesino del bergamasco. Poi mi raccontò della sua esperienza politica a Milano, la sua politicizzazione passata attraverso la sindacalizzazione nella fabbrica dove lavorava, i contrati, le lotte, l’inasprimento del padronato, la coscienza sempre più approfondita che lui andava maturando, lo scontro con le logiche di totale mediazione, che lui chiamava “arrendevolezza del vertice del sindacato”, il suo travaglio e la rottura completa con il sindacato. La sua incredulità nel raccontare che molti dirigenti d’industria e capi reparto tra i più duri erano iscritti al PCI.  Lui non se ne faceva capace che chi imponeva la produttività, il sacrificio, la logica di lottare, ma portando sempre il profitto all’azienda, erano quelle le persone che a parole si dicevano comuniste. Questa cosa per lui era totalmente inammissibile, da lì maturò la scelta della lotta armata. E questa sua scelta, maturata proprio partendo dall’avversione verso la cultura stalinista e produttivista del PCI, se l’è portata dietro sempre, con coerenza fino alla fine.
Lui non se ne faceva capace che chi imponeva la produttività, il sacrificio, la logica di lottare, ma portando sempre il profitto all’azienda, erano quelle le persone che a parole si dicevano comuniste. Questa cosa per lui era totalmente inammissibile, da lì maturò la scelta della lotta armata. E questa sua scelta, maturata proprio partendo dall’avversione verso la cultura stalinista e produttivista del PCI, se l’è portata dietro sempre, con coerenza fino alla fine.
Dario era chiuso, un po’ introverso ma estremamente determinato e lucido; io non concordavo alcune questioni del suo ragionamento ma in fondo ero con lui, soprattutto in quegli anni a San Vittore. Poi le nostre strade si sono divise, ci siamo scritti qualche lettera, lui non concordava la mia scelta critica al metodo della lotta armata che secondo me non si adattava più, ma c’è sempre stato dell’affetto.
Poi siamo nati lo stesso giorno, l’8 luglio festeggiavamo i compleanni insieme, sognavamo insieme, io ci scherzavo un po’ su, sulla sua rigidità. Abbiamo studiato tanti libri, documenti, insieme, nelle lunghe e interminabili discussioni e passeggiate nel cortile, dove lui, tra una sigaretta e l’altra, si faceva chilometri a piedi, molto spesso da solo, assorto nel suo mondo. E io scherzavo dicendo: “Torna in terra, vieni a giocare a pallavolo, a correre”. Con l’ironia e lo scherzo molto spesso comunicavo con lui , con quel suo modo d’essere reticente nel parlare anche della sua vita privata, dei suoi amori. Con quel suo bene grande che voleva alla sorella, che spesso veniva a trovarlo, portandogli anche dei pacchi che consumavamo insieme.
Poi, come spesso accade, ci siamo persi. E ci siamo ritrovati tanti anni dopo, nel maggio dello scorso anno, sfogliando una pagina del libro La mappa perduta, ho letto il suo nome e l’ho rivisto nel cuore, in quel suo grande cuore che non voleva mai manifestare, che voleva quasi coprire, proteggere, con un po’ di scontrosità”.
Un bell’articolo su Vincenzo Guagliardo e Nadia Ponti
TRANQUILLI! VINCENZO GUAGLIARDO DOPO 33 ANNI RESTA IN CARCERE
di Mario Dellacqua
“Il mondo di None” 6/7 GIUGNO-LUGLIO 2009
Mensile di None TO
Questa storia non mi da pace, non interessa quasi nessuno e non ci posso fare niente. Quando Vincenzo Guagliardo è sparito nella lotta armata, non me ne sono accorto. Ero distratto. Quando ne è uscito passando attraverso il carcere –ora sono una vita di 33 anni – ero ancora più distratto e le sue foto sul giornale dietro le sbarre smuovevano al massimo la mia curiosità, ma finiva lì. Poi vennero i suoi libri. Li ho letti e ne ho parlato su queste ospitali colonne. Venne anche la dimessa lotta solitaria, sua e di sua moglie Nadia Ponti, per ottenere il diritto all’affettività in carcere, condotta con implacabile serenità, anche a costo di rinunciare ai benefici di una legislazione che premiava i detenuti a condizione che esprimessero atti di contrizione, esibizioni pubbliche di pentimento, richieste spettacolari di perdono. La giustizia italiana non concesse i benefici e neppure l’affettività, perché l’umanità del trattamento carcerario prescritta dalla Costituzione si accontenta di considerare i detenuti ancor meno di animali rinchiusi in uno zoo.
Vincenzo e Nadia continuarono a rivendicare la loro dignità di persone senza pretese e rifiutarono persino di tentare la via della spettacolarizzazione massmediatica del loro caso. Scelsero la via del silenzio che reputarono la forma di mediazione più consona alla tragedia della quale erano stati corresponsabili.
Perciò i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Roma respinsero nel settembre scorso la prima istanza di liberazione condizionale: Guagliardo era colpevole della “scelta consapevole di non prendere contatti con i familiari delle vittime”.
Ma un incontro era avvenuto nel 2005, come Sabina Rossa ha testimoniato in un libro uscito ben prima che la figlia dell’operaio comunista ucciso a Genova nel 1979 diventasse parlamentare del PD.
Semplicemente avvenne senza chiamare Bruno Vespa (senza la benedizione televisiva del quale anche i fatti accaduti sono revocati), perché Vincenzo e Nadia non volevano che un così drammatico faccia a faccia apparisse “merce strumentale a interessi individuali, simulazione e perciò ulteriore offesa.”
L’onorevole Rossa, anzi, si rivolse spontaneamente al magistrato di sorveglianza, riferì dell’avvenuto colloquio, chiese la liberazione dei due detenuti e presentò addirittura una proposta di legge che non subordinava la concessione della condizionale alla imponderabile verifica pubblica della sfera interiore del detenuto come prova dell’autenticità del ravvedimento. Ma i giudici non si sono accontentati e ad aprile hanno respinto per la seconda volta la richiesta di Guagliardo. Non bastano più i contatti con le persone offese: ora si decide che essi assumono “valenza determinante” solo se “accompagnati dall’esternazione sincera e disinteressata”. Poco importa se Sabina Rossa, la figlia della vittima, ha chiesto la liberazione del condannato all’ergastolo dopo 33 anni di carcere: la sua è una “manifestazione isolata non rappresentativa delle persone offese”.
Anche noi anarchici siamo tenuti a rispettare la giustizia e le sentenze di uno Stato che non amiamo, ma nessuno ci toglierà dalla testa che “il tema del perdono –come scrive il giornale comunista Liberazione del 15 aprile scorso – o meglio la mediazione riparatrice o riconciliatrice, attiene alla sfera privata, non a quella dello Stato.” Lo Stato democratico, se non vuole diventare Stato etico, non dovrebbe spoliticizzare il pubblico e politicizzare il privato: piuttosto dovrebbe, come stabilisce la Costituzione, misurare se le pene inflitte – che non devono essere contrarie al senso di umanità – hanno raggiunto l’obiettivo della rieducazione del condannato al quale devono sempre tendere (art. 27).
La lotta di Nadia e Vincenzo continua con esemplare e magistrale serenità: essa non cancella l’inamovibile tormento, ma lo scioglie e lo distribuisce sotto forma di una domanda e di un’offerta di umanità che colpisce e turba anche i distratti come me, sempre impegnati in cose più importanti, che non so quanto siano effettivamente più importanti.
Arresti G-8 a Roma: video e petizione
La coscienza civile si risvegli, la libertà di dissenso va difesa
 successione in questi giorni. Ne hanno fatto le spese le giovani e i giovani colpiti dai provvedimenti di privazione della libertà personale in un contesto che dovrebbe essere tra i più protetti in uno stato di diritto: quello della manifestazione di dissenso, anche il più radicale. Con sorprendente tempismo, nella settimana del secondo G8 presieduto da Silvio Berlusconi, dopo quello tristemente noto di otto anni fa a Genova, ordini di carcerazione sono stati eseguiti a carico di 21 partecipanti alla contestazione dell’Onda studentesca nei confronti del “G8 dei rettori” di Torino, risalente a due mesi prima. Il giorno seguente, durante le prime contestazioni all’incontro dei capi di Stato e di governo, in occasione del transito a Roma delle delegazioni internazionali verso la sede del summit a Coppito nell’Abruzzo terremotato, gli ordini di carcerazione hanno riguardato 8 dei 36 giovani fermati nel corso di un corteo partito dalla terza Università pubblica della capitale.
successione in questi giorni. Ne hanno fatto le spese le giovani e i giovani colpiti dai provvedimenti di privazione della libertà personale in un contesto che dovrebbe essere tra i più protetti in uno stato di diritto: quello della manifestazione di dissenso, anche il più radicale. Con sorprendente tempismo, nella settimana del secondo G8 presieduto da Silvio Berlusconi, dopo quello tristemente noto di otto anni fa a Genova, ordini di carcerazione sono stati eseguiti a carico di 21 partecipanti alla contestazione dell’Onda studentesca nei confronti del “G8 dei rettori” di Torino, risalente a due mesi prima. Il giorno seguente, durante le prime contestazioni all’incontro dei capi di Stato e di governo, in occasione del transito a Roma delle delegazioni internazionali verso la sede del summit a Coppito nell’Abruzzo terremotato, gli ordini di carcerazione hanno riguardato 8 dei 36 giovani fermati nel corso di un corteo partito dalla terza Università pubblica della capitale.  Un corteo caricato dalle forze dell’ordine senza ragione alcuna, nel momento in cui i manifestanti stavano per sciogliersi e raggiungere la manifestazione convocata all’Università la Sapienza contro gli arresti del giorno prima. Nulla aveva compiuto il corteo nei confronti di cose e persone, e non risulta, né è stata contestata agli indagati, lesione alcuna all’incolumità di chicchessia. Mentre tra i fermati, chi è stato trattenuto in carcere, in stato d’arresto e perfino in regime di semi-isolamento, è noto essere impegnato in quotidiane e trasparenti attività politiche e sociali. Esattamente come è avvenuto con gli arresti di esponenti dell’Onda e dei movimenti che l’appoggiano, effettuati il giorno prima in tutta Italia.
Un corteo caricato dalle forze dell’ordine senza ragione alcuna, nel momento in cui i manifestanti stavano per sciogliersi e raggiungere la manifestazione convocata all’Università la Sapienza contro gli arresti del giorno prima. Nulla aveva compiuto il corteo nei confronti di cose e persone, e non risulta, né è stata contestata agli indagati, lesione alcuna all’incolumità di chicchessia. Mentre tra i fermati, chi è stato trattenuto in carcere, in stato d’arresto e perfino in regime di semi-isolamento, è noto essere impegnato in quotidiane e trasparenti attività politiche e sociali. Esattamente come è avvenuto con gli arresti di esponenti dell’Onda e dei movimenti che l’appoggiano, effettuati il giorno prima in tutta Italia. Né si possono considerare integre, piene ed effettivamente tutelate le garanzie di agibilità democratica in un Paese, quando in esso l’autorità esercita forme di repressione generalizzata delle contestazioni collettive di dissenso, tanto più in occasioni delicate come un vertice internazionale di governi. La manifestazione del dissenso è infatti parte della normale dialettica di una società democratica.
Né si possono considerare integre, piene ed effettivamente tutelate le garanzie di agibilità democratica in un Paese, quando in esso l’autorità esercita forme di repressione generalizzata delle contestazioni collettive di dissenso, tanto più in occasioni delicate come un vertice internazionale di governi. La manifestazione del dissenso è infatti parte della normale dialettica di una società democratica. Devono allarmarsi per le sorti della democrazia e della libertà di tutti: si comincia dalle posizioni radicali ma non si può prevedere dove ci si fermi.
Devono allarmarsi per le sorti della democrazia e della libertà di tutti: si comincia dalle posizioni radicali ma non si può prevedere dove ci si fermi.
Per leggere le firme e lasciare la propria questo è il link http://petizionearrestig8.noblogs.org
Qui invece il video di ricostruzione degli “scontri” dell’altro giorno con il simpatico atteggiamento della Digos
AD ANNAMARIA MANTINI
ANNAMARIA MANTINI
-Nacque a Fiesole, l’11 aprile 1953
-Frequenta le scuole a Firenze e nel 1973 si iscrive a Lettere e Filosofia
– Nel 1975 si trasferisce a Roma
– Milita nei Nuclei Armati Proletari
– Viene uccisa dai carabinieri a Roma l’8 luglio 1975
Documenti prodotti da organizzazioni armate per la per persona o per l’evento in cui ha incontrato la morte:
– Nuclei Armati Proletari, Comunicato 9-7-75 in: Soccorso Rosso napoletano (a cura di), I nap, Milano 1976, Collettivo Editoriale Libri Rossi.
“9 luglio 1975: Ieri in un agguato teso dalla polizia, è stata uccisa a freddo la compagna Annamaria. La volontà del potere di chiudere la partita con i compagni che si organizzano clandestinamente, ha armato la mano del killer di turno, che con la precisa coscienza di uccidere, ci ha privato di una compagna eccezionale.
Annamaria era uno dei compagni che hanno dato vita al nucleo “29 ottobre”. Ha fatto parte del gruppo che ha sequestrato sotto casa il magistrato Di Gennaro, e il contributo che ha dato alla costruzione ed esecuzione di questa azione, dimostrando il livello politico militare che aveva raggiunto. E’ enorme l’abisso che separa una compagna rivoluzionaria da uno sbirro. Non basterebbero la vita di cento Tuzzolino per pagare la vita di Annamaria.
Questo non significa che dimenticheremo i Tuzzolino, i Barberis, così come non abbiamo dimenticato i Conti e i Romaniello.
La mano che uccide un proletario ci è nemica come i porci che la armano. Ma lo ripetiamo, non è uccidendo uno o più sbirri che i proletari si possono ripagare del prezzo che stanno pagando per liberarsi. E per questo prezzo altissimo, in noi come in tutti i rivoluzionari, non c’è solo la rabbia ma anche la coscienza che il movimento si sta arricchendo in maniera definitiva del patrimonio di importantissime esperienze che questi compagni ci lasciano.
Le giornate di aprile, le innumerevoli azioni armate, gli espropri per autofinanziamento, le azioni nelle carceri, dimostrano la crescita di una nuova generazione di combattenti, e non bastano gli omicidi e gli arresti per distruggerla.
La nostra esigenza di comunismo è indistruttibile.
Luca Mantini, Sergio Romeo, Bruno Valli, Vito Principe, Gianpiero Taras, Margherita Cagol, Annamaria Mantini.
Non siete i soli e non sarete gli ultimi, ma rappresentate per tutti i rivoluzionari una scelta irrinunciabile.
Lotta armata per il comunismo
Nucleo Armato 29 ottobre.
Documenti prodotti da gruppi sociali
– Anna Maria Mantini, in: Nuclei Armati Proletari, Quaderno n.1 di Controinformazione, Milano 1976
“Comunista da sempre, ma solo a 17 anni inizia ad interessarsi attivamente di politica sull’onda della contestazione studentesca del ’68. Quando il fratello viene arrestato (’72) entra a far parte dell’allora Soccorso Rosso fiorentino. L’esperienza diretta, la grande sensibilità nei confronti delle esigenze del proletariato detenuto la portano alla spontanea scelta verso questo settore di intervento.
Vive dall’interno le contraddizioni dei “nuclei carceri” di Lotta Continua.
 Di sua iniziativa prende contatti con altri detenuti ed ex-detenuti, con i quali mantiene rapporti sempre più intensi: sono loro lo stimolo principale alla sua maturazione politica, il suo punto di riferimento ed è con loro che critica le posizioni attendeste di LC.
Di sua iniziativa prende contatti con altri detenuti ed ex-detenuti, con i quali mantiene rapporti sempre più intensi: sono loro lo stimolo principale alla sua maturazione politica, il suo punto di riferimento ed è con loro che critica le posizioni attendeste di LC.
Dopo una breve militanza in Potere Operaio ne esce per dar vita insieme ad altri compagni al Collettivo G. Jackson.
Il radicalizzarsi delle posizioni all’interno e all’esterno del carcere la rendono cosciente della necessità di operare sui livelli più avanzati dello scontro, ciò la spinge ad approfondire i rapporti con i compagni dei NAP.
Con l’assassinio di due di loro durante un’azione di autofinanziamento viene a rompersi un legame politico e umano fortissimo. “E’ inutile che io nasconda dietro la mia fede politica la mutilazione grossissima che ho avuto” scrive ad un mese dalla morte del fratello.
Ma non per questo affretta o decelera una scelta che già da tempo aveva fatto. La maturità politica, la carica umana, l’odio profondo per l’istituzione carceraria la vedono fondatrice del nucleo 29 Ottobre. Verrà assassinata a 22 anni, ma come spesso ripeteva lei stessa: “E se la morte ci sorprende all’improvviso, che sia la benvenuta, purchè il nostro grido di guerra giunga ad un orecchio che lo raccolga, un’altra mano si tenda per impugnare le nostre armi e altri uomini si apprestino ad intonare canti funebri con il crepito delle mitragliatrici e nuove grida di guerra e di vittoria.”
QUI, il mio omaggio agli altri compagni uccisi dallo stato: omaggio che giorno dopo giorno cerco di completare per non dimenticare nessun@
A loro, sangue nostro.
A Roberta, la compagna di Aldo Bianzino
Abbiamo conosciuto Roberta nei giorni successivi alla morte di Aldo,
giorni drammatici, durissimi, di intense mobilitazioni.
Abbiamo conosciuto la sua forza d’animo, la sua rabbia, la sua voglia di
lottare e il suo desiderio di conoscere la verità.
Una verità insabbiata, nascosta, che non riesce a venire fuori.
Roberta se ne è andata nel silenzio, senza riuscire a conoscerla.
Roberta Radici è la compagna di Aldo Bianzino, il falegname morto
misteriosamente nel carcere perugino di Capanne, la notte del 14 ottobre
2007. Aldo, insieme a Roberta, era finito in carcere con l’accusa di
possedere e coltivare alcune piante di marijuana e dal quel luogo non è
più uscito vivo.
Da allora, insieme a Roberta e suo figlio Rudra, insieme a Gioia (ex
moglie di Aldo) e ai figli Elia e Aruna, come Comitato Verità
per Aldo;, abbiamo organizzato manifestazioni, iniziative, presidi e
volantinaggi affinché si facesse luce su questa vicenda.
Mercoledì 1 luglio alle ore 9.00 presso il Tribunale di Perugia si terrà
l’udienza preliminare relativa alla richiesta di rinvio a giudizio della
guardia carceraria in servizio durante quella notte, per il reato di
omissione di soccorso.
Oggi che Roberta non c’è più, sentiamo, ancora più forte, l’esigenza di
continuare a lottare insieme a Rudra, rimasto solo, e a tutti gli altri
familiari. Continueremo insieme.
PERCHE’ IN CARCERE PER UNA PIANTA D’ERBA NON SI DEVE FINIRE
PERCHE’ IN CARCERE NON SI PUO’ MORIRE
COMITATO VERITA’ PER ALDO
Ad Antonio Lo Muscio
ANTONIO LO MUSCIO
– Nasce a Trinitapoli (FG) il 28 marzo 1950
– Non risponde alla chiamata per il servizio militare ed è quindi arrestato nel 1970 dove rimane per 2 anni
– torna in carcere più volte
– nel 1975 lavora alla Fargas di Novate milanese per qualche tempo
– milita nei Nuclei Armati Proletari
– viene ucciso dai carabinieri a Roma, il 1 luglio 1977
Scritture di Antonio Lo Muscio
– “Lettera ad un amico”, carcere di Procida, 5 Marzo 1974
Caro compagno spero tanto che tu stia sempre bene. Quando uscirò oltre a lavorare normalmente, cercherò di svolgere anche un certo lavoro politico coinvolgendo se sarà possibile gli stessi elementi che ieri come me vivevano al di fuori della realtà. In un mondo diverso da quello reale dove si vede nel denaro la sola via d’uscita, così come ci ha insegnato la borghesia, che con i soldi fa e disfa a suo piacimento. Bisogna far capire loro come ho capito io che chi ha il potere di fare e disfare a suo piacimento è uno solo, il popolo. E’ questa la vera forza che fa cambiare il mondo, e non il denaro. Tutte le soddisfazioni ce le potremo prendere una volta abbattuti gli sporchi capitalisti e tutte le forze reazionarie esistenti. Solo quando questo sarà attuabile tutti gli uomini si potranno ritenere uomini, oggi siamo sulla via di transizione, cioè uomini lo stiamo diventando solo ora.
– “Lettera ad un amico”, carcere di Perugia, 5 Gennaio 1975
Carissimo compagno, come sai fra non molto sarò fuori precisamente fra 18 giorni. Di questo sono contentissimo per il fatto che uscendo potrò veramente dedicarmi alla lotta politica e in questo modo darò un significato alla mia stessa vita. Dico questo in riferimento a ciò che ero prima, cioè prima che entrassi in carcere. Sono del parere, se il tempo della detenzione viene usato bene, che, almeno una volta, tutti, senza escludere nessuno, dobbiate venire in carcere a vedere da vicino quello che veramente è l’istituzione carceraria e la sua violenza.
Testimonianze al Progetto Memoria
– Silvana Innocenzi, Testimonianza al Progetto Memoria, Firenze 1995
“Un ragazzo intelligente, timido e sensibile. Un sorriso spontaneo, carico di tenerezza e di entusiasmo per la vita. Così la mia mente ricorda il primo incontro con Antonio. Mi colpì la disponibilità e la generosità che aveva nei confronti degli altri, la sua capacità di ascoltare.
Bello, dicevano le compagne che lo incontravano o che hanno avuto modo di conoscerlo nella sua passione politica. Io ero rimasta affascinata dal suo carattere, dal suo mondo interiore. […]
Arrivò il servizio militare e venne inviato a Como proprio mentre era nata un’intensa storia d’amore. La ragazza rimane incinta ( un figlio che poi non nascerà a causa di un aborto spontaneo )… e lui la raggiunge… la classica fuga.
Viene raggiunto a casa e dichiarato in stato di arresto. Ne nasce un tafferuglio… processato e condannato venne rinchiuso nel carcere di Forte Boccea e poi a Gaeta. E’ l’inizio dell’impatto con il carcere.
Il padre iscritto al PCI discuteva spesso con lui. Discussioni animate in cui Antonio, con la passione politica che aveva maturato contestava al padre la politica riformista e revisionista del PCI. In quegli anni lui era ideologicamente più vicino alla sinistra extraparlamentare. Fin da ragazzo era alla continua ricerca di un mondo diverso, più giusto, con meno differenze sociali, con meno sfruttamento e meno emarginazione.
Il suo primo sguardo l’ho incrociato dietro un bancone di una sala colloqui del carcere di Perugia. Era finito lì, dopo la detenzione militare, per un reato definitivo di furto.
 A Perugia insieme ad altri compagni aveva dato vita al Collettivo delle Pantere Rosse, sull’onda del movimento delle Black Panthers americane. […]
A Perugia insieme ad altri compagni aveva dato vita al Collettivo delle Pantere Rosse, sull’onda del movimento delle Black Panthers americane. […]
I nostri incontri a colloquio, erano dei momenti intensi di confronto e scambio, di comunicazione tra realtà diverse. Io che frequentavo il movimento di liberazione della donna e lui che mi parlava dell’assurda vita coatta. Delle vite e delle sofferenze che erano rinchiuse all’interno delle mura di un carcere. Dell’uso dei letti di contenzione e dei manicomi giudiziari per le persone che meno si adattavano alla vita del carcere, alle sue regole.
Era felice quando poteva comunicarmi una piccola conquista interna, sia che si trattasse di spazi di socialità, di condizioni lavorative migliori o della possibilità di far entrare libri e altro materiale scritto senza l’intervento della censura.
Era felice perché stava cambiando qualcosa e si rendeva contro che poteva farlo anche all’interno di un’istituzione così totale come è, ed era, il carcere.
Mi regalò il libro Col sangue agli occhi di Jackson. “Leggilo, mi disse, dimmi cosa ne pensi, secondo me è stupendo”.
Lo lessi e capii che lui lì ritrovava tutte le sue emozioni più forti: rabbia, odio, amore. Non amava il sottoproletariato di Marx, amava il proletariato di Fanon.
Intanto le rivolte nelle carceri aumentavano e quella del carcere di Alessandria fece discutere più di tutte. C’erano stati dei morti tra il personale civile sequestrato.
Alcuni detenuti della rivolta finirono anche a Perugia e iniziò anche lì un’attiva campagna di controinformazione su quanto era realmente accaduto durante il sequestro degli ostaggi,
Sognare, realizzare un’evasione è il desiderio più vivo di ogni recluso per sottrarsi ad una situazione che, per quanto può essere vivibile, toglie il bene più importante: la libertà dell’individuo.
“Liberare tutti” era il messaggio più radicato tra i detenuti di quegli anni.
Alla rabbia istintiva, individuale, cosciente di molti detenuti, i Nuclei Armati Proletari diedero una progettualità collettiva e rivoluzionaria.
Antonio ci si ritrovò.
Un giorno con discrezione mi diede un foglietto dattiloscritto, voleva sapere cosa ne pensavo. Erano delle riflessioni sulla lotta armata, sulla sua possibilità e necessità. Non riuscii subito a dargli una risposta, ero solo cosciente che lì, in carcere più che altrove, le mediazioni non erano possibili.
Uscì nel 1974. Mi presi dei giorni di ferie dal lavoro e l’aspettai all’uscita. Fu sorpreso. Aveva i capelli lunghi, la barba e un cappotto lungo che gli davano un aspetto particolare, tra l’originale e il demodé. […] Furono momenti stupendi. E solo oggi che ho anche io vissuto l’esperienza del carcere posso coglierne ulteriori sfumature.
Cercò i compagni che conosceva, gli amici che da tempo non rivedeva. Alcuni lavoravano in fabbrica e lo invitarono alle loro riunioni. Io a Roma, lui a Milano, ma continuammo a vederci circa ogni 15 giorni.
Il carcere però non lo aveva dimenticato, soprattutto non aveva dimenticato le persone che aveva lasciato e che voleva aiutare ad uscire da quei luoghi di non vita. Continuammo ad andare ai colloqui e a seguire alcuni compagni nei bisogni più immediati.
Intanto nel suo cuore c’era la speranza di entrare in contatto con i compagni dei NAP che iniziavano a fare le loro prime azioni.
Ma il passaggio decisivo alla lotta armata avvenne quando la polizia uccise a Roma, sul pianerottolo di casa, la compagna Anna Maria Mantini (presto questo blog dedicherà una pagina anche a lei). L’aveva conosciuta, apprezzata, stimata moltissimo. Ne discutemmo a lungo di questa sua morte. Non ci volle molto a capire che avrebbe continuato la sua lotta. […] La mia scelta non tardò ad arrivare.
Vivere con lui un periodo della mia militanza nei NAP è stato di un’enorme ricchezza. Era la prima volta che dividevamo insieme più cose, dalla quotidianità al grande sogno di un mondo diverso. Non c’è mai stata tra noi una grande divisione di ruoli, ci alternavamo in molte cose; quello che detestava era fare acquisti, anche quanto le cose servivano a lui. Non viveva la sua scelta separata alle altre dimensioni della vita. La sua concezione di guerriglia conciliava con tutto: azioni, amore, famiglia e figli. Tutto era un unico grande filo rosso.
Viaggiavamo sempre molto uniti, tanto da diventare oggetto di simpatica ironia per gli altri compagni.
L’ultima immagine che ho di lui vivo è quella della separazione alla stazione Termini. Io partivo per Torino, per incontrare dei compagni, e lui mi aveva accompagnato. Non voleva farmi partire, ma io insistetti. Mi girai più volte a guardarlo andare via e giurammo che al ritorno avremmo mollato tutto per festeggiare il mio compleanno.
Ma non potemmo farlo. Appena arrivata a Torino fui arrestata.
Mi raggiunge anche in carcere con simpatiche cartoline, brevi, affettuose, cariche di emotività, quasi a voler colmare il vuoto e la distanza che si era creata materialmente tra noi.
Intanto i compagni continuavano ad essere arrestati, la caccia all’uomo era diventata sempre più accerchiante, e la vita per lui e per gli altri non deve essere stata facile negli ultimi periodi.
Poi un giorno, il primo luglio 1977, la terribile notizia appresa da un banale giornale radio tra le mura di una cella di Marassi, a Genova.
Ucciso durante un conflitto a fuoco con i carabinieri a Roma, piazza san Pietro in Vincoli, vicino alla facoltà di ingegneria, all’età di 27 anni, mentre tentava di sfuggire all’arresto con altre due compagne.
Falciato dalle raffiche di mitra fu poi freddato con una pallottola sparata a pochi centimetri dalla nuca. Non volevano arrestarlo, ma ucciderlo.
Non ci rivedemmo più.
Da una testimonianza raccolta da un giornalista del Corriere della Sera e pubblicata il 2 luglio: “Prima è passato di corsa quel giovane, Lo Muscio, inseguito da un carabiniere che sparava raffiche di mitra. E’ caduto proprio a pochi metri dall’ingresso della facoltà, cercando di sostenersi con le braccia e urlando per il dolore.
E’ a questo punto che il carabiniere, fatti pochi passi, ha lasciato partire un’altra raffica e Lo Muscio è stato fulminato. Gli ultimi colpi sono stati sparati dal carabiniere con una pistola.”
– Amici di Antonio, testimonianza collettiva al Progetto Memoria, Roma 1995
“Antonio l’ho conosciuto in carcere, nelle prime lotte. E’ diventato un compagno dei NAP proprio stando insieme a noi. Antonio era un compagno generoso, molto disciplinato. Quando si accostò al collettivo di Perugia doveva uscire di lì a poco. Gli dissi, se vuoi conoscere un compagno eccezionale, vai a questo indirizzo, e gli diedi l’indirizzo di Luca Mantini (anche di Luca ne parleremo presto ). Lui uscì. E per quanto sembri incredibile, era la sera di Piazza Alberti, del giorno in cui Luca era morto in piazza Alberti. Naturalmente non poteva saperlo e andò in casa di Luca. Lì trovò Annamaria.
Vennero a casa mia insieme quella sera e fu la prima volta che lo vidi. Dopo di allora ci siamo incontrati molte volte. Con me non aveva un rapporto politico, era una cosa un po’ strana, un rapporto molto umano. Antonio era un tipo gioviale, festoso. Cantava. In macchina cantava sempre. Ricordo di un viaggio con Antonio.
Me lo ricorderò tutta la vita. Prendemmo un vassoio, pesante come un macigno. E partimmo. Attraversando mezza Italia. E durante tutto il viaggio, sebbene spossato di stanchezza, cantava. […] Si fermò all’alba in un negozio di alimentari, comprò un po’ di gnocchi di patate. Poi, da un’altra parte, del pomodoro crudo. Li condimmo così, a mano. Al controllo dei cibi, in carcere, comunque mi restituirono il vassoio con tutti quegli gnocchi, e mi dissero seraficamente di metterli in un contenitore di plastica… Mi ricordo quest’ episodio perché dice come era fatto Antonio: se c’era da fare una cosa, lui partiva all’una di notte, attraversava l’Italia e la faceva, con allegria. Antonio era subito disponibile, sempre allegro, ti sapeva mettere subito a tuo agio.
QUI, un’intervista a Franca Salerno, arrestata e pestata (con un bel pancione) insieme Maria Pia Vianale mentre Antonio veniva giustiziato.
Al-Molky è stato espulso verso la Siria
Appena tre giorni fa salutavamo da questo blog Khaled Husseini, morto nel carcere di Benevento a 79 anni, da tempo malato ma malgrado questo rinchiuso in regime di Elevato Indice di Vigilanza in un braccetto speciale.
Oggi, inaspettatamente è stato espulso (in queste ore lo staranno imbarcando su un volo per Damasco) Yussef MAged Al-Molki, che ha già scontato più di 23 anni nelle carceri italiane e a fine pena era stato rinchiuso in un centro di identificazione ed espulsione. Le autorità italiane hanno aspettato l’ultimo giorno dei 60 che avevano a disposizione per comunicargli l’espulsione.
ACHILLE LAURO: ESPULSO AL MOLKY, VADO VERSO LA MORTE . PRELEVATO A SORPRESA (ANSA) – GENOVA, 27 GIU –
«Mi hanno usato come merce di scambio fra Italia e Siria. Mi stanno mandando verso la morte». Sono le ultime parole, una disperata denuncia lanciata con il cellulare, di Youssef Maged Al Molky, 47 anni, il palestinese ritenuto tra i principali responsabili del sequestro della nave da crociera Achille Lauro, avvenuto nel 1985, ed oggi espulso a sorpresa con destinazione Siria. Al Molky, condannato a 30 anni di reclusione dalla Corte d’Assise di Genova per quel sequestro e l’uccisione di un passeggero statunitense di origine ebraica, Leon Klinghofer, ha scontato 23 anni e 8 mesi di carcere, pena ridotta per buona condotta.  Appena uscito dall’Ucciardone, nell’aprile scorso, aveva ricevuto un ordine di espulsione nei confronti del quale hanno però fatto ricorso i suoi legale, Gianfranco Pagano, del foro di Genova, e Maria Stella Pagano, di Palermo. Secondo i legali, Al Molky, nato in Palestina da padre giordano e madre siriana, e sposato da 5 anni con una donna italiana che vive in Piemonte, «non ha una cittadinanza riconosciuta, è sposato in Italia e secondo la sentenza deve ancora scontare tre anni di libertà vigilata». In attesa della decisione del giudice di pace di Palermo sul ricorso, Al Molky è stato rinchiuso nel centro di accoglienza Serraino Vulpitta di Trapani. Oggi, a sorpresa, mentre ancora si attende la sentenza del giudice di pace, Al Molky è stato prelevato dalla polizia e condotto a Roma da dove a tarda sera sarà imbarcato su un aereo con destinazione Damasco. Secondo quanto riferito alla moglie prima che fosse privato del telefono cellulare, all’uomo sarebbe stato consegnato un lasciapassare della Siria con il quale il Paese arabo accetta di accoglierlo sul suo territorio. «Vado verso la morte» ha continuato a ripetere Al Molky durante il trasferimento da Palermo a Roma. Ed il suo avvocato, da Genova, conferma che «poichè molti reati legati alla vicenda dell’Achille Lauro furono compiuti nelle acque territoriali siriane, le possibilità che possa essere condannato a morte sono molto alte». «Ho pagato le mie colpe – ha aggiunto l’ex terrorista – ed ora vengo scaricato da un Paese che si definisce democratico». Il legale genovese chiarisce anche che nelle scorse settimane, su interessamento dell’Autorità palestinese, l’Algeria si era dichiarata disposta ad accogliere Al Molky, ma l’uomo si era rifiutato di accettare la proposta ritenendo che, essendo sposato con una italiana, potesse rimanere a vivere in Italia al fianco della moglie. «È assurdo ed incredibile – commentano ora i due legali – che venga adottato un provvedimento di espulsione prima che il giudice si sia pronunciato. Siamo pronti a chiedere immediatamente il ricongiungimento familiare».
Appena uscito dall’Ucciardone, nell’aprile scorso, aveva ricevuto un ordine di espulsione nei confronti del quale hanno però fatto ricorso i suoi legale, Gianfranco Pagano, del foro di Genova, e Maria Stella Pagano, di Palermo. Secondo i legali, Al Molky, nato in Palestina da padre giordano e madre siriana, e sposato da 5 anni con una donna italiana che vive in Piemonte, «non ha una cittadinanza riconosciuta, è sposato in Italia e secondo la sentenza deve ancora scontare tre anni di libertà vigilata». In attesa della decisione del giudice di pace di Palermo sul ricorso, Al Molky è stato rinchiuso nel centro di accoglienza Serraino Vulpitta di Trapani. Oggi, a sorpresa, mentre ancora si attende la sentenza del giudice di pace, Al Molky è stato prelevato dalla polizia e condotto a Roma da dove a tarda sera sarà imbarcato su un aereo con destinazione Damasco. Secondo quanto riferito alla moglie prima che fosse privato del telefono cellulare, all’uomo sarebbe stato consegnato un lasciapassare della Siria con il quale il Paese arabo accetta di accoglierlo sul suo territorio. «Vado verso la morte» ha continuato a ripetere Al Molky durante il trasferimento da Palermo a Roma. Ed il suo avvocato, da Genova, conferma che «poichè molti reati legati alla vicenda dell’Achille Lauro furono compiuti nelle acque territoriali siriane, le possibilità che possa essere condannato a morte sono molto alte». «Ho pagato le mie colpe – ha aggiunto l’ex terrorista – ed ora vengo scaricato da un Paese che si definisce democratico». Il legale genovese chiarisce anche che nelle scorse settimane, su interessamento dell’Autorità palestinese, l’Algeria si era dichiarata disposta ad accogliere Al Molky, ma l’uomo si era rifiutato di accettare la proposta ritenendo che, essendo sposato con una italiana, potesse rimanere a vivere in Italia al fianco della moglie. «È assurdo ed incredibile – commentano ora i due legali – che venga adottato un provvedimento di espulsione prima che il giudice si sia pronunciato. Siamo pronti a chiedere immediatamente il ricongiungimento familiare».
E’ STATO IMBARCATO ALLE 22,30 DALL’AEREOPORTO DI FIUMICINO.
Morire in cella, a 79 anni. Un saluto a Khaled Husseini, combattente palestinese
Pensare un uomo di 79 anni chiuso in una cella fino al giorno della sua morte è già cosa difficile. Ancora più difficile e lacerante è pensarlo in un reparto ad Elevato Indice di Vigilanza, in un braccetto speciale di un carcere meridionale. Khaled Husseini, palestinese di 79 anni è morto nel carcere di Benevento lunedì scorso. Il medico legale ha parlato di un probabile infarto ma soltanto l’autopsia fornirà le cause esatte del decesso, forse legate alla malattia che il carcere gli aveva sempre impedito di curare in modo adeguato.
Malgrado fosse stato condannato per un fatto che poco aveva a che fare con reati di matrice islamica, Khaled Husseini era rinchiuso in un reparto appositamente ideato per detenuti del genere. Singolare paradosso, discordanza di tempi per un militante laico e rivoluzionario impegnato nel tortuoso percorso che segna da molti decenni la lotta per la liberazione della terra e del popolo di Palestina.
Era stato condannato per il dirottamento della nave da crociera Achille Lauro, realizzato nel 1985 da un commando di quattro palestinesi appartenenti al Fronte di Liberazione della Palestina. In realtà l’azione era stata concepita in modo diverso: l’obiettivo non era il sequestro dei passeggeri ma lo sbarco nel porto di Ishdud, dove il commando doveva catturare dei soldati israeliani e chiedere in cambio la liberazione di alcuni prigionieri palestinesi. Ma a largo delle coste egiziane qualcosa andò storto e il commando, vistosi scoperto, si impadronì della nave. Fu un gesto improvvisato durante il quale un passeggero, Leon Klinghoffer, venne ucciso e gettato in mare. La vicenda si trasformò nel più grosso incidente diplomatico tra Italia e Usa. Ottenuto un salvacondotto da parte italiana, la nave fu lasciata libera e i quattro palestinesi fatti salire a bordo di un aereo egiziano diretto verso Tunisi, dove l’OLP aveva il suo quartier generale in esilio. Ma gli Stati uniti intercettarono il velivolo costringendolo ad atterrare nella base Nato di Sigonella, in Sicilia. Il capo del governo Craxi rifiutò di consegnare il commando agli americani. La polizia italiana prese in consegna i palestinesi facendo valere la sovranità nazionale. Khaled Husseini non era tra loro. Dopo una prima condanna a 15 anni, in appello verrà condannato all’ergastolo in contumacia, nel 1989, sulla base delle parole di un appartenente al gruppo che scelse di iniziare a collaborare con la magistratura italiana, designandolo 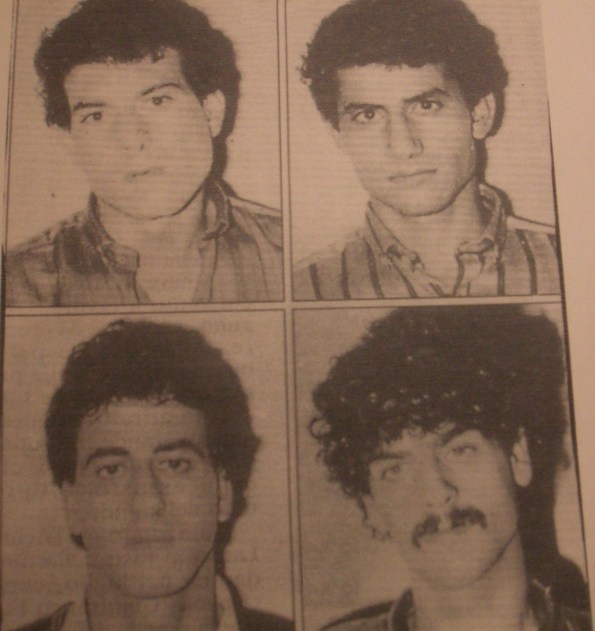 come il responsabile operativo del commando, anche se Hussein non aveva ideato il sequestro e l’uccisione dell’ostaggio. Aveva accompagnato il gruppo a bordo dell’Achille Lauro nel porto di Genova, per scendere durante lo scalo ad Alessandria, poco prima del dirottamento.
come il responsabile operativo del commando, anche se Hussein non aveva ideato il sequestro e l’uccisione dell’ostaggio. Aveva accompagnato il gruppo a bordo dell’Achille Lauro nel porto di Genova, per scendere durante lo scalo ad Alessandria, poco prima del dirottamento.
Con lui prenderà l’ergastolo, sempre in contumacia, anche Abu al-Abbas, responsabile politico dell’organizzazione (catturato dagli americani nel 2003 in Iraq, subito dopo l´inizio dell’occupazione militare, per morire dopo appena 2 mesi in circostanze più che sospette nel carcere di Abu Grahib).
Per Khaled Husseini il calvario nelle carceri italiane inizia invece nel 1996, quando l’Italia riesce ad ottenere l’estradizione dalla Grecia, dove era stato arrestato 5 anni prima. Khaled ha scontato la sua pena fino alla morte nel peggiore dei modi, in condizioni estremamente pesanti e in un isolamento quasi totale: gli è stato sempre negato il diritto ad un tutore e per anni è rimasto privo di colloqui.
Il trasferimento nel braccetto speciale di Benevento è stato fatale per le sue condizioni di salute. In quella sezione, oltre alle bocche di lupo che non fanno filtrare la luce e non permettono di vedere all’esterno, c’è anche un pannello di plexiglas a dividere la cella dal resto del mondo mentre nel cortile del passeggio una volta metallica sostituisce il cielo. Il trattamento riservato ai detenuti è rigido e la burocrazia per accedere a cure e permessi, lenta e ostacolata. Pochi giorni prima di morire aveva chiesto un permesso per iniziare le cure all’esterno, ma gli era stato negato.
Khaled se n’è andato senza nemmeno il diritto di vedere il colore del cielo nell’ultimo giorno. È morto con la sua terra nel cuore, la terra che aveva sempre infinitamente amato e che aveva sognato di liberare. Ma non è un mondo per sognatori, questo qui.
di VALENTINA PERNICIARO, L’ALTRO -24 giugno 2009-
A Lorenzo Bortoli, 30 anni dopo la sua morte
LORENZO BORTOLI
– Nasce a Torrebelvicino (VI) il 23 dicembre 1954
– Si diploma e lavora come operaio decoratore alla Blue Bell di Bassano
– milita nel movimento studentesco
– convive con Maria Antonietta Berna, nella casa di Thiene dove avviene l’esplosione dell’11 febbraio 1979
-viene arrestato il 12 febbraio 1979 nell’inchiesta sui Collettivi Politici Veneti
-muore suicida nel carcere di Verona, il 19 giugno 1979
Scritture di Lorenzo Bortoli
– Verbale di confronto tra coimputati, Padova 15-6-79
“Il Bortoli al P.: “Ripeto ancora una volta che è falso quello che tu hai detto; ricordati di questo particolare: nella comune cella, mentre giocavamo a carte io ho estratto di tasca l’ultimo mandato di cattura notificatomi e nel leggerne la motivazione dove si faceva cenno a dichiarazioni di coimputati ebbi un moto di sorpresa; tu spontaneamente mi dicesti che eri stato tu e che avevi riferito su confidenze non vere perché ti era stata promessa dagli inquirenti la derubricazione delle imputazioni e la concessione della libertà provvisoria.”
– Foglio di richiesta, Carcere di Verona 18-6-79
“Al signor direttore della casa circondariale di Verona.
Le sarei veramente grato se potesse far pervenire ai miei familiari il seguente telegramma: “Raggiunto Antonia. Vi prego di essere sepolto con lei. Vi assicuro che sto bene così. Un abbraccio. Dite a Vanna di non piangere, ma di ricordarsi come eravamo felici come ora che siamo nuovamente insieme. Lorenzo”
La pregherei di far pervenire anche il gruppo di fotografie, difalcando le spese dal mio conto personale. La ringrazio vivamente.
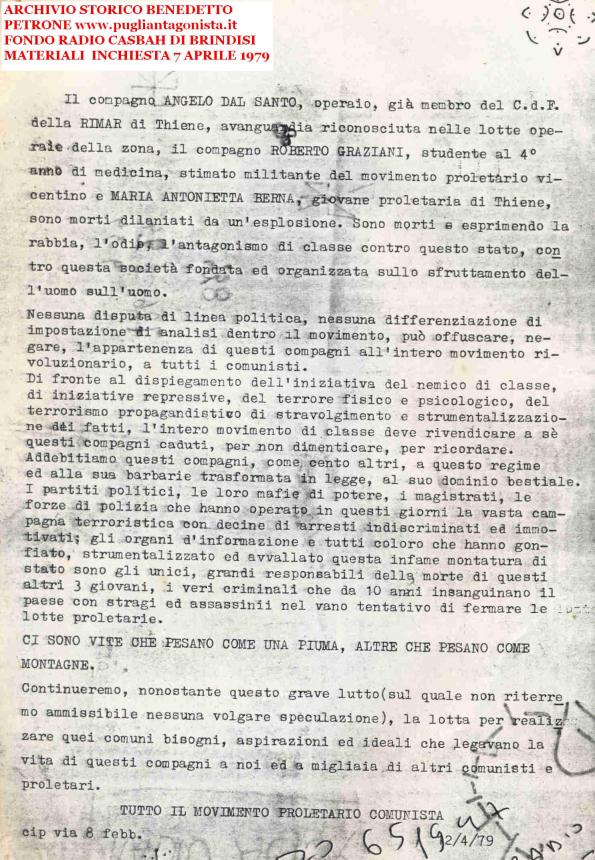 Documenti prodotti da organizzazioni armate:
Documenti prodotti da organizzazioni armate:
-Movimento Comunista Organizzato, Manifesto A Lorenzo Bortoli 19-6-80
“Questo non vuole essere un epitaffio commemorativo, tu per primo non lo vorresti. Lasciamo alla società borghese la misera forma ipocrita di commemorare i propri morti.
Noi vogliamo ricordarti da comunista, da proletario in lotta contro la barbarie del capitale, dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, delle morti “bianche” e per aborto, del rifiuto ad una vita invivibile. Questo è un filo rosso che unisce la tua vita alla nostra, la tua militanza comunista alla vita di milioni di proletari che quotidianamente lottano contro i propri sfruttatori. La tua vita continua in noi nella volontà e nell’impegno che ci assumiamo nel non voler dimenticare chi ti ha costretto al suicidio.
Certo credevano attraverso la tua morte di annientare e terrorizzare centinaia di compagni che come te lottavano e soffrivano in carcere mentre in realtà la tua morte ha smascherato ancora una volta e per sempre chi si nasconde dietro il paravento della legge e della democrazia.
La tua scelta è stata una forma di lotta, non una sconfitta. Questo tutti i rivoluzionari ed i veri comunisti lo hanno capito.
Mai dimenticheremo con quanto odio le bande armate di Dalla Chiesa ti hanno aggredito; come il PM Rende ha pianificato sin dall’inizio la tua morte, attraverso l’isolamento, il non ricovero in ospedale dopo il tuo primo tentativo di suicidio, con la provocazione dell’inserimento con te in cella del burattinaio vigliacco C.P.
Vogliamo gridare guardandoli in faccia tutto il nostro odio verso queste figure, vogliamo che sentano continuamente tutto il nostro disprezzo proletario: spregevoli giocattoli nelle mani dei loro padroni.
Certamente questo non ti farà essere fisicamente tra noi. Tu vivi nella nostra irriducibilità al sottometterci allo Stato del capitale, vivi nel nostro bisogno di comunismo. Per tutto questo ti onoriamo e ricordiamo.
O tutti o nessuno.
Onore a Lorenzo, Angelo, Alberto e Antonietta.
Per il comunismo.
Documenti prodotti da gruppi sociali:
– Comitato di zona Partito Comunista Italiano, “Un suicidio che riempie di sdegno, Thiene 21-6-79
“Apprendiamo con profondo sgomento e indignazione la notizia della morte, nel carcere di Verona, di Lorenzo Bortoli. E’ accaduto ciò che si temeva e ciò che le forze dell’amministrazione della giustizia erano tenute ad evitare. Era infatti evidente che dopo 2 tentativi di suicidio Lorenzo Bortoli si trovava in uno stato psicofisico di estrema prostrazione e che, in mancanza di cure adeguate, di un’attenta assistenza e sorveglianza, di un trattamento più umano e non assolutamente segregante, non avrebbe desistito nel suo intento di togliersi la vita. Proprio queste cure, questa assistenza, avevamo 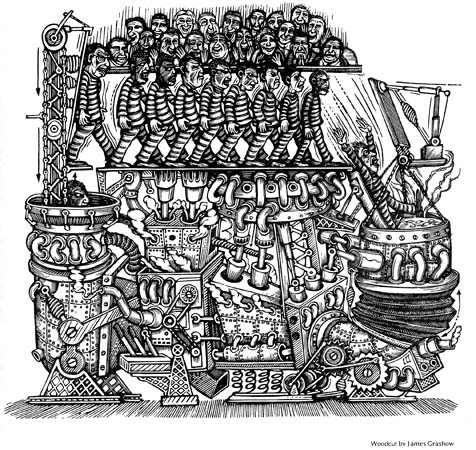 sollecitato aderendo all’appello del 30 Maggio lanciato da alcune personalità e cittadini democratici sul Giornale di Vicenza. Anche alla luce di ciò, il comportamento delle autorità giudiziarie e dell’amministrazione carceraria è tale da suscitare sdegno e riprovazione, in quanto si è dimostrato insensibile e incurante verso il diritto fondamentale di ogni essere umano: il diritto alla vita, e verso i diritti costituzionali di un imputato di potersi difendere, nella pienezza delle proprie facoltà intellettuali e fisiche, dalle accuse mossegli. Il suicidio di Lorenzo Bortoli è quindi un fatto di eccezionale gravità. Le responsabilità nel comportamento delle autorità carcerarie e giudiziarie vanno perciò indgate e punite, per salvaguardare i valori dello stato di diritto e le garanzie che la Costituzione da ad ogni cittadino.”
sollecitato aderendo all’appello del 30 Maggio lanciato da alcune personalità e cittadini democratici sul Giornale di Vicenza. Anche alla luce di ciò, il comportamento delle autorità giudiziarie e dell’amministrazione carceraria è tale da suscitare sdegno e riprovazione, in quanto si è dimostrato insensibile e incurante verso il diritto fondamentale di ogni essere umano: il diritto alla vita, e verso i diritti costituzionali di un imputato di potersi difendere, nella pienezza delle proprie facoltà intellettuali e fisiche, dalle accuse mossegli. Il suicidio di Lorenzo Bortoli è quindi un fatto di eccezionale gravità. Le responsabilità nel comportamento delle autorità carcerarie e giudiziarie vanno perciò indgate e punite, per salvaguardare i valori dello stato di diritto e le garanzie che la Costituzione da ad ogni cittadino.”
– AA.VV. Frammenti di coordinamenti, collettivi, radio.
“Lorenzo Bortoli, operaio decoratore alla Blue Bell di Bassano, arrestato dopo l’esplosione dell’11 febbraio di Thiene dove era tragicamente morta la sua compagna Maria Antonietta Berna, si è tolto la vita impiccandosi nel carcere di Verona. E’ un suicidio che noi chiamiamo assassinio e del quale riteniamo responsabili tutti coloro che hanno abbandonato Lorenzo a se stesso, spingendolo prima alla disperazione con l’accusa di omicidio nei confronti della persona che amava di più, diffamandolo poi come dedito alla droga quando tentò di suicidarsi una prima e una seconda volta ingerendo dei medicinali, rifiutando infine il suo ricovero in ospedale come da tempo richiesto dal collegio di difesa e sollecitato anche da organismi sindacali e sociali della provincia, ma negato dai giudici del tribunale di Vicenza.
Tutto ciò è stato fatale per Lorenzo. L’obiettivo di questo Stato, cioè la distruzione fisica dei suoi avversari, ancora una volta è stato raggiunto. (…).
A tutte le strutture di movimento, a tutti i proletari della provincia proponiamo che la mobilitazione continui e si allarghi ponendosi come obiettivo centrale la messa in stato di accusa di tutti i responsabili della morte di Lorenzo. (…)”
Dai detenuti della Dozza
I detenuti dei reparti giudiziari hanno deciso di attuare una protesta pacifica, lo sciopero della fame, a partire dal giorno 17 giugno c.a. e della durata di giorni *7*, con lo scopo di sensibilizzare le autorità e l´opinione pubblica delle condizioni in cui si è costretti a vivere in codesto istituto:
1. *Sovraffollamento celle:* costruite per ospitare un detenuto, ce ne vivono tre;
2. *Educatori:* ci sono detenuti, con posizione giuridica definitiva da diversi anni e non hanno mai interloquito con il proprio educatore;
3. *Sanità:* mancanza di specialisti, pazienti con patologie gravi, sono costretti a comprarsi i farmaci, mentre chi si trova in precarie condizioni economiche non può acquistare i medicinali, con il conseguente aggravio delle proprie patologie;
4. *Locale Docce:* sporche e costretti a lavarci spesso con acqua fredda anche durante il periodo invernale;
5. *Telefono:* l´apparato telefonico è ubicato al centro del corridoio, e si è continuamente disturbati, durante il colloquio con i familiari, dal rumore;
6. *Montaggio di grate alle finestre:* premesso che avevamo richiesto di renderci partecipi affinchè fosse fatto un ultimo tentativo nel sensibilizzare, attraverso una commissione composta anche da detenuti, una minima percentuale di detenuti che ancora non riesce a comprendere il danno, gettando i rifiuti dalla finestra, che provocherà il montaggio definitivo delle grate alle stesse. Infatti,la maggioranza dei detenuti non ritiene corretto subire una restrizione così drastica a causa di una esigua minoranza; soprattutto in questo periodo in cui stiamo collaborando con itecnici dell´Hera per poter contribuire ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Il montaggio delle grate riduce notevolmente l´areazione e l´ingresso della luce che porterà sicuramente ad un deterioramento della vista, a scompensi fisici, a forme depressive e tutto ciò porterà ad un aggravio dell´Amministrazione Sanitaria, e quindi del contribuente, che sarà costretta a prescrivere psicofarmaci;
7. *Cambio Lenzuola:* fornite dall´Amministrazione, vengono sostituite in media ogni 40 giorni, aumentando in tal modo il rischio di malattie infettive.
Si auspica un doveroso intervento delle persone e autorità sensibilizzate attraverso questo documento.
I Detenuti della Dozza
Il New York Times attacca la giustizia italiana
Il New York Times attacca la giustizia italiana, da Reportonline, di Valentina Perniciaro
Amanda Knox, il « volto d’angelo » presunta complice nell’assassinio di Meredith ha preso parola per la prima volta davanti ai giudici della Corte d’assise di Perugia, continuando a dichiararsi innocente : « Tutto ciò che ho detto, me l’ha suggerito la Polizia. Gli agenti mi hanno picchiato, mi chiamavano stupida e bugiarda. Ciò che ho detto, l’ho detto perché messa sotto pressione. Le dichiarazioni sono state prese contro la mia volontà. Ho detto ciò che ha suggerito il pm”.
Parole pesanti, che avranno peso nel processo e forte eco sulla stampa americana che già da giorni, dopo l’articolo del premio Pulitzer Thimoty Egan sul New York Times on line, scrive dell’innocenza della studentessa e soprattutto sul processo farsa di cui lei sarebbe vittima.
Nel suo articolo Egan non usa mezzi termini contro il sistema giudiziario italiano, la stampa e soprattutto contro l’inchiesta che sta portando avanti dal primo giorno il pm Giuliano Mignini « potente procuratore italiano incriminato per comportamento scorretto che qualunque giuria seria lo avrebbe già ricusato da mesi» e difende con forza l’innocenza dell’imputata, « una studentessa altrettanto vivace della vittima la cui vita e’ stata quasi distrutta dalla collisione fra un giornalismo rapace e una procura sciatta”.
Nel suo blog il giornalista ricostruisce l’intera vicenda giudiziaria, dimostrandosi già sufficientemente scandalizzato dal primo interrogatorio che durò un’intera notte senza la presenza di un avvocato nè di un interprete. Le dichiarazioni di quella notte sono state per mesi la sola prova nelle mani degli inquirenti ed hanno permesso gli arresti di Amanda Knox e del suo fidanzato Raffaele Sollecito, dando in pasto alla stampa italiana quella che Egan descrive come una vera e propria ossessione del pm Mughini : dimostrare che l’assassinio sia avvenuto durante un’orgia con fiumi di cocaina a cui la vittima voleva sottrarsi.
Le prove trovate dopo mesi contro la coppia « appaiono difettose ed incerte », e i due continuano a dichiararsi innocenti., mentre Rudy Guede è stato già condannato a 30 anni per questo delitto.
La stampa italiana, e non solo quindi la procura che si occupa delle indagini, fa una pessima figura tra le righe del NYTimes, per la pubblicazione continua di numerosi dettagli della vita privata e dei costumi sessuali di Amanda, « una cosa che non sarebbe stata mai fatta con un uomo”.
Difficile controbattere a questa ricostruzione, anche dopo le dichiarazioni di ieri della stessa Amanda, ma soprattutto conoscendo la giustizia italiana e l’onestà di certe indagini. Chi ricorda Karol Racz e Loyos, accusati dello stupro della Caffarella sa come funzionano gli interrogatori della polizia e come la stampa è pronta a sciacallare e ad invocare il boia. Certo è difficile immaginare che quello sia il viso di un’assassina, ma non siamo soliti usare metodi lombrosiani per arrivare ai verdetti, nè però, lo ammettiamo, per questi abbiamo un grande amore, privatori di libertà e chiavistellatori di vite umane.
La verità sull’indulto
Redattore Sociale – Dire, 23 maggio 2009
Parla Giovanni Torrente, docente di Sociologia giuridica e autore della ricerca “Indulto. La verità, tutta la verità, nient’altro che la verità”: nove persone su dieci non sono tornate a delinquere.
Si può parlare davvero di fallimento dell’indulto? Le carceri sempre più piene e straripanti hanno davvero riaperto le porte a persone che perlopiù avevano beneficiato della legge? Non ne è per nulla convinto Giovanni Torrente, docente di Sociologia giuridica dell’Università della Valle d’Aosta e autore della ricerca “Indulto. La verità, tutta la verità, nient’altro che la verità”. Anzi, l’esperto garantisce il contrario: la recidiva degli indultati è assolutamente sotto la media.
La sua considerazione sul non fallimento dell’indulto nasce da un monitoraggio attento dei dati relativi agli ingressi e ai reingressi nelle strutture penitenziarie nel periodo successivo al varo della legge nel 2006: “La televisione e i giornali ci dicevano che molte persone uscite in questo modo dal carcere vi erano rientrate a distanza di pochi giorni. Ma spesso i media dicono le cose senza porsi il problema di verificarle, per questo è nata la mia ricerca che ha smentito questo luogo comune” ha infatti spiegato nel corso della giornata di studi “Prevenire è meglio che imprigionare”.
Lo studio, infatti, ha analizzato i dati relativi ai 27.607 detenuti usciti con l’indulto e a un campione di 7.615 persone che beneficiavano di misure alternative. Nei 26 mesi successivi alla legge la recidiva nel primo caso si è fermata al 26,9%, mentre nel secondo caso è risultata al 18,57%. “Questi dati significano che nove persone su dieci non sono tornate a delinquere – spiega Torrente -. La media degli indultati tornati in carcere risulta dunque inferiore rispetto a quella del dato complessivo sulla recidiva che tocca quota 68%”. Si tratterebbe, secondo l’esperto, di un altro esempio di cattiva informazione che non si pone le giuste domande e non cerca le giuste verifiche, ma anche di una evidente strumentalizzazione a fini politici.
Solidarietà a Marco e Fabio
Un comunicato di ieri da Torino
SOLIDARIETA’ A MARCO E FABIO, REDATTORI DI RADIO BLACK OUT
Questa mattina il gazebo elettorale de La Destra a Porta Palazzo è stato ribaltato da un gruppo di giovani frequentatori del mercato e i fascisti sono stati anche oggetto di un lancio di verdure avariate.
Subito dopo, però, un gruppo interforze di vigili, poliziotti e alpini è riuscito a bloccare due dei contestatori: Fabio e Marco. Gli altri invece si sono dileguati, aiutati anche dalla gente, che li ha coperti
nella fuga.
Mentre un po’ di compagni, un’ora dopo, si stavano riunendo al Balon per protestare sono arrivate due notizie: la prima, pessima, era che i due erano stati portati alle Vallette mentre la seconda, ottima, era che degli sconosciuti poco prima erano riusciti a mandare in aria un gazebo di Fiamma Tricolore in corso Palestro, di fronte agli occhi attoniti dei Carabinieri che lo proteggevano.
Nel primo pomeriggio, un volantinaggio/corteo con una quarantina diccompagni ha fatto il giro di Porta Palazzo per informare gli abitanticdell’accaduto, e poi anche a San Salvario ci sono stati un paio di comizi di strada in solidarietà con gli arrestati e contro la presenza fascista in città.
I due saranno processati per direttissima lunedì mattina.
Intanto, potete mandare loro dei telegrammi a questo indirizzo:
Fabio Milan
C.C. Lo Russo e Cotugno
via Pianezza 300 – 10151 Torino
Marco Da Ros
C.C. Lo Russo e Cotugno
via Pianezza 300 – 10151 Torino
Carceri galleggianti e manodopera dei detenuti: il Medioevo avanza a passo di carica
Ansa, 14 maggio 2009
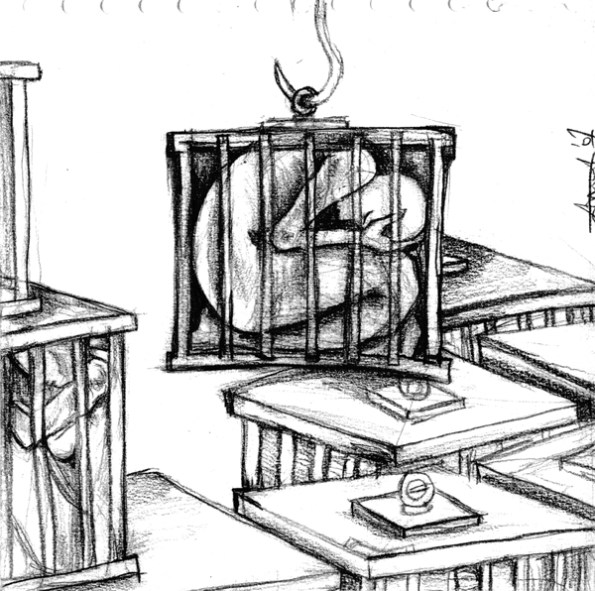 Carceri “galleggianti”, vale a dire piattaforme o navi ormeggiate a Genova, Livorno o in uno qualsiasi dei numerosi porti italiani, dove trasferire i detenuti così da risolvere l’emergenza sovraffollamento arrivata oggi a 62.473 posti occupati contro un limite regolamentare di 43.201 e una tollerabilità di 63.702. L’ipotesi – una delle tante, oltre alla costruzione di 46 padiglioni e di 22 nuovi istituti, di cui 9 già finanziati, per arrivare a un incremento complessivo di 17.129 posti – è contenuta nel piano straordinario che il capo del Dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria (Dap), Franco Ionta, ha consegnato all’inizio del mese al ministro della Giustizia Angelino Alfano.
Carceri “galleggianti”, vale a dire piattaforme o navi ormeggiate a Genova, Livorno o in uno qualsiasi dei numerosi porti italiani, dove trasferire i detenuti così da risolvere l’emergenza sovraffollamento arrivata oggi a 62.473 posti occupati contro un limite regolamentare di 43.201 e una tollerabilità di 63.702. L’ipotesi – una delle tante, oltre alla costruzione di 46 padiglioni e di 22 nuovi istituti, di cui 9 già finanziati, per arrivare a un incremento complessivo di 17.129 posti – è contenuta nel piano straordinario che il capo del Dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria (Dap), Franco Ionta, ha consegnato all’inizio del mese al ministro della Giustizia Angelino Alfano.
Nelle 19 pagine di relazione si sottolinea che la nuova edilizia penitenziaria terrà conto di “soluzioni alternative” a quelle fino ad ora adottate, anche attraverso “strutture modulari”, più economiche nella manutenzione-gestione oltre che più rapide da costruire, nonché “la previsione di strutture penitenziarie galleggianti”. Se il piano di Ionta avrà il placet del governo, l’Italia adotterà una soluzione già messa in pratica negli ultimi 20 anni in Paesi come Stati Uniti (la prima chiatta-prigione fu ormeggiata a New York nell’89, lungo il fiume Hudson), la Gran Bretagna (la nave-prigione “Weare” è stata ancorata dal 1997 al 2005 nella baia di Porland, in Dorset), e più recentemente l ’Olanda.
Utilizzo manodopera dei detenuti
Per costruire nuove carceri, oltre che per ampliare o ristrutturare quelle vecchie, saranno impiegati i detenuti, seppure soltanto per “interventi edilizi complementari”. Lo prevede il piano straordinario che il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), Franco Ionta, ha consegnato al mese al ministro della Giustizia Angelino Alfano per far fronte all’emergenza sovraffollamento detenuti. Il piano ipotizza la realizzazione complessiva, al massimo entro dicembre 2012, di 46 nuovi padiglioni in altrettanti carceri già esistenti e la costruzione di 22 nuove carceri (di cui 9 già in costruzione) per un totale di 1 miliardo e 590 milioni di euro, così da arrivare a creare 17.129 posti letto. Di questi ultimi, 4.605 saranno pronti entro un paio di attraverso l’ampliamento di carceri esistenti con nuovi padiglioni o ristrutturazioni, e la realizzazione di nuovi penitenziari già finanziati (costo complessivo 205.730.000 di euro); altri 6.201 posti, per un costo di 405milioni di euro, con fondi già individuati nella Cassa delle ammende (circa 120-130milioni di euro ai quale il commissario straordinario Ionta può ora attingere, mentre fino a due mesi fa l a Cassa era solo per il reinserimento dei detenuti), o nei fondi Fas per le aree sottosviluppate; infine 6.323 posti che costeranno 980milioni di euro con fondi ancora da individuare.
Dai detenuti della casa di reclusione di Padova
Ristretti Orizzonti, 12 maggio 2009
Il sovraffollamento delle carceri si fa sentire pesantemente anche alla Casa di Reclusione di Padova: creata per condannati a pene lunghissime ed ergastolani, ha solamente celle “singole” (8 metri quadri), che avrebbero dovuto consentire una detenzione meno gravosa per questa tipologia di detenuti e una gestione migliore della sicurezza da parte degli agenti. In realtà le celle “pensate” per una sola persona sono state subito occupate da 2 “inquilini” ed oggi ci è arrivata la notizia dell’aggiunta di una “terza branda”. Una situazione per la quale i detenuti hanno deciso una serie di “azioni dimostrative”, a partire da venerdì prossimo: rifiuto del vitto dell’amministrazione, sciopero della fame e “battitura” delle porte blindate.
Lo rendono noto in una lettera indirizzata a Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Direzione del carcere, nella quale denunciano la “sopraffazione psico-fisica subita con l’istallazione della terza branda, in celle singole che mal si adattavano a due persone”.
Protesta avvalorata anche dal parere del Dirigente Sanitario del carcere, che riterrebbe le celle di 8 mq inadatte “per una normale convivenza di tre persone, specialmente in prossimità di temperature che in estate raggiungeranno facilmente i 40 gradi”.
I detenuti concludono appellandosi alle autorità competenti perché “vogliano prendere coscienza della situazione a dir poco drammatica di chi vive sulla propria pelle, quotidianamente, l’insufficienza d’aria, di igiene e di spazio”.
La Casa di Reclusione di Padova, costruita per 350 detenuti, ne “ospita” stabilmente oltre 700 e l’aggiunta della terza branda nelle celle lascia presagire che il numero è destinato molto presto ad aumentare, probabilmente nel tentativo di decongestionare le sovraffollate Case Circondariali della Regione: nel Veneto i carcerati sono oltre 3.100, mentre i posti-branda sono appena 1.900… in altre parole ogni 100 posti ci sono 162 detenuti.
2° parte Commissione internazionale di inchiesta sulla morte di Ulrike Meinhof
Proseguo con la pubblicazione di alcune parti della Commissione internazionale d’inchiesta sulla morte di Ulrike Meinhof. Qui ci focalizzeremo un po’ di più su alcuni dettagli inquietanti sia delle due autopsie a cui è stata sottoposta, sia del ritrovamento del corpo, della sua posizione e della condizione della cella.
Affronteremo, la prossima volta, un accurata analisi degli accessi al braccio dove era detenuta, dell’illuminazione della stanza e dei verbali con gli interrogatori alle guardie penitenziarie che avevano il compito di sorvegliarla quella notte.
Qui la 1° parte della Commissione.
Qui invece la terza parte!
Presa di posizione di medici inglesi, 13 agosto 1976
“Com’è morta Ulrike Meinhof?
Il 9 maggio 1976, il mondo fu informato del ‘suicidio’ a Stoccarda di Ulrike Meinhof, quadro dirigente del gruppo Baader-Meinhof, nel carcere appositamente costruito, con misure di sicurezza particolari, in cui era stata detenuta per molti mesi prima e durante il processo. Da allora, sono venuti alla luce un certo numero di elementi che mettono in dubbio la versione ufficiale degli avvenimenti. Questi elementi hanno sollevato importanti quesiti, non solo per chi è impegnato politicamente, ma per tutti coloro che difendono le libertà civili.
Ulrike Meinhof è davvero morta per suicidi, per impiccagione? Oppure trattasi di morte per arresto cardiaco riflesso in seguito alla pressione esercitata sul suo collo da terzi? Vi è stata una violenza sessuale contro Ulrike Meinhof oppure solo un tentativo? IL significato di una risposta affermativa a una di queste domande non ha bisogno di essere dimostrato.
Sul corpo di Ulrike Meinhof sono state praticate due autopsie. Ci sono pervenuti entrambi i rapporti. Riteniamo necessario dare ampia diffusione all’opinione pubblica di questi risolutati profondamente inquietanti, sia per ciò che dicono, sia per ciò che non dicono.
Prendendo posizione, speriamo di sfuggire alle solite manipolazioni e alle deformazioni dei documenti fornitici; ugualmente desideriamo evitare l’orribile compiacimento “nel sangue dei martiri”, tanto caratteristico delle parrocchie e delle organizzazioni politiche. La linea politica di Ulrike Meinhof non è stata la nostra. Ma non è questo il problema.
L’autopsia ufficiale, nel suo rapporto, indica che il corpo è stato trovato mentre il tallone sinistro toccava ancora la sedia sulla quale sarebbe salita per appendersi. In altre parole, una “caduta” del corpo da una certa altezza non c’è stata. Se c’era stato suicidio, la morte avrebbe dovuto subentrare, verosimilmente, per asfissia e non per rottura della colonna vertebrale a livello delle vertebre cervicali superiori, come è solito nelle esecuzioni legali. (Infatti non c’è stato spostamento violento delle vertebre cervicali).
Uno dei segni più importanti d’asfissia per strangolamento è l’impossibilità per il sangue della testa di ritornare in circolo. Il sintomo di una tale impossibilità è la presenza di emorragie interstiziali nelle congiuntive. Ambedue i rapporti d’autopsia non rilevano simili emorragie. Inoltre, i rapporti non citano nemmeno la protusione degli occhi e della lingua, o la cianosi del viso, segni abituali della morte per asfissia. Nonostante la frattura dell’osso ioide alla base della lingua, non c’era alcuna tumefazione al collo, nella zona interna al segno lasciato dalla “corda ricavata da un asciugamano”, con la quale la detenuta si sarebbe impiccata.
Questi risultati negativi sono insoliti per una morte per asfissia; è il meno che si possa dire. Si inseriscono invece, molto bene nel quadro di morte per compressione del nervo vago, ossia di morte per pressione sulla carotide che può provocare un arresto cardiaco riflesso.
Ci sono altri risultati inquietanti. I due rapporti d’autopsia menzionano un edema importante nelle parti genitali esterne e tumefazioni ai polpacci. Le due perizie parlano di una escoriazione, coperta di sangue coagulato alla natica sinistra. Il rapporto di Janssen menziona anche un’ecchimosi nella zona dell’anca destra. L’esame dello slip della detenuta rileva macchie sospetto. Le analisi chimiche per la ricerca dello sperma, secondo la dichiarazione ufficiale, hanno dato risultati positivi malgrado l’assenza di spermatozoi. (Atti della procura, Istituto tecnico di ricerche criminologiche, rapporto dell’11 maggio 1976)”. 
Negli atti del PM il prof. Mallach constata che, malgrado un test di sperma positivom non sono stati rilevati spermatozoi. Ciò non prova nulla; se nella biancheria esistono tracce di materia fecale o di urina, gli spermatozoi sono disgregati dall’azione dei batteri e spariscono entro qualche ora. E macchie di urina sono state trovate nello slip di Ulrike Meinhof. L’azione di questi batteri attenua anche la reazione positiva dello sperma.
STRALCI DEL RAPPORTO DEL DOTT. HANS JOACHIM MEYER , membro della Commissione internazionale d’inchiesta
[…] Il materiale a nostra disposizione consiste dei rapporti di autopsia dei prof. Mallach e Rauscke e della seconda autopsia eseguita dal prof. Janssen; ambedue i rapporti sono incompleti: mancano i risultati degli esami microscopici e istologici. Inoltre vi sono i risultati dell’esame del cadavere, condotto dal prof. Rauschke il 9 maggio ’76, gli esami dell’Ufficio regionale della polizia criminale del Land di Baden-Wuttemberg e i risultati delle analisi dell’Istituto di Medicina legale a Tubinga.
I tre rapporti arrivano alla conclusione che si tratti di suicidio per impiccagione. Nel rapporto Mallach-Rauschke è detto testualmente: “LA posizione del corpo appeso alla cella, la disposizione e la lunghezza del mezzo servito all’impiccagione, nonché l’analisi degli elementi rilevati sul luogo e dei risultati medici dell’autopsia, corrispondono inequivocabilmente ad una impiccagione che si è svolta nel seguente modo: la signora Meinhof è salita sulla sedia che
aveva disposto sotto la finestra su un materasso; ha fatto passare la striscia ritagliata dall’asciugamano attraverso le maglie del reticolato della finestra, poi, dopo essersi addossata al muro sotto la finestra, ha annodato due volte la striscia sotto al mento e ha lasciato la sedia, facendo un passo nel vuoto. Pendendo liberamente al reticolato della finestra, ha presto perso conoscenza ed è morta per asfissia.”
Ecco alcune osservazioni in merito a questo rapporto:
– la Meinhof non poteva fare questo passo nel vuoto, avendo davanti lo schienale della sedia che glielo impediva
– non pendeva liberamente dal reticolato della finestra perché il piede sinistro era poggiato sulla sedia
Problematica dell’impiccagione:
Abbiamo dall’inizio insistito sul fatto che le circostanze dell’impiccagione sono state falsificate accorciando, di 29 cm, il cappio nel quale era appesa. In realtà è stata messa in un cappio di 80-82 cm che aveva quindi un diametro di 26 cm. Chiunque è in grado di verificare che si può facilmente passare la testa attraverso un cappio di questo diametro e farla uscire senza difficoltà. Per appendersi con un cappio di questo tipo bisogna inclinare la testa leggermente in avanti, appoggiare il mento sul petto, altrimenti il cappio non può sostenere il peso del corpo.
Nei casi di incoscienza, i movimenti dipendenti dalla volontà non sono più possibili, il tono muscolare a poco a poco sparisce e la persona, appesa in questo m odo, cade dal cappio, poiché il peso del corpo tende verso la testa. La testa viene tirata indietro e allo stesso modo, il cappio solleva il mento e la testa. La stretta del cappio intorno al corpo non è più possibile. Il cappio, in queste condizioni, non lascia il segno di strangolamento che aveva la Meinhof, poiché comprime solo la parte anteriore del collo e non i lati, e passa dietro la testa. Questo cappio probabilmente non potrebbe nemmeno garantire la compressione dei vasi sanguigni. 
Del tutto diversa è la situazione con un cappio della circonferenza di 51 cm. La testa non può passarvi, né uscire cadendo. Il punto in cui la corda è annodata non è più allora dietro la testa, ma dietro al collo e, effettivamente, provoca un profondo segno di strangolamento. Ed è questa l’impressione che, accorciando la circonferenza del cappio, si è voluta dare agli esperti. Tutto questo non corrisponde ai fatti.
L’impiccagione, in un cappio così largo (80-82 cm) è un modo poco appropriato per impiccare una persona r improprio per appendere un corpo e mantenerlo per ore in questa posizione. In base alle stesse leggi fisiche, un cadavere cadrebbe fuori dal cappio, come l’uomo ancora in vita che ha perduto conoscenza. Si può appendere un cadavere in un cappio troppo largo, solo se si approfitta della rigidità cadaverica per mettere la testa in una posizione fissa, che non permetta più al cappio di scivolare.
Nel caso di Ulrike Meinhof, coloro che l’hanno appesa, hanno dovuto avere dubbi rispetto alla stabilità dell’impiccagione. Comunque hanno rafforzato questa stabilità, appoggiando il piede sinistro sulla sedia davanti a lei. Quando il corpo è rigido, la gamba tesa ha lo steso effetto di un bastone di legno sul quale si potrebbe appoggiare un peso. In questo modo la pesantezza del corpo è stata alleggerita sostenendolo in parte. Per maggiore sicurezza, le spalle sono state portate in avanti perché facessero da contrappeso. La gamba sinistra è stata appoggiata sulla sedia proprio al momento della rigidità cadaverica. E’ riconoscibile dal fatto che il piede è rimasto nella sua posizione normale. Se il piede, immediatamente dopo la morte, avesse avuto questa posizione, l’avrebbe perduta al momento del rilasciamento del tono muscolare e questa posizione rilasciata sarebbe stata fissata dalla rigidità cadaverica. Non è questo il nostro caso. […]
Per quanto riguarda lo stesso strumento di strangolamento, sembra evidente che una corda di tale lunghezza non poteva essere ricavata da una striscia tagliata da un asciugamano lungo 75 cm, senza ricorrere ad una cucitura.
9 Maggio, Ulrike Meinhof. 1° parte della commissione internazionale d’inchiesta sulla sua morte
Il 9 maggio ricorre (oltre all’anniversario dell’assassinio di Peppino Impastato) l’anniversario dell’assassinio di Ulrike Meinhof, nel carcere di Stammheim. Già in passato questo blog si è occupato di questa figura degli anni ’70 tedeschi, con alcuni stralci presi dalle sue lettere e dai suoi scritti.
E’ il caso, invece, da questo momento in poi (la “serie” sarà un po’ lunga) di mettere in rete un po’ di materiale che dimostra l’assassinio che c’è dietro la sua morte e quella successiva e simultanea di altri 3 prigionieri della stessa formazione , la R.A.F. anche conosciuta come Banda Baader-Meinhof. , a partire dal Rapporto della Commissione internazionale d’inchiesta sulla morte di Ulrike Meinhof. Fu ritrovata impiccata, con ancora un piede poggiato sulla sedia, morta da ore…ma come vedremo successivamente, l’autopsia dimostra più che chiaramente come non si sia trattato di suicidio…
, a partire dal Rapporto della Commissione internazionale d’inchiesta sulla morte di Ulrike Meinhof. Fu ritrovata impiccata, con ancora un piede poggiato sulla sedia, morta da ore…ma come vedremo successivamente, l’autopsia dimostra più che chiaramente come non si sia trattato di suicidio…
Prima di affrontare la parte tecnica dell’inchiesta mettiamo la sua dichiarazione d’intenti e una parte della prima inchiesta sulla tortura ‘pulita’ applicata costantemente su tutti i detenuti politici tedeschi, e non solo.
Di tortura non si può smettere di parlare, di indagare, di archiviare e diffondere…
« …anche i giudici che condannavano ai roghi le streghe e i maghi del secolo passato, credevano di purgare la terra di più fieri nemici… » (Pietro Verri –Osservazioni Sulla tortura- 1776)
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE D’INCHIESTA SULLA MORTE DI ULRIKE MEINHOF
A conclusione dei suoi lavori, la Commissione internazionale d’inchiesta Sulla morte di Ulrike Meinhof ha preso atto del rapporto formulato dalla segreteria.Senza far propria ogni singola formulazione, la Commissione sottolinea, tuttavia, che si tratta di un lavoro serio, realizzato grazie alla collaborazione di periti qualificati, che merita di essere preso in considerazione e ampiamente diffuso.
Per riassumere i pareri sui quali i suoi membri hanno trovato un accordo, la Commissione ha constatato :
– che Ulrike Meinhof è stata sottoposta, a più riprese e per lunghi periodi, a condizioni di detenzione che si è costretti a qualificare « tortura ». Si tratta di quel tipo di tortura chiamata isolamento sociale e privazione sensoriale, comunemente applicanto nella Repubblica Federale Tedesca a numerosi prigionieri politici e anche a detenuti comuni ;
– che la tesi delle autorità statali, secondo la quale Ulrike Meinhof si sarebbe suicidata per impiccagione non è provata e che i risultati della Commissione tendono a dimostrare che Ulrike Meinhof non potuto impiccarsi da sola ;
– che i risultati dell’inchiesta suggeriscono che Ulrike Meinhof era morta quando è stata appesa e che vi sono indizi inquietanti d’intervento di terzi in relazione a questa morte. eorge
La Commissione non può esprimersi con certezza sulle circostanze della morte di Ulrike Meinhof. Tuttavia, il fatto che al di fuori del personale della prigione i servizi segreti avessero accesso alle celle del 7° piano attraverso un passaggio distinto e segreto autorizza ogni sospetto. I risultati dell’inchiesta, qui presentati dalla Commissione, rendono più urgente la nécessita di costituire una commissione internazionale d’inchiesta sui morti di Stammheim e di Stadelheim.
 La Commissione ringrazia la sorella di Ulrike Meinhof che ha messo a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, nonché tutte le persone ed organizzazioni che hanno facilitato il lavoro intrapreso, appoggiandolo e contribuendo al suo finanziamento. Il lavoro è stato finanziato esclusivamente da questi contributi e senza di essi non sarebbe stato possibile realizzarlo. La Commissione ringrazia anche tutte le persone che si sono impegnate nella pubblicazione del presente rapporto.
La Commissione ringrazia la sorella di Ulrike Meinhof che ha messo a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, nonché tutte le persone ed organizzazioni che hanno facilitato il lavoro intrapreso, appoggiandolo e contribuendo al suo finanziamento. Il lavoro è stato finanziato esclusivamente da questi contributi e senza di essi non sarebbe stato possibile realizzarlo. La Commissione ringrazia anche tutte le persone che si sono impegnate nella pubblicazione del presente rapporto.
Parigi, 15 dicembre 1978
Michelle Beauvillard, avvocato, Parigi – Claude Bourdet, giornalista, Parigi – Robert Davezies, giornalista, Parigi – Georges Casalis, teologo, Parigi – Joachim Israel, sociologo, Copenhagen – Panayotis Kanelakis, avvocato, Atene – Henrik Kaufholz, giornalista, Aarhus (Danimarca) – John McGuffin, scrittore, Belfast – Hans Joachim Meyer, neuropsichiatra, R.F.T. – Jeane-Pierre Vigier, fisico, Parigi
[stralci del Rapporto della Commissione]
1. CONDIZIONI DI DETENZIONE
Dopo l’arresto di Ingrid Schbert e di Monika Berberich, nell’ottobre 1970, i prigionieri della R.A.F. sono sottoposti ad un regolamento di detenzione, calcolato fin nei minimi dettagli : il totale isolamento e l’isolamento in Piccoli gruppi.
Rapporto di Jorgen Pauli Jensen, psicologo, Danimarca :
All’indomani dell’arresto, Ulrike Meinhof fu tenuta prigioniera, in condizioni di assoluto isolamento, nel « braccio della morte » del carcere di Colonia-Ossendorf [era in un braccio vuoto, con 6 celle vuote e lei era al centro di queste]. Questo primo periodo di isolamento totale (poi ne seguiranno altri) è durato 237 giorni.
Metodo ed effetto della tortura dell’isolamento sono in diretta interdipendenza : il metodo consiste nell’isolamento assoluto da ogni contatto sociale e nella soppressione di impressioni sensoriali differenziate, che sono una condizione necessaria al funzionamento dell’organismo umano. Rinchiudendo i detenuti in una camera silens, una cella perfettamente isolata, dunque senza alcun rumore ( o una cella nella quale si ascolta un suono incessante), buia di giorno (o dipinta di bianco e illuminata al neon giorno e notte), con ridotte possibilità di movimento e aria viziata, si tenta, in qualche modo, di esasperarne il bisogno umano di contatti e impressioni sensoriali, vale a dire di comunicazione umana. Le ricerche di psicologia sperimentale e, disgraziatamente, anche l’esperienza diretta, ci hanno insegnato con certezza che tali condizioni possono corrodere e annientare, nel giro di breve tempo, gli esseri umani fisicamente e psichicamente
A livello fisico, la funzione vegetativa è distrutta poco a poco (modificazione patologica del bisogno di dirmire e urinare, della famé, della sete, nonchè mal di testa e perdita di peso). A livello psichico si sviluppa instabilità emotiva (angoscia improvisa o collera). Sul piano psichico e su quello della  conoscenza si sviluppa entro brève tempo, un disorientamento nel tempo e nello spazio ; difficoltà di concentrazione, difficoltà nel definire un pensiero , perdita della memoria, déficit del linguaggio e della comprensione, allucinazioni ecc.
conoscenza si sviluppa entro brève tempo, un disorientamento nel tempo e nello spazio ; difficoltà di concentrazione, difficoltà nel definire un pensiero , perdita della memoria, déficit del linguaggio e della comprensione, allucinazioni ecc.
Tuttavia, non sempre questo progetto raggiunge il suo scopo : esistono donne e uomini che, malgrado la tortura dell’isolamento, conservano la loro identità politica.
Dal 1972 vengono applicati metodi speciali contro i prigionieri politici nelle carceri della R.F.T.
– isolamento sistematico dei prigionieri in rapporto agli altri ; esclusione da tutte le attività comuni, dalla vita normale della prigione ; divieto di comunicare con altri prigionieri, ogni tentativo di ignorare tale divieto viene punito con la detenzione nelle celle di punizione ;
– l’applicazione di inferriate speciali dinanzi allé finestre delle celle allo scopo di rendere impossibile la vista sull’esterno [bocche di lupo]
– solo un’ora d’aria, soli, con manette ai polsi
– divieto di ricevere visite e lettere, tranne che da familiari
– tutte le visite sono sorvegliate dalla polizia politica, che registra tutta la conversazione e l’utilizza, all’occorrenza, nel processo
– censura totale di libri e giornali
« …Che fare ? E’ chiaro, sporgere denuncia per lesioni fisiche. Allora, dai ! L’ho già detto centinaia di volte : psichiatra e –ormai l’ho capito- otorinolaringoiatra che spieghino, finalmente, scientificamente, come il ‘silenzio’ abbia gli stessi effetti degli elettrochoc, provochi lo stesso tipo di lesioni, di devastazioni nell’organo dell’equilibrio e nel cervello… » Ulrike Meinhof ai suoi avvocati, dal braccio della morte, febbraio 1974
Suicidi in carcere ed etica della responsabilità
La metto così: il carcere è, e in sostanza è sempre stato, una questione totale: cioè, una questione in ogni suo aspetto, un continuum di criticità, che si tengono tutte fra loro. La questione dei suicidi in carcere, a mio avviso, va letta così. Nel contesto del carcere, per dire una cosa ovvia, tutto quello che dovrebbe rilevare sul nostro tema è la sua vivibilità o la sua invivibilità. Il discorso potrebbe allora svilupparsi nella ricostruzione di tutti i fattori e dinamiche di invivibilità, non pochi e non leggeri. Poi, bisognerebbe attuare una strategia dell’attenzione nei confronti di coloro che soffrono in modo speciale la invivibilità.
Ma c’è, indubbiamente, a monte di questi aspetti, un primo punto che non può essere ignorato: ed è quella che potrebbe essere chiamato la «vivibilità dell’arresto», che ha un proprio rilievo, provato dal dato statistico (ricavato dal libro di Baccaro e Morelli: «Il carcere: del suicidio e di altre fughe», letto in bozza) che il 28% dei suicidi in carcere si verificano entro i primi dieci giorni e il 34% entro il primo mese. Sotto questo profilo del «tintinnio delle manette», il carcere fa solo da cornice al precipitare di vicende individuali, rispetto alle quali un sistema di attenzione degli operatori non è facile, specie in presenza di certe strategie processuali. Naturalmente, c’è chi dirà: «Non vorrai mica che il carcere non faccia paura?».
Ma veniamo ai fattori di invivibilità del carcere, subìti e sofferti da tutti e da alcuni fino a rinunciare alla vita. Il primo è quello legato al sovraffollamento, che ha due aspetti a cominciare dal fatto di vivere a ridosso immediato di altre vite, il levarsi reciprocamente l’aria, il che non è affatto poco (gli esperimenti per le scimmie dicono che diventano nervose: e gli uomini?). Ma poi, in una struttura sovraffollata, inevitabilmente le disfunzioni sono infinite. Si lotta per sopravvivere a livelli minimi.
Il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio di Europa (Cpt), ha considerato la situazione di sovraffollamento in carcere, come «trattamento inumano e degradante». Tanto maggiore sarà la invivibilità quanto più si accompagnerà alle lunghe permanenze in cella, a fare della cella il luogo di una vita invivibile. E la normalità, in situazioni del genere, è che dalla cella si esce solo per brevi periodi «d’aria», ma non per lavorare o per altre attività né, per molti dei detenuti (stranieri, persone sbandate per le ragioni più varie, etc.), per avere colloqui con i familiari. E’ possibile costruire prospettive di uscita da queste situazioni? Lo impediscono: la povertà delle risorse organizzative del carcere su questo versante, le risposte sempre più difficili e spesso negative della magistratura, lo stesso ridursi delle possibilità o la mancanza di queste per la fascia sempre più numerosa degli stranieri, che attendono solo l’espulsione (nei grandi carceri metropolitani sono ormai ben oltre il 50%, ma anche la media nazionale si avvicina al 40%). C’era una volta un Ordinamento penitenziario che dava delle speranze di permessi di uscita, di misure alternative, ma anche questi spazi si sono sempre più ristretti – per leggi forcaiole e per magistrati condizionati dal clima sociale che le produce – e le speranze si sono trasformate in delusioni.
D’altronde, il suicidio non è l’unico prodotto della invivibilità delle carceri: lo sono anche i tentati suicidi, come pure, spesso difficili da distinguere dai primi, i gesti autolesionistici. Tutto insieme, si arriva vicini all’inferno. C’è, comunque, una campagna della amministrazione penitenziaria per individuare e agire a sostegno dei soggetti più a rischio. Ma non si può sperare che questo serva quando gli sforzi necessari sono limitati da poche risorse, destinati a durare per poco tempo, come accaduto in passato, affidati ad un sistema di sorveglianza psicologica e psichiatrica mai costruito adeguatamente: il tutto sempre dentro quelle condizioni di invivibilità che si mantengono e si concorre anzi ad aggravare, come dimostra l’accelerazione delle dinamiche di sovraffollamento. Tento una conclusione. Sentire, tutti, la responsabilità di questi morti e del carcere che li produce è una scelta etica desueta.
____Sandro Margara: Il Manifesto del 22 Aprile 2009____


















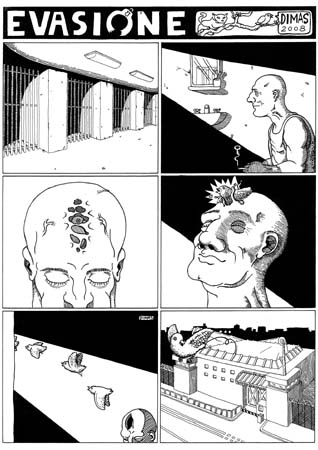






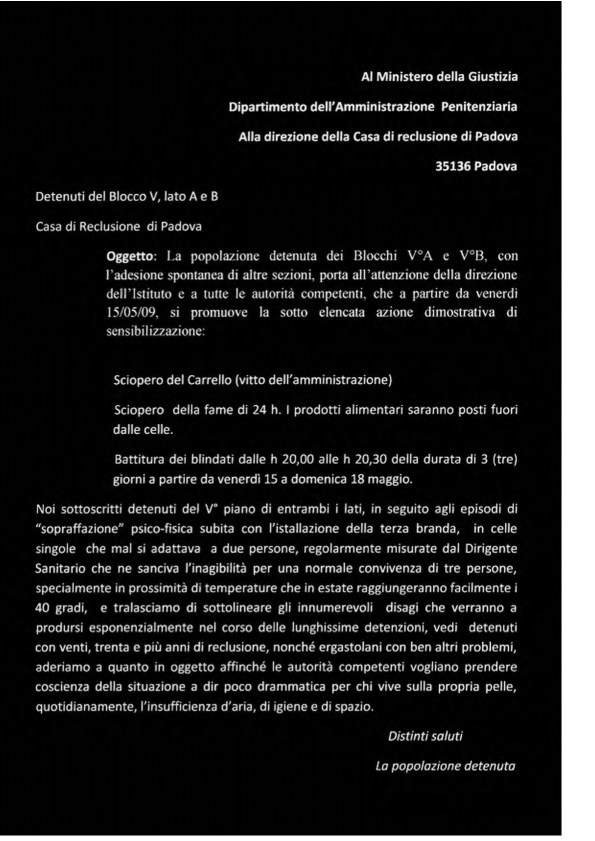




































Commenti recenti