Archivio
50 anni di magliette a striscie: GENOVA 30 GIUGNO 1960
30 giugno 1960
 Cavolo ma fa davvero 50 anni. Incredibile.
Cavolo ma fa davvero 50 anni. Incredibile.
Mi stupisco più di tanti altri anniversari perchè ricordare il 30 giugno 1960 a Genova, ricordare i Camalli, i portuali dalle magliette a strisce che a suon di bastonate e sassaiole hanno cacciato i fascisti e chi voleva proteggerli.
Una giornata che ha segnato un passaggio, una giornata dove si sfoglia la pagina del libro e qualcosa cambia per sempre.
Per quello mi emoziona e stupisce così tanto che siano passati 50 anni e che quindi la prossima settimana siano 50 anni da Lauro Farioli, Afro Tondelli, Ovidio Franchi, da Marino Serri e da tutti gli altri, “morti di Reggio Emilia” che sento nel sangue da quando so che mi scorre del sangue dentro.
Il giorno prima a Roma un corteo fu caricato pesantemente e rispose con coraggio alle cariche a cavallo.
50 anni di storia mia, di corde vocali che quasi si spezzano per la tanta rabbia in gola.
50 anni di gente mia, di compagni e sangue, di resistenza e sorrisi come di troppi lutti e sconfitte.
50 anni, e quelli dei camalli non invecchiano malgrado facciano parte di un rimosso totale.
OGGI COME IERI, con le magliette a strisce e in mano un sasso per le vostre camionette.
19/05/1991 19/05/10 AURO BRUNI VIVE
Il “padiglione delle madri”: prigioniere politiche in Argentina
Era molto tempo che volevo mettere queste righe.
Ma per mettermi qui a riscrivere queste due paginette ho dovuto trovare un po’ di coraggio.
 Da quando sono diventata mamma non sopporto, ancor meno di prima, certi soprusi, certi abusi su donne, mamme e bambini.
Da quando sono diventata mamma non sopporto, ancor meno di prima, certi soprusi, certi abusi su donne, mamme e bambini.
Si diventa più sensibili, forse è vero. O è solo un fatto di “appartenenza”… dopo che hai sentito dentro di te tutto ciò niente è più come prima.
Quando diventi mamma il modo di amare cambia profondamente: e con quello, parallelamente, anche gli altri sentimenti prendono forma in altro modo, esplodono in altro modo. La rabbia che m’ha fatto provare questa testimomianza è rara.
QUESTE RIGHE agghiaccianti sono tratte da un libro MEMORIA DEL BUIO estremamente interessante, di cui ho già pubblicato un piccolo brano . E’ un libro documento, un racconto corale di 112 donne argentine che hanno vissuto insieme l’esperienza della prigionia nelle carceri argentine durante la dittatura, fra il 1974 e il 1983.
Non mi è facile scrivere del “Padiglione delle madri”, dove entrai nel febbraio 1974. La memoria mi tradisce e, per quanto mi sforzi, molti frammenti restano sfocati.
Tentare di ricordare sarà allora una prova, una sfida con me stessa.
Mi colpì la sporcizia, lo squallore del luogo. Si chiusero le sbarre. Sarei rimasta lì dentro per anni. A poco a poco, la gabbia si animò delle nostre voci di ragazze, dei nostri ricordi, e più tradi dei nostri FIGLI. Per l’esattezza, mio figlio, Eduardo Adolfo, nacque il 14 luglio.
Quando mi arrestarono ero incinta di tre mesi. Sembravo un’ “oliva”, secondo mio fratello. Non c’erano specchi in carcere, perciò non sono in grado di smentirlo. Quando venne l’ora di partorire, mi ricoverarono nel reparto maternità del Sardà. Ero sotto la custodia di agenti del Servizio penitenziario federale che, oltre alla porta della mia stanza, sorvegliavano i corridoi e le scale dell’ospedale. Una pattuglia di pliziotti piantonava la strada sotto le mie finestre.
Quando iniziò il travaglio, i medici decisero di farmi il cesareo. Mi portarono in sala operatoria incatenata alla barella. Il dottore cercò di convincere gli agenti di custodia ad aspettare fuori. Per tutta risposta, uno di loro indossò camice e mascherina chirurgica e non si mosse più. Appena mi sfilarono le manette, sibilai: “Lavatemi di torno il piedipiati”. Ma capii che era inutile, e allora dissi a me stessa: Concentrati sulla cosa più importante, la nascita del tuo primogenito. In quella gelida sala operatoria, l’umanità del personale medico mi dette coraggio. Tutti i mieri pensieri si rivolsero alla mia PICCOLA GRANDE VITTORIA: STAVA PER  NASCERE MIO FIGLIO.
NASCERE MIO FIGLIO.
E venner al mondo, bello come il sole. Niente e nessuno poterono più cenusare i miei sentimenti, le mie emozioni, la mia tremenda allegria che provai nel sentirlo piangere.
Passavano i mesi, Guarito cresceva. Nel gennaio 1975 il padiglione si era andato ormai affollando di prigioniere politiche. La maggior parte erano state picchiate e torturate. Non avevano risparmiato nemmeno quelle incinte.
A fine anno la repressione si acuì, e le carceri, di conseguenza, si affollarono. Fu in quel periodo che il grosso delle compagne venne smistato nei padiglioni della Sezione 6. Nel 49 restarono solo madri e puerpere, e da allora fu chiamato “Padiglione delle madri”. Durante quel periodo nacquero almeno 17 bambini. Ci organizzammo in modo da seguire i piccoli, mandare avanti le faccende quotidiane e contemporaneamente dedicarci all’attività politica. Mentre un gruppo cucinava, un altro faceva le pulizie, e un terzo studiava e discuteva la situazione argentina e mondiale, nonostante le scarse informazioni che ci arrivavano dai parenti.
Dopo il golpe, il Potere Esecutivo Nazionale promulgò un decreto di base al quale i figli potevano restare con le madri solo fino al compimento del sesto mese d’età. Così la maggior parte dei bambini che viveva con noi fu consegnato ai parenti. Per molti anni non ebbi più nessun contatto fisico con mio figlio. Ecco come è andata col mio Guarito.
Quando venne il momento di separarmi da lui, avrei voluto gridare: “lasciatemi andare con mio figlio, il mio Guarito”, ma soffocai la disperazione. Per dignità, o forse per “intellettualizzazione”. Dentro però, ero a pezzi. Guardai una compagna che stava consegnando suo figlio ai nonni. Soffriva anche lei come me. Ci abbracciammo, piangemmo, li maledicemmo insieme. Ci avevano costrette a dare via i nostri figli. Ci avevano tolto il sacro diritto alla maternità.
I nostri due piccoli se ne andarono insieme, e il cancello del Padiglione delle madri si chiuse alle loro spalle. Non sapevano che non ci avrebbero più rivisto per anni. Quel pomeriggio, nell’ameno cortile del carcere, circondato da alti muri coronati da una triplice barriera di filo spinato, nacquero quei versi:
“Che ti succede figlio mio lontano
che ti succede figlio mio strappato
via da queste braccia che ti hanno cullato.
E’ una rabbia infondo al petto
che si gonfia nel silenzio…”
La memoria non mi assiste, non riesco a ricordare quei versi carichi d’amore e di dolore. Per questo ho provato a scrivere i frammenti della mia storia, perchè non voglio che “memoria” resti solo una bella parola.
Padiglione delle Madri
“LA PETY” GRISELDA VARELA VEIGA
“Costituzione” e “democrazia” non sono valori che m’appartengono
La Costituzione??
La Democrazia??
 Ma perchè? Perchè siamo diventati così?
Ma perchè? Perchè siamo diventati così?
Sarà dura per me stare in piazza questo 25 aprile: volevo portare il mio bambino al suo primo corteo di LIBERAZIONE ma non credo riuscirò a farlo.
Sono comunista, sono antifascista…ma quest’ antifascismo non mi piace, quest’antifascismo non m’appartiene.
Non riesco a vedere “compagni miei”, SANGUE MIO, invocare democrazia e Costituzione…
Non potete chiedermi di difendere la Costituzione…non la potete trattare come una cosa intoccabile, detentrice di valori eterni ed inviolabili.
Ma di cosa stiamo parlando?
Ma da quando amiamo la nostra Costituzione? La democrazia? Una costituzione che parla di “famiglia”, di “proprietà privata”?
La stessa democrazia che tiene i compagni in carcere da trent’anni, la stessa democrazia che ha regalato ergastoli e leggi speciali,
la stessa democrazia che sgombera le case, che carica i lavoratori e l’ha sempre fatto.
Quanti proletari sono stati ammazzati dalla nostra Costituzione???
Ieri ad Ostia c’è stata l’ennesima aggressione di Casa Pound: c’era un compagno solo ad attacchinare che s’è salvato per un pelo:
Volevo mettere il comunicato e non ne sono stata capace: si invocano le “forze sinceramente democratiche”… sul mio blog, scusate, non riesco a mettervi!
Non riesco a condividere strade e piazze nemmeno più con la retorica partigiana di personaggi come Bentivegna che poi hanno avallato ergastoli a go-go.
Basta, invece di capire questo, di superare quella retorica in modo antagonista e rivoluzionario facciamo addirittura passi indietro,
la peggioriamo, la rendiamo ancora più “democratica e populista”. Non ne posso più!
Vorrei contenuti di altro genere, vorrei parole nostre…non vorrei appellarmi solo al lessico borghese, alle Costituzioni borghesi e ai loro tribunali.
Questo 25 aprile mi sento molto sola, e non per i tanti fascisti in giro, ma per il modo in cui tentiamo di combatterli!
Intervista a Sonja Suder e Christian Gauger, a rischio estradizione!
Dal blog DamnatioMemoriae non posso non prendere (GRAZIE!!!) la traduzione di quest’intervista pubblicata sull’edizione domenicale della Tageszeitung (TAZ, quotidiano berlinese di sinistra) del 21.3.2010, agli esuli tedeschi in Francia Sonja e Christian, di cui ho già parlato in questo blog.[Archivio]
Revolutionäre Zellen
Sfuggiti per 22 anni ai cacciatori di terroristi. Sonja Suder e Christian Gauger sulla vita in clandestinità e su ciò che si prova quando si viene scoperti
“Guardi sempre se c’è qualcuno dietro di te”
di Andreas Fanizadeh
taz: Signora Suder, signor Gauger, quando vi siete accorti per la prima volta di essere osservati?
Sonja Suder: Era l’estate 1978. Eravamo appena tornati a Francoforte da una gita nel sud della Francia. Alle 6 di mattina ci siamo mossi per montare il nostro stand al mercato delle pulci all’Eisernen Steg sul Mainufer.
E li avete notato che qualcuno vi seguiva?
Suder: Alle sei di mattina è evidente se qualcuno ti sta dietro dalla porta di casa fino al mercato, dove poi non monta un suo stand. Al pomeriggio l’abbiamo comprovato ed era chiaro: eravamo osservati. Era un clado giorno d’estate a Francoforte, credo in agosto. E dovemmo prendere una decisione.
Perché?
Eh, erano tempi duri, era l’anno dopo il sequestro Schleyer e i morti di Stammheim. Decidemmo di andarcene via.
1978.
Chi si ricorda del 1978, l’anno in cui Sonja Suder e Christian Gauger scomparvero dalla scena, per restare introvabili nei successivi 22 anni? L’anno in cui l’Argentina visse i mondiali di calcio. O in cui nacque Katja Kipping, oggi vice capo del Partito Die Linke (La Sinistra). C’era ancora la RDT (Germania dell’Est) e l’Europa occidentale era nella fase finale del movimento del ’68. In Nicaragua i Sandinisti attaccarono il Palazzo Nazionale, in Italia le Brigate Rosse uccisero il democristiano Aldo Moro.
Quando l’esplosivo scoppiò all’improvviso E nella Repubblica Federale Tedesca, nel giugno del 1978, un conoscente -secondo la Procura penale- di Sonja Suder e Christian Gauger si preparò a piazzare una bomba al Consolato argentino di Monaco. Si chiamava Herrmann Feiling ed avrebbe agito, come Sonja Suder e Christian Gauger, nell’ambito delle cosiddette Cellule Rivoluzionarie (RZ). Le RZ erano per gli apparati di difesa dello Stato difficili da valutare, poiché dalla loro spaccatura del 1976/77 agivano senza una direzione riconoscibile. Il gruppo propagava attacchi con danni materiali e tentava, diversamente dalla RAF, di non fare vittime. Suder e Gauger avrebbero partecipato, dice oggi la Procura, a due attacchi contro imprese che lucravano sull’uranio con il Sudafrica, nel 1977, e ad un incendio al castello di Heidelberg, nel 1978. Perciò il 15 settembre 1978 un giudice istruttore federale emise un mandato d’arresto contro i due.Se Gauger, Suder e Feiling si conoscevano veramente, come ritiene la Procura, potevano senz’altro, nel 1978, considerare l’Argentina come uno Stato di non-diritto. Là i militari avevano fatto nel 1976 un colpo di stato con un seguito di 30’000 omicidi. In quel paese e in condizioni scandalose si giocarono i campionati mondiali di calcio. E la coalizione social-liberale di Bonn tollerava gli affari delle imprese tedesche con la dittatura argentina, mentre aiutava solo con molte esitazioni i cittadini germanici incarcerati e torturati in Argentina. V’erano insomma serie inconvenienti , anche se solo pochi come Herman Feiling tentarono di bucare con una bomba il muro del Consolato argentino. Ma l’attentato al Consolato non ebbe luogo. Per Hermann Feiling, il presunto conoscente di Suder e Gauger, la preparazione ebbe un esito fatale. L’esplosivo scoppiò il 23 giugno prima del previsto ad Heidelberg, e Feiling perse entrambe le gambe e gli occhi.
Il ferito grave venne palesemente interrogato dagli inquirenti già nella clinica universitaria di Heidelberg. Per settimane e mesi, dicono amici ed avvocati, gli inquirenti isolarono Feiling, per cercare di ottenere informazioni sulla struttura organizzative delle Cellule Rivoluzionarie. Gli inquirenti verbalizzarono ciò che Feiling avrebbe detto loro sotto l’effetto dei medicamenti e senza l’assistenza di un legale liberamente scelto, cose che poi egli ritrattò.
Poche settimane dopo l’incidente di Feiling, Suder e Gauger notarono la squadra di osservazione a Francoforte e si eclissarono. Da allora avrebbero vissuto da qualche parte all’estero senza più essere attivi -come lo erano in precedenza- in rapporto alle RZ.
Il sospetto contro Suder e Gauger “si appoggia in sostanza sulle dichiarazioni del testimone Feling nel 1978” conferma oggi, su richiesta, la Procura di Francoforte. Solo nel 1999 si aggiunse secondo le autorità un ulteriore sospetto contro Sonja Suder. Accusa: partecipazione all’attacco contro l’OPEP a Vienna nel 1975 e complicità in omicidio. I termini di prescrizione per gli attentati originariamente imputati a Suder e Gauger è di 20 anni. Sarebbero quindi prescritti dal 1998. Ma, sostiene la Procura pubblica, la prescrizione è stata “interrotta più volte” e può andare “al massimo fino al doppio del tempo previsto, dunque a 40 anni”. Un attacco incendiario del 1978 (prescrizione: 10 anni) può essere trasformato in un attacco incendiario con messa in pericolo della vita altrui (prescrizione: 20 anni) e così allungare la prescrizione a 40 anni.
È del 2000 la spettacolare scoperta con immediato arresto dei due “pensionati delle RZ”, come vennero definiti, a Parigi. Da allora le autorità francesi e tedesche si affannano su Suder e Gauger. Nel 2001 la Francia respinse una domanda di estradizione della Germania. Ora la pagina potrebbe voltarsi, grazie al nuovo mandato di cattura europeo, contro i due militanti della sinistra degli anni settanta. Il caso pende al momento presso la Corte costituzionale francese. Si ignora se la Francia estraderà.
2010.
Parigi, Saint Denis, vicino all’Università 8. Su piccolissimi appezzamenti di terreno sorgono piccole case, in lontananza si scorgono i profili di alcuni grattacieli. Non c’è nessuno per strada, è una giornata fredda e umida. In una delle casine, o meglio in una parte minuscola di una di quelle casine, vivono da quando vennero scoperti ed arrestati Sonja Suder e Christian Gauger. Sonja Suder ha compiuto nel frattempo 77 anni, Christian Gauger ne ha 68. Erano una coppia già prima della fuga nel 1978. È la prima volta che parlano con la stampa tedesca. Il colloquio è accompagnato da thé e torte. La loro cucina non arriva a 16 metri quadrati.
In clandestinità poco prima della laurea
Com’è, essere trovati e presi decine di anni dopo aver attaccato delle imprese tedesche per i loro affari con il Sudafrica dell’apartheid, dopo essere scomparsi ed aver vissuto una vita clandestina in Francia? Suder e Gauger sorridono. Su quei temi non parlano. Entrambi vogliono parlare con la TAZ a condizione di non dover rispondere a domande che possano avere un rilievo giuridico nel loro processo. Non dicono se, e se sì, per cosa, portano responsabilità.
 taz: Da quando vive in esilio?
taz: Da quando vive in esilio?
Sonja Suder: Dal 1978.
Prima viveva a Francoforte?
Suder: Si, studiavo medicina. Quando siamo partiti, avevo quasi finito.
Quanti anni aveva, allora?
Suder: Dovevo averne 45.
E lei, signor Gauger?
Christian Gauger: Anch’io vivevo a Francoforte. Avevo un diploma in psicologia e lavoravo con la pedagogia speciale all’Università.
Come collaboratore scientifico?
Gauger: No, come ‘servitore’ scientifico. Così si chiamava allora.
Gauger squadra il giornalista. Beve un po’ dalla sua tazza -thé d’erbe come quello di Suder- ed è calmo e concentrato. I suoi capelli bianchi li ha raccolti in una treccia, il viso è incorniciato da una barba sale e pepe tagliata corta. Con la sua camicia a fiori ed il leggero dialetto della regione dell’Hess potrebbe essere uscito direttamente da un negozio di antiquariato del quartiere Bockenheim a Francoforte. Sonja Suder dirige il dialogo. I suoi 77 anni non si notano. Una personalità agile, vivace e spontanea, con una voce decisa, è vestita sportivamente in nero, con capelli corti e scuri.
La camera a Saint Denis è arredata con mobili usati, comoda e pratica, come se ne vedono nelle comuni della scena alternativa. L’anticonsumismo sembra un’ideologia pratica per la vita spartana della clandestinità, senza pensione né entrate stabili. Tra i libri sugli scaffali si notano molti reggiposate. I reggiposate vengono volentieri usati in Francia per appoggiarvi le posate tra una portata e l’altra, per non sporcare il tavolo. Sono di porcellana, di diversi metalli nobili, rifiniti in modo semplice o artistico. Ogni uomo ha un hobby, e collezionare reggiposate è quello di Christian Gauger. Lui racconta lentamente, è quasi floscio. Nel 1997 ha subito un infarto ed ha dovuto essere riportato in vita.
Taz: Com’era la situazione, quando veniste arrestati nel 2000?
Suder: Eravamo arrivati da poco a Parigi e siamo usciti dall’albergo. Andò tutto molto in fretta: mani in alto! Poi volto e braccia contro il muro.
Polizia francese?
Suder: Sì, polizia francese.
Nessun tedesco assieme a loro?
Suder: No, solo più tardi, al distretto degli sbirri, lì c’erano anche dei tedeschi. Non si sono lasciati vedere, ma potevi sentire come parlavano tra di loro.
È importante per voi che si parli di ‘sbirri’?
Suder [ride]: No, possiamo anche dire polizia.
Ve l’aspettavate, di essere presi nel 2000?
Suder: No. Non in quel particolare momento, anche se rispetto alla tua vita sai che potrebbe accadere in qualsiasi momento. Non si sa mai cosa stia effettivamente succedendo. In questo senso essenzialmente te lo aspetti.
Insomma non avevate nessun concreto indizio?
Suder: No. E questo benché ci stessero sicuramente già addosso da un pezzo.
Sapete come vi hanno ritrovati dopo 22 anni?
Suder: Non è chiaro. Avevamo avuto in incontro con un parente. Forse gli si sono appiccicati.
Intende dire che per tutto l’anno un commando di catturatori vi è stato addosso?
Suder: Non credo. Fino alle dichiarazioni di Hans-Joachim Klein nel 1998/99 non eravamo neppure sempre indicati nelle ricerche per la cattura in Europa. La cosa deve essere cambiata dopo.
Hans-Joachim Klein partecipò nel 1975 all’attacco contro l’OPEP a Vienna. Si allontanò in seguito dal terrorismo ma venne preso solo nel 1998 in Francia. Dopo il suo arresto sostenne per la prima volta nel 1999 che Sonja Suder aveva potuto partecipare alla logistica dell’attacco all’OPEP. Fino al 1999 non c’era un ordine di arresto internazionale?
Suder: No, secondo i nostri avvocati. È probabilmente per questo che prima abbiamo avuto abbastanza tranquillità.
Signor Gauger, si trattiene? Non vorrebbe partecipare alla nostra conversazione?
Gauger: Di molte cose non ho più ricordi. Ho avuto un infarto e sono entrato in coma.
Quando è successo?
Suder: 1997.
Gauger: Il cuore mi si fermò. Ero praticamente morto. Sonja mi ha riportato in vita. [Arresto cardiaco e infarto, con i conseguenti pregiudizi sul cervello e sulla capacità di memoria sono attestati da perizie mediche francesi].
Le vostre false identità erano così ben fatte che potevate chiedere delle cure mediche?
Suder: Dovevamo! Già solo per il controllo e le medicine. La riabilitazione l’ho poi fatta io con lui. Era davvero una situazione assurda.
E non vi hanno scoperti?
Suder: No. A volte abbiamo dovuto trattenere il respiro, ma la nostra età fa sì che la gente non sia tanto malfidata.
Gauger: Io avevo integralmente perduto la memoria.
Ma Sonja Suder l’ha riconosciuta?
Suder: Fatto che mi stupì, devo dire.
Gauger: Ma prima non sapevo neppure che esistesse, l’ho conosciuta solo quando è ritornata nella camera.
Che sentimento si prova, quando ci si è dimenticati tutto, si vive in clandestinità e ci si deve fidare di una persona che ci insegna chi si è?
Gauger: Prima o poi viene la paura: cazzo, che succede se rimango stupido? Quando mi è venuto questo timore era però anche il momento in cui ho notato che potevo pensare da solo. La cosa è durata per un po’.
Sonja Suder le ha anche dovuto raccontare perché viveva in clandestinità?
Gauger: Sì. Ma naturalmente non so se mi ha raccontato tutto. Semplicemente non lo so.
Suder: Questo neppure si può. Non puoi raccontare un’intera vita. Se qualcuno lo chiede e se si lavora con certi testi di riabilitazione, si può ri-raccontare qualcosa, ma non si può sovraccaricare una cervello. La cosa funziona pezzetto per pezzetto.
1997 e 2000 – tra arresto cardiaco e incarcerazione non passò molto tempo.
Suder: Sì, ma si era già stabilizzato. Il punto di cui prima parlava fu dopo un mezzo anno di riabilitazione. Ma ancora oggi Christian mi chiede cose sul suo passato, ed in pratica continuiamo ancora la riabilitazione.
Dopo l’incarcerazione siete stati immediatamente separati?
Suder: Sì, subito.
Avete ancora famiglia in Germania?
Suder: Sì, abbiamo contatto con le nostre rispettive sorelle.
Signor Gauger, allora adesso può verificare autonomamente se ciò che le ha raccontato la signora Suder è vero?
Gauger: Sì, questo è almeno divenuto più facile.
Che atteggiamento avete avuto nei confronti dell’interrogatorio dopo l’arresto?
Suder: Se prima hai concordato “se succede qualcosa, nessuna parola, niente dichiarazioni”, hai allora un buon sentimento di sicurezza.
 Quanto siete rimasti in carcere preventivo nella prima procedura del 2000/2001?
Quanto siete rimasti in carcere preventivo nella prima procedura del 2000/2001?
Suder: Meno di tre mesi. Christian era detenuto a Parigi, il carcere femminile era fuori.
È stata la vostra prima volta in carcere?
Suder: Sì, io ero alla fine dei miei 60 anni, Christian all’inizio dei suoi.
Com’era in carcere?
Suder: Si dice che le prigioni francesi siano le peggiori del mondo. Io però non posso affermarlo. Sono stata messa in cella e avevo la normale ora d’aria nel cortile. Ho incontrato subito due donne basche. Da quel momento mi è stato organizzato tutto ciò di cui avevo bisogno, in modo naturale e ovviamente sottobanco. Insomma ero quasi un po’ privilegiata. Quella solidarietà era affascinante.
Qual’era la cosa più noiosa in carcere?
Suder: Di fatto, il baccano. Ad ogni passaggio ci sono porte d’acciaio, che vengono in permanenza aperte e sbattute rumorosamente. Sono dei botti continui. Un baccano incredibile. L’essere rinchiusa non era per me così brutto, per quello ti prepari un po’ prima. Devi subito vedere di fare qualcosa, come esercizi sportivi e letture.
Signor Gauger, come fu per lei?
Gauger: Al passeggio, è venuto subito uno da me. Sapeva già. Così poi sono stato sempre con lui e con un altro al passeggio. In cella eravamo in tre. I letti a castello erano scomodi; sul terzo, sopra, si è ben in alto, ti possono venire le vertigini. Altrimenti: topi e scarafaggi, che sono però animali domestici. Meglio che una cella singola tutta bianca, dove non vedi né senti nessuno.
Che si pensa, quando si è arrestati dopo 20 anni di esilio?
Suder: Adesso ci hanno proprio beccati.
Gauger: E io ho pensato: questo non è necessario.
Sapete ciò che concretamente vi viene rimproverato?
Suder: Tre attentati, due contro il programma atomico dell’allora regime dell’apartheid sudafricano, ed un attacco contro la ristrutturazione della città di Heidelberg. A me, inoltre, Vienna. Questa storia dell’OPEP. E con essa l’accusa: complicità in omicidio. In Francia questo sarebbe già prescritto. Le sole cose che qui non vanno in prescrizione sono i crimini contro l’Umanità.
L’accusa di partecipazione all’attacco contro l’OPEP l’ha sorpresa?
Suder: Sì.
1975. L’arresto di Klein nel 1998 fu un fulmine a ciel sereno, proprio come la sua affermazione della partecipazione di Suder. Klein aveva fatto parte nel 1975 di un commando diretto da Ilich Ramirez Sanchez, detto ‘Carlos’, e che si rese responsabile della morte di tre persone. A Klein, ferito durante l’azione, riuscì di partire con gli altri membri del commando e con i ministri dell’OPEP in ostaggio. Poi nel 1976 un commando tedesco-palestinese dirottò un aereo dell’Air France su Entebbe; in quell’occasione morirono Wilfried Böse e Brigitte Kühlmann, considerati dirigenti delle prime RZ. In seguito le RZ si rifondarono, distanziandosi da gruppi e formazioni del vicino oriente come quella di Carlos. Criticarono l’antiamericanismo e l’antisionismo della ‘sinistra antiimperialista’ e propagarono forme di attacco che non producessero morti.
Su richiesta, la Procura pubblica di Francoforte conferma oggi che, fino al 1999 ed a parte le affermazioni di Klein, non v’è mai stato il minimo indizio che Suder sia stata coinvolta nella prima fase delle RZ fino al 1976. Klein, la cui credibilità viene spesso paragonata con l’ex-membro della RAF e raccontatore di storie Peter-Jürgen Boock, accusò dei militanti delle RZ ed altre persone di aver partecipato all’attacco contro l’OPEP. Rudolf Schindler venne per questo processato dal tribunale di Francoforte. E venne assolto dall’accusa di complicità nell’attaco all’OPEP, smentendo l’accusa di Klein. La corte dubitò della sua “certezza di identificazione nel riconoscimento fotografico del 2.9.1999”. In quell’occasione accusò assieme a Schindler anche Suder, “benché in precedenza non avesse mai accennato ad un’altra donna”, affermò il tribunale già 2001. A parte la dichiarazione di Klein, ancora oggi la procura penale non ha null’altro in mano contro Suder per l’attacco all’OPEP.
TAZ: Quanto presenti sono state per voi in questi anni le accuse dei ’70, di una fase sempre più lontana delle vostre vite? Avete potuto avere una vita normale?
Suder: All’inizio no. Ti guardi sempre dietro per vedere se c’è qualcuno. Se parla tedesco.
Gauger: Il meno possibile contatti con dei tedeschi, questo è molto importante.
Signora Suder, signor Gauger, non vi è mai venuto in mente in tutti quegli anni: la storia è così vecchia, che senso ha, vogliamo ritornare e affrontiamo il passato?
Suder: Insomma, a me no. E a te, Christian?
Gauger: Certo, se avessero revocato i mandati di cattura.
Suder: Molto divertente. Ora è però chiaro: se la Francia ci estrada, saremo processati in Germania.
Il gruppo al quale avreste appartenuto si è sciolto definitivamente all’inizio degli anni novanta. Questo ha qualche influenza sul processo?
Suder: Giuridicamente nessuna. Dopo l’entrata in vigore degli accordi penali europei, siamo stati arrestati una seconda volta nel 2007. Christian per quattordici giorni ed io per un mese. E dal 2009 dobbiamo contare ogni giorno sull’eventualità di un’estradizione, benché il tribunale francese avesse già negato l’estradizione nel 2001
Dopo la vostra scoperta nell’anno 2000 e il rifiuto della domanda di estradizione avete vissuto a Parigi per la prima volta di nuovo legalmente. Com’è stato per voi?
Suder: Quando vivi sempre con una leggenda, non ti puoi costruire delle vere amicizie. Abbiamo vissuto tutti quegli anni molto ritirati. A Parigi in un primo tempo non avevamo nessun contatto. La nostra avvocatessa ci ha trovato dei compagni italiani, così da avere almeno un indirizzo da indicare per poter essere scarcerati. Poi una bravissima donna ci ha ospitati. Credo che in Germania sarebbe stato più difficile. Ma la cultura repubblicana ha in Francia una ricca e secolare tradizione di offrire rifugio agli esuli. Persone che non conoscevamo ci hanno lasciato la loro casa per mezzo anno, sono andati ad abitare nel sud della Francia permettendoci così di cercarci una nostra abitazione a Parigi. Praticamente non conoscevano né noi né la nostra storia, e ci hanno semplicemente aiutati. Ci siamo poi integrati in fretta nell’ambiente, abbastanza grande, degli esuli italiani, i militanti degli anni ’70 qui rifugiati, con le loro discussioni e le loro feste. Sono molto solidali. Abbiamo avuto fortuna.
Da Francoforte a Parigi
1. Clandestini: Nell’estate 1978 a Francoforte Sonja Suder e Christian Gauger si accorsero di essere spiati. Partirono all’estero ed assunsero false identità. Probabilmente vissero in Francia, a Lille. Nel 1997 Gauger subì un colpo apoplettico e perse la sua memoria -della falsa come della vera identità.
2. Scoperti: Nel 2000 vennero scoperti ed arrestati davanti ad un albergo a Parigi. Separati, passarono alcuni mesi in carcere preventivo. Da allora Suder, 77 anni, e Gauger, 68, vivono a Parigi. La Germania ne chiede alla Francia l’estradizione -fin’ora invano.
3. Incolpati: La Procura di Francoforte sul Meno accusa oggi la coppia di aver partecipato ad attentati contro imprese nel 1977 e contro il castello di Heidelberg nel 1978. Suder è inoltre accusata di complicità in omicidio: per l’attacco alla conferenza dei ministri dell’OPEP a Vienna nel 1975, dove tre persone persero la vita. Questa accusa è basata soltanto sulle dichiarazioni dell’ex-terrorista Hans-Joachim Klein.
Un fiore rosso per Valerio

Maggio 1977 _Valerio in piazza, che guarda dall'alto la manifestazione_ Questa splendida foto è sul blog di Carla http://www.valerioverbano.it
LUNEDI 22 FEBBRAIO.
TRENT’ANNI DALL’ASSASSINIO DI VALERIO VERBANO
L’APPUNTAMENTO E’ ALLE 16, IN VIA MONTE BIANCO, SOTTO CASA SUA.
PER PORTARE UN FIORE A VALERIO, PER ABBRACCIARE CARLA.
A Nando Biccheri, compagno nostro!
CIAO PRESIDENTE,CIAO NANDO
Vogliamo ricordare un compagno ,un compagno che molti hanno conosciuto e che con molti ha percorso le strade per la giustizia sociale e la trasformazione del mondo in un luogo di uguaglianza.
Un compagno che difficilmente interveniva nelle assemblee pubbliche ma che non si risparmiava di dirti quello che pensava ,faccia a faccia anche in modo duro e perentorio. Un compagno semplice che noi giovani abbiamo imparato a chiamare Presidente. Era un compagno autorevole,che faceva pesare quello che diceva e pensava, un compagno grande,un 68ttino,un 77ino,un autonomo, un antinuclearista, un ocupante dei centri sociali,uno dei 500.000 di Genova 2001,un compagno che al momento giusto sapeva stare con i giovani,indirizzarli ,spronarli e calmarli ”calma e gesso”,formarli ma mai sovradeterminarli.
NANDO BICCHERI era il Presidente ,il compagno di cui gli aspetti politici non si disgiungono mai da quelli personali,è difficile ricordare gli uni senza mischiarli agli altri.
Un compagno sempre attento agli altri,era il primo a parlare con i nuovi arrivati, a confrontarsi con i proletari nelle piazze. Nando Biccheri ci ha insegnato tante cose negli anni in cui ci siamo frequentati. Ci ha insegnato ad usare il cervello in modo autonomo,forse troppo,”ognuno deve essere un partito comunista nella propria testa”. Ci ha insegnato la responsabilità verso le lotte che si affrontano, l’abbiamo conosciuto quando nel 1984 con il COMITATO PROLETARIO TRULLO manteneva l’ultimo comitato di AUTORIDUZIONE delle bollette ENEL contro il nucleare, con decine di famiglie proletarie che NANDO insieme ai pochi compagni e compagne del comitato non ha lasciato con gli staccatori dietro la porta ma ha chiuso l’intervento dopo aver conquistato un accordo vantaggioso con i proletari. Anche questo suo buon senso travestito da caparbietà ha permesso ai compagni futuri di poter girare a testa alta nel quartiere proletario dove NANDO aveva lavorato politicamente e umanamente.
NANDO BICCHERI in quel comitato ha saputo aspettare con pazienza che una nuova generazione,dopo la grande repressione del movimento, si riaffacciasse con l’esigenza del cambiamento,ed insieme a loro si è impegnato per ricostruire un nuovo protagonismo,con l’attenzione di non farci ripetere gli errori del passato ma con la fiducia incondizionata nella vitalità dei giovani,nell’ incessante necessità del cambiamento e nell’ineluttabilità della trasformazione del presente manifestata e costruita dai movimenti sociali.
Ci ha insegnato a “contare sulle nostre forze” perché dopo il corteo cittadino nel territorio ci sono solo i compagni del territorio, e insieme a lui una nuova generazione di compagni del Trullo ha occupato un Centro Sociale . Nei giorni dell’occupazione di Ricomincio dal Faro ci ha insegnato la forza dell’autorganizzazione, cosa vuol dire fare intervento in un “quartiere proletario”, come bisogna stare in mezzo alla gente e privilegiare la socialità per far stare i compagni insieme alla gente,come il duro lavoro territoriale sia più prezioso della vetrina cittadina.
Non abbiamo mai potuto distinguere l’aspetto personale,perché il suo amore per la vita lo ha sempre espresso allo stesso modo,nella lotta come nell’attenzione alla vita dei compagni,sia nei momenti difficili come nel la felicità per una notizia lieta. Insieme a lui abbiamo visto tanti posti di questo paese,conosciuto tanti compagni e tanta gente. Gli interventi che oggi i compagni con difficoltà portano avanti,sono frutto delle sue intuizioni,la lotta contro l’elettrosmog,il contatto con il mondo contadino e la formazione del gruppo d’acquisto sono percorsi che abbiamo iniziato con lui.
Ci mancheranno anche gli aspetti più spigolosi del suo carattere solare, ci mancheranno le tue uscite marchiggiane,i tuoi borbottii vivaci quando le cose non andavano,le tue bestemmie un po’ imprecazione un pòincoraggiamento, i tuoi silenzi di quando non eri d’accordo.
Abbiamo avuto la fortuna di aver conosciuto un grande uomo e un grande comunista.
Che la terrà ti sia leggera,resterai per sempre il nostro PRESIDENTE.
Un abbraccio forte a MARILU’ sua compagna di lotta e di vita ,a MARINA e MICHELE.
CENTRO SOCIALE OCCUPATO RICOMINCIO dal FARO
Martino Zicchitella
Prosegue la sezione di questo sito dedicata ai compagni uccisi durante azioni armate, tutti quelli che normalmente vengono rimossi dalla memoria collettiva, tutti gli “scomodi”.
Molti in questo ultimo periodo li ho saltati. Per problemi di tempo, ma non per dimenticanza, quindi il danno verrà riparato al più presto e tutti coloro che sembravano essere stati dimenticati dalle pagine di questo blog verranno ricordati.
Non ci si dimentica del proprio sangue.
Il tutto è tratto dal Progetto Memoria, Edizioni Sensibili alle Foglie
MARTINO ZICCHITELLA
– Nasce a Marsala il 26 aprile 1936
– pochi anni dopo si trasferisce a Torino
– svolge attività extra-legali e viene arrestato per rapina del ‘66
– evade dal carcere di Firenze
– riarrestato milita nel movimento di rivolta dentro alle carceri
– milita nei Nuclei Armati Proletari
– resta ucciso a Roma, durante un’azione armata dei N.A.P. il 14 dicembre 1976
Scritture di Martino Zicchitella
– “Memoriale redatto da Zicchitella; Anarchismo n.10 – 11, Catania 1976
 “Prima del mio arrivo nella Casa di reclusione di Lecce, mi era stato accennato come fosse usuale in questo luogo, conosciuto come il “lager del Salento”, percuotere i nuovi arrivati. Già il compagno S. N. in un memoriale presentato alla magistratura alcuni mesi fa, descriveva fatti avvenuti e metodi usati di violenza da restare sgomenti; egli si riferiva al caso di un detenuto che dopo essersi aperto il ventre dalla disperazione con un’arma da taglio, fu oggetto di un pestaggio da parte degli agenti di custodia, che lo ridussero in fin di vita a colpi di manganello e calci. Lo stesso poi (il suo nome era Caradonna), fu abbandonato in una cella sotterranea senza che gli fossero state apprestate le cure necessarie.
“Prima del mio arrivo nella Casa di reclusione di Lecce, mi era stato accennato come fosse usuale in questo luogo, conosciuto come il “lager del Salento”, percuotere i nuovi arrivati. Già il compagno S. N. in un memoriale presentato alla magistratura alcuni mesi fa, descriveva fatti avvenuti e metodi usati di violenza da restare sgomenti; egli si riferiva al caso di un detenuto che dopo essersi aperto il ventre dalla disperazione con un’arma da taglio, fu oggetto di un pestaggio da parte degli agenti di custodia, che lo ridussero in fin di vita a colpi di manganello e calci. Lo stesso poi (il suo nome era Caradonna), fu abbandonato in una cella sotterranea senza che gli fossero state apprestate le cure necessarie.
Trasferito in questo stabilimento, ebbi modi di constatare, e subire, i metodi che venivano messi in atto: un trattamento riservato quasi sempre ai compagni o simpatizzanti di sinistra.
Il 30 giugno 1975 faceva il mio ingresso nella menzionata casa penale proveniente da Rebibbia, dove fui trattato secondo il regolamento. Alla villa Bobò di Lecce invece, appena preso in consegna dal corpo di guardia del carcere, mi venne rivolta da un brigadiere degli agenti di custodia, questa frase: “E adesso che cosa avanzi?”
Certo non potevo immaginare cosa mi sarebbe accaduto nei seguenti 80 giorni. Dopo essere stato portato in un ufficio adiacente a quello del maresciallo comandante, fui perquisito da cima a fondo, senza rispetto alcuno della personalità umana, con accurate esplorazioni anali, poi introdotto in una sezioncina detta “Reparto isolamento”: qui fui rinchiuso in una cella che non aveva alcun arredo, solo mura, porte e inferriate di ferro. Qui ci rimasi circa mezzora, dopo di che fui invitato ad uscire in un corridoio dove c’erano ad attendermi un numero considerevole di guardie (una quindicina ).
Mi fecero percorrere il corridoio della sezione e a spintoni mi condussero in un passaggio che immetteva in un sotterraneo dello “la campana”. Si trattava di tre anguste celle lunghe due metri e trenta per uno e cinquanta. Appena scesi gli scalini e spinto in una delle tre cellette (la seconda), venni aggredito da alcune guardie che erano nel corridoio precedentemente, agli ordini di un appuntato.
Queste mi furono addosso in un baleno e mi percossero selvaggiamente per mezzora con calci e pugni, tanto da farmi svenire e procurarmi lesioni e dolori che accusai per oltre un mese. Dopo il primo pestaggio, chiusero la porta della cella e quella della sezione andandosene. Il locale maleodorante e sudicio era umidissimo, l’unica suppellettile era un bugliolo senza coperchio nel quale c’erano ancora escrementi umani.
Di lì a poco tempo con un rumore assordante di chiavi e ferri sbattuti, arrivarono altre guardie, era una seconda squadretta per il secondo pestaggio, l’appuntato era sempre lo stesso, aprirono la mia cella e mi si avventarono nuovamente addosso, dicendomene di tutti i colori, frasi come bastardo, fottuto, delinquente.
Mi strapparono da dosso la camicia e i pantaloni e questa volta ricevetti anche dei colpi con un bastone. Insomma avevo le ossa e il corpo in stato pietoso, era blu per le ecchimosi, il sangue mi fuoriusciva dal naso, dalla bocca, dalle abrasioni alle braccia e al corpo. Prima che se ne andassero gettarono nella cella due secchi d’acqua allagando l’angusto locale; in queste condizioni rimasi ben 24 giorni, cioè nudo con acqua sul pavimento e con scarso cibo, per i primi tre giorni non mi dettero nulla e per un mese non vidi un raggio di luce, e non presi una boccata d’aria all’esterno.
Nello stesso periodo ebbi modo di conoscere altri compagni che avevano subito o subirono vessazioni e pestaggi. 
Il trattamento fu pressappoco analogo per tutti: il B.D.S. fu addirittura messo in un reparto denominato “il forno”, locale strettissimo e privo di finestre, nel buio più totale, per diversi giorni. Altri due mesi, poi me li fecero trascorrere in una cella di un piano superiore, dove c’era un pancaccio e un gabinetto alla turca. Alla “campana” per tutta la durata dei 24 giorni non mi fu data né una branda né un materasso. Dormivo a terra con una coperta sudicia che subito si inzuppava d’acqua, che mi veniva consegnata la sera alle 21 e ritirata la mattina alle 8.
Continue furono le istigazioni al suicidio e durante la notte mi costringevano ad alzarmi per il controllo della ronda, la luce era accesa giorno e notte, naturalmente per tutto il tempo che rimasi in quel buco, non potei acquistare cibo, né scrivere a mia madre, la quale dopo il mio trasferimento da Roma non sapeva dove fossi stato mandato. […]
– Martino Zicchitella, “Assassinio di un uomo”, Porto Azzurro, in: Autori Vari, Liberare tutti i dannati della terra, Roma 1972, Edizioni Lotta Continua–
“Questa è la giustizia del nostro paese, condanne assurde, senza troppo andare per il sottile, labili indizi per ciò che concerne la colpevolezza, prove ed alibi di innocenza non tenuti in considerazione. Perché? Si tratta di un pregiudicato, pregiudicato divenuto per protesta di una società che fa schifo, democrazia di capitalisti, uomini che sfruttano milioni di altri uomini, salariandoli con molliche di pane, briciole lasciate cascare dalla loro sontuosa mensa, briciole che non sfamano, gocce che tengono in vita un moribondo.
Pregiudicato è colui che, stanco dei soprusi, stanco di essere sfruttato, stanco del massacrante turno di lavoro, dice al padrone: basta, ladro, restituiscimi ciò che mi hai rubato prima.
Stenti e fame alle dipendenze del padrone.
Stenti e fame durante l’espiazione della pena.
Stenti e fame dopo l’espiazione, scacciato e insultato.
Pregiudicato e operaio da noi, negro in America non sono che forme di preconcetti razziali del capitalismo, dei padroni che ci trattano come servi della gleba, quei padroni che vivono senza sapere che vuol dire un’esistenza squallida, nella miseria, senza sapere cosa significa desiderare pane e mortadella, di non aver avuto da bambino il piacere di possedere un giocattolo costoso, a volte il calore e l’affetto di una famiglia, del focolare.
L’orfanotrofio, il correzionale, il carcere, ecco sfornato il pregiudicato. Ed ora? … marcisca in una patria galera … rieducarlo ora? macché, carne da macello, taluni gridano pena di morte, altri no! Fatelo vivere, fatelo vegetare, l’organizzata industria della giustizia deve avere la sua materia prima.
Polizia, carabinieri, parte di una florida industria che produce … pregiudicati, e criminali, il carcere è l’università ove si laurea, la scuola per delinquere, il giovane che vi è rinchiuso oggi per un furtarello, sarà il rapinatore o l’assassino di domani, non importa, l’industria non deve fallire.
 Le carceri magazzini di carne umana sono zeppe, si raggiunge ormai, in ogni stabilimento penale o giudiziario, la saturazione, uno sull’altro come animali, l’esempio più classico dei tre compagni arsi vivi a San Vittore in un’angusta cella, dico tre persone … tre giovani vite stroncate nel fiore dell’età per una assurda condizione carceraria, per il sadismo edilizio che costringe tre giovani a stare rinchiusi in due metri quadrati di spazio.
Le carceri magazzini di carne umana sono zeppe, si raggiunge ormai, in ogni stabilimento penale o giudiziario, la saturazione, uno sull’altro come animali, l’esempio più classico dei tre compagni arsi vivi a San Vittore in un’angusta cella, dico tre persone … tre giovani vite stroncate nel fiore dell’età per una assurda condizione carceraria, per il sadismo edilizio che costringe tre giovani a stare rinchiusi in due metri quadrati di spazio.
Nel carcere di Torino sono stato compagno di cella con Bobbio, Viale, Bosio, Mochi Sismondi, compagni e seguaci di Lotta Continua, al loro fianco ho compreso veramente il valore di ciò che significhi lotta per la libertà, lotta al capitalismo: ed a tutte le sue strutture borghesi, con profonde radici fasciste.
Con loro ho vissuto momenti di vera fratellanza, fummo commensali, discutemmo sulle occupazioni delle fabbriche, delle università, la Fiat, Palazzo Campana. Su queste basi capeggiai nell’estate ’68 una rivolta passiva. Un sit-in alla Bertrand Russel a protesta e a richiesta che si facesse di più per i detenuti, che si riformassero i codici, che si varasse l’ordinamento carcerario, fui prelevato di peso, attaccato dalla Stampa per il mio gesto e trasferito in casa di rigore. Ancora una volta dovetti subire la repressione da parte della polizia e voluta dai capitalisti.
Dovrò ancora scontare oltre 15 anni di carcere per dei reati che non ho commesso, con ingiustizie e provocazioni: uscirò … debbo uscire per scendere ancora in piazza e alzare la destra, serrare il pugno, dovrò contestare, dovrò combattere la polizia mia acerrima nemica, il capitalismo dovrà essere sconfitto, e con loro i servi e i fascisti, dovrò uscire per raggiungere i miei compagni e marciare al loro fianco verso un nuovo orizzonte.”
Documenti prodotti da organizzazioni armate per la persone o per l’evento in cui ha incontrato la morte
– Nuclei Armati Proletari, “Onore al compagno Zicchitella”, Roma 1976
“Il compagno Martino Zicchitella nacque a Marsala il 26-4-1936 ma fin da piccolo ha vissuto a Torino, la città della borghesia savoiarda, degli ex-repubblichini, la citta dei Valletta, la città in cui la sperequazione capitalistica è più evidente e più umiliante. La città metropoli in cui, già negli anni del boom, la vita sociale è pianificata, controllata e manipolata; dove ogni attività è finalizzata alla produzione di plusvalore e consenso, attraverso l’utilizzazione dei più rudimentali mass-media del tardo capitalismo.
Dai casermoni di Via Verdi ai portici di Via Roma lastricati di marmo, alla Barriera di Milano, alla Crocetta, i salariati di Torino si battono tra centinaia di contraddizioni giornaliere, simili a quelle di qualsiasi altro paese capitalista, ma tutte riconducibili a una sola: quella della propria appartenenza di classe, del proprio potere di acquisto dal quale dipende la gradazione della propria identità umana e sociale. Qui l’acquisizione e l’interiorizzazione dei valori legati all’ideologia borghese non sono scelta, sono induzione violenta, costante, asfissiante.
Martino sceglie la strada dell’appropriazione violenta ed individuale del benessere padronale: quella della rapina, per cui viene arrestato nel ’66.
Durante l’alluvione di Firenze, Martino evade, vive ancora contraddittoriamente la sua realtà di proletario detenuto; salverà invece alcuni giovani dalla melma dell’Arno.
Il carcere e lo scontro che in esso si vive collettivamente gli fanno acquisire i primi elementi di coscienza rivoluzionaria e lo portano nel ’68 alla testa, come direzione ed avanguardia riconosciuta, delle prime dimostrazioni pacifiche nelle carceri “Nuove” di Torino, alle quali il potere risponde brutalmente, come sempre.
Nel ’70 Martino ha pienamente chiarificato la sua identità, ha identificato lo Stato anche nelle sue appendici carcerarie e riesce ad evadere da Alessandria.
Rimane fuori poche ore con le gambe spezzate per il salto dal muro di cinta. Ripreso viene massacrato dalle guardie e rimarrà claudicante.
Nel ’71 è alla testa della rivolta delle “Nuove”. Con lui altri compagni che in quelle lotte e da quelle lotte hanno con sequenzialmente maturato la scelta della lotta armata; all’interno della quale rappresentano le avanguardie più alte e più coscienti del proletariato detenuto, al quale la loro prassi fornisce le più chiare indicazioni: l’evasione e l’organizzazione combattente.
Il ’71 è l’anno di Attica per i proletari che si ribellano in USA; quello di Porto Azzurro per i compagni come Martino. Le successive rivolte ad Alghero, Noto, Enna, lo vedono farsi carico, nella gestione delle lotte, degli interessi di sopravvivenza dei proletari prigionieri, della loro necessità di organizzarsi e combattere.
Nel ’74 a Viterbo inizia un confronto con altre avanguardie espresse dalle lotte dei detenuti sulla costituzione in organizzazione politico-militare all’esterno di alcune avanguardie rivoluzionarie.
Con la presenza a Viterbo di un militante dei NAP, il confronto prosegue e si sviluppa interno-esterno, sul piano politico quanto su quello organizzativo-militare.
Partecipa così alla costruzione e alla realizzazione della operazione coordinata con l’attacco armato interno-esterno del maggio ’75 che vede al primo posto la parola d’ordine della liberazione dei combattenti comunisti prigionieri.
L’attacco interno non coglie l’obiettivo della liberazione ma, per effetto dell’attacco esterno che vede imprigionato il boia Di Gennaro, è comunque un momento di enorme crescita politico-militare che Martino fa suo patrimonio all’interno dell’organizzazione dei NAP.
Trasferito a Lecce per rappresaglia subisce per mesi torture fisiche e psicologiche ma non cessa di porsi come direzione dello scontro organizzando e realizzando con un altro militante dei NAP l’azione armata dell’agosto ’76 che porta alla liberazione di 11 prigionieri.
La sua morte nello scontro di Roma caratterizza e definisce la sua vita e la sua coerenza di combattente comunista.”
Piazza Fontana, 40 anni dopo
 Uno pensa a certe cose e riflette sul “da quando sono nata che…”
Uno pensa a certe cose e riflette sul “da quando sono nata che…”
e invece no, era molto prima. Molto prima, non tantissimo, scoppiavano le bombe nelle piazze, scoppiavano le bombe sui treni, scoppiavano le bombe nelle banche, pochi giorni prima di Natale.
La prima fu proprio lei, dentro la Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, precisamente 40 anni fa, tra qualche ora.
E allora penso al processo mentale di bambina, di giovane adolescente e di giovane donna poi che ho fatto per arrivare a capire quelle parole che mia madre mi ripeteva come fossero intoccabili: QUELLA ERA UNA BOMBA DI STATO, L’HANNO MESSA I FASCISTI, L’HANNO PAGATA I PADRONI.
?
Erano realmente intoccabili.
Cavolo: il percorso di comprensione della cosa è stato rapido. Dentro la mia testa rapidissimo, nella mia coscienza di comunista, di rivoluzionaria, di libertaria è entrato riga dopo riga, parola dopo parola, in un viaggio di conoscenza che m’ha portato a capire dove sono nata, dove stavo crescendo!
Il paese nato dalla Resistenza e dalla retorica incessante su di essa, che poi ha creato le leggi speciali, le carceri speciali, le strategie per eliminare qualunque diritto o rivendicazione proveniente dalla classe operaia, dal proletariato, dal meridione, dalle donne, dagli studenti. Quel paese faceva morire per strada, per lo scoppio di una bomba, e poi invocava carcere a vita per chi lottava, pochi anni dopo.
Crescevo in un paese che non ha mai voluto dire una verità che noi compagni abbiamo sempre saputo: la contro-inchiesta partita immediatamente dopo ha portato alla luce molto, già a caldo, sul libro “La Strage di Stato”..
ma la verità s’è vista cadere dalla finestra della questura di Milano appena tre giorni dopo.
La verità è stata chiara: s’è sfracellata come corpo morto al suolo.
Non mi va, in quest’anniversario di pubblicare materiali, di ribattere e scannerizzare testi o volantini, manifesti o tazebao.
Brucia ancora, come quel giorno, dentro di me: la rabbia e la consapevolezza di chi sono i colpevoli, di chi sono i mandanti e di chi siamo noi.
A Tarzan Sulic, ucciso dentro una caserma ad 11 anni.
Sarà quel pacco bomba, per strada regalato,
Lo schifo di ricordo, che schifo di ricordo, d’un braccio amputato
Per rifilare un taglio non solo alle tue mani
Ma a quelle degli zingari, di quei fottuti zingari più sporchi dei cani
Le fiabe hanno l’odore di polvere da sparo
Lo disse anche Matteo, si torturava Mira quel libro costò caro
E se Sengul da bambola sembravi troppo a Barbie
Coi chiodi e con le biglie, coi fiori e con le bolle sul viso è troppo tardi
In quell’incrocio Emran guardava da innocente
I soldi di una carità elargita ad un pezzente
Adesso solo un occhio salvato dalle schegge
Vedrà soltanto odio in un mondo senza legge
E come Tarzan Sulic volava tra le sbarre
Un angelo ribelle non può cadere a terra
Caramba sparò in testa, non vide più una stella,
Tarzan d’undicianni assassinato in cella
Assassinato in cella assassinato in cella
Assassinato in cella assassinato in cella
E Mira torturata con mala meraviglia,
Il tuono di quel colpo, il colpo di quel tuono
Di notte ora ti sveglia
La fretta di un processo e pena senza pesa
Dimenticare presto, dimenticare tutto, giustizia non è resa.
 Non si trova molto in rete sulla storia di Tarzan Sulic e Mira Djuric, due bimbi rom. Una storia del settembre 1993, quindici anni fa.
Non si trova molto in rete sulla storia di Tarzan Sulic e Mira Djuric, due bimbi rom. Una storia del settembre 1993, quindici anni fa.
Lui è morto ucciso da un proiettile sparato da un carabiniere, dentro una camera di sicurezza della caserma di Ponte di Brenta.
Dicono, rendetevi conto, che il colpo è partito per sbaglio, che l’undicenne freddato con un colpo alla testa stava provando a scappare e nella colluttazione sarebbe partito un colpo.
Colpo che ha passato la testa del giovane Tarzan e poi ha ferito sotto il seno sinistro la sua cuginetta, fermata con lui e con lui rinchiusa in quella cella.SI è salvata dopo un lungo intervento, visto che la pallottola si era fermata vicino al cuore.
Lui è morto sul colpo.
A 11 anni, dentro una caserma dei Carabinieri.
CHI SE LO RICORDA?
In questo momento dai microfoni di Radio Onda Rossa, una bella trasmissione in loro ricordo!
Per amore della storia…
Sono passati diversi giorni dall’editoriale di Magris sul Corriere della Sera e da alcune risposte comparse su altre testate. Volevo riportare questa di Marco Clementi, comparsa qualche giorno dopo sulle pagine de L’Altro. La libertà di parola, la libertà di fare storia va difesa a denti stretti!
La storia è plurale. La memoria vittimaria rientra nella sfera privata e sembra più vicina alla vendetta che alla giustizia, se usata come rivendicazione
Marco Clementi L’Altro 4 agosto 2009
Un’intera generazione italiana, quella che ha fatto la lotta armata negli anni ‘70 e ‘80, scontate quasi tutte le pene dopo i secoli di carcere con i quali lo Stato l’ha punita, deve tacere. Questo, se non ho capito male, è il centro del discorso che sviluppa Claudio Magris sulle pagine del Corriere della Sera del 31 luglio. Lo studioso ammette che il brigatista può recuperare i pieni diritti civili e politici (anche se ciò, una volta scontata la pena, non avviene automaticamente ma bisogna attivare la procedura di “riabilitazione”), può esprimere la sua sulle piattole, se nel frattempo il carcere gli avesse fornito l’istruzione adeguata per farlo, ma non può dire una parola sul suo passato di combattente.  Certo, di fronte ad espressioni come quelle riportate nell’articolo e attribuite al militante di Prima Linea Sergio Segio – giustamente definite «pappa del cuore, vecchio vizio retorico italiano, posta sentimentale rosa vicina al rosso sangue versato» -, consiglierei al suo autore di tacere, ma non si vede perché tale raccomandazione debba essere estesa a tutti gli altri. In letteratura, come nel processo penale, la responsabilità è personale.
Certo, di fronte ad espressioni come quelle riportate nell’articolo e attribuite al militante di Prima Linea Sergio Segio – giustamente definite «pappa del cuore, vecchio vizio retorico italiano, posta sentimentale rosa vicina al rosso sangue versato» -, consiglierei al suo autore di tacere, ma non si vede perché tale raccomandazione debba essere estesa a tutti gli altri. In letteratura, come nel processo penale, la responsabilità è personale.
E così, il brigatista è un brigatista, e non un SS, un mafioso, uno stragista impunito. A ognuno il suo, per cominciare. E di brigatisti e brigatismo si deve allora parlare visto l’elenco di alcune delle vittime che fa Magris (non tutte peraltro colpite dalle Brigare rosse) considerate «le figure dell’Italia migliore, quella più libera e aperta e democratica, che avrebbe potuto e dovuto essere diversa da quella di oggi». Come se il motivo per cui oggi siamo qui è perché in Italia c’è stata la lotta armata. Intanto mi sembra uno strano recupero dei diritti quello di chi, riabilitato, può andare a votare per il Parlamento italiano ma non deve dire una parola sugli anni in cui fu protagonista. Da sempre i reduci hanno raccontato della propria guerra. Ma c’è dell’altro.
I brigatisti, primi e unici nella storia di questo paese, scelsero di rivendicare i propri delitti e di assumersene la responsabilità di fronte alla legge, indipendentemente dal loro coinvolgimento concreto. Al punto che molti sono stati condannati all’ergastolo per il sequestro Moro senza essere stati in via Fani, né in via Montalcini, né in via Caetani. Se avessero deciso di difendersi singolarmente, senza dichiararsi rei, la storia giudiziaria delle Br sarebbe andata molto diversamente e le condanne si sarebbero contate con numeri più piccoli. Che dire, poi, delle continue riforme del codice penale per adeguare la legge alla nuova situazione creata in Italia dalla presenza di questo gruppo armato? Tutto ciò induce a pensare che si trattò di una storia politica. Nessuno degli uccisori di allora lo fece per questioni personali; nessuno aveva un “conto aperto” da chiudere. Come ipotizza Magris, «pensava di costruire un’Italia migliore».
E le vittime, mi si dirà? E i parenti delle vittime? Perché è questo, in fondo, il contesto all’interno del quale si chiede, ovvero si impone ai brigatisti di tacere. Ma a quali brigatisti ci si riferisce? Ai pentiti, ai dissociati o ai cosiddetti “irriducibili”?
Le confessioni dei pentiti e quelle dei dissociati sono state qualitativamente differenti: i pentiti hanno offerto parole utili alle tesi dell’accusa in sede processuale (oltre che permesso in casi clamorosi l’arresto di decine di militanti), I dissociati hanno fornito ricostruzioni politiche della propria esperienza militante in linea con quella desiderata dello Stato. Lo hanno fatto molti anni dopo il loro arresto, contribuendo alla sconfitta politica della lotta armata, non a quella militare. A quanto risulta a chi scrive, i pochi ex-militanti della lotta armata che hanno partecipato in modo attivo alla memorialistica appartengono in maggioranza alla  schiera dei cosiddetti pentiti o dissociati. Per quanto concerne, invece, gli irriducibili, essi per lo più tacciono (e spesso i commentatori li accusano proprio per questo!) e anche quando parlano, come nel caso di Mario Moretti con un libro sulle Br per nulla apologetico, si sottolinea quello che non sarebbe stato ancora detto, perché è una verità predeterminata, quella che si vorrebbe ascoltare, non il pensiero di Moretti. Veniamo alla questione delle vittime e dei loro parenti. Il 9 maggio è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo in Italia. Di tutte le vittime, senza distinzione di matrice, tipologia di attentato, obiettivo. Quest’anno, per l’occasione, la vedova Pinelli è stata invitata al Quirinale, dove ha incontrato la vedova Calabresi. L’iperbole è complessa, e va analizzata e spiegata. Da tempo ormai il calendario italiano si è riempito di giorni della memoria e del ricordo e si cerca di far passare l’idea che la memoria abbia una sorta di dignità parallela a quella della storia. Forse perché la memoria appartiene alle vittime, mentre la storia ai vincitori? In realtà non è così. La differenza è un’altra e ben più sostanziale. La memoria appartiene alla sfera privata, mentre la storia è pubblica. La memoria non si può verificare, laddove la storia attende un riscontro da parte della comunità scientifica. La memoria non sostituisce la storia, né si affianca ad essa; offre delle fonti, tutte da vagliare. Per questo, un incontro tra la vedova Pinelli e la vedova Calabresi può avere luogo solo nel giorno della memoria. Perché nella memoria si perdono i ruoli e Pinelli e Calabresi sono visti semplicemente come vittime. Nella storia, però, i ruoli sono attribuiti in un altro modo. L’assassinio di Pinelli è stato perpetrato all’interno di una struttura dello Stato nel corso di un’indagine sulla strage di piazza Fontana. Quello di Calabresi, in un contesto diverso e qualcuno che potrebbe spiegarcelo non vuole farlo. E, stranamente, a questi non si chiede di tacere. Ora, nel diritto moderno è lo Stato che regola il rapporto tra il reo e la giustizia, tanto che il pubblico ministero non difende i parenti delle vittime, ma sostiene l’accusa in nome del popolo italiano. La vittima, o i suoi parenti, si possono costituire parte civile, con un avvocato a rappresentarli. Il giudice, quindi, è terzo rispetto alle parti e non potrebbe essere altrimenti, da quando la dottrina giuridica e le costituzioni moderne hanno tolto alla famiglia il diritto di vendetta, sostituendolo con quello della giustizia. La memoria rientra nella sfera privata e sembra più vicina alla vendetta che alla giustizia, se usata come rivendicazione. Ovviamente i parenti di una vittima hanno tutto il diritto di scrivere, appellarsi e indignarsi. Non lo ha però lo Stato, che ha compiuto il proprio dovere arrestando i brigatisti e riuscendo a farli condannare, debellando il fenomeno. Dato però che lo Stato non dovrebbe vendicarsi, non può condannare nessuno né al silenzio, né all’oblio. Anzi, ne guadagnerebbe se, ora che la guerra è finita da tempo, si impegnasse per capire il motivo che ha indotto una generazione e una classe sociale a dire «mai più senza fucile», agendo di conseguenza. Gli ex lo possono spiegare, ed è interesse di tutta la comunità che lo facciano.
schiera dei cosiddetti pentiti o dissociati. Per quanto concerne, invece, gli irriducibili, essi per lo più tacciono (e spesso i commentatori li accusano proprio per questo!) e anche quando parlano, come nel caso di Mario Moretti con un libro sulle Br per nulla apologetico, si sottolinea quello che non sarebbe stato ancora detto, perché è una verità predeterminata, quella che si vorrebbe ascoltare, non il pensiero di Moretti. Veniamo alla questione delle vittime e dei loro parenti. Il 9 maggio è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo in Italia. Di tutte le vittime, senza distinzione di matrice, tipologia di attentato, obiettivo. Quest’anno, per l’occasione, la vedova Pinelli è stata invitata al Quirinale, dove ha incontrato la vedova Calabresi. L’iperbole è complessa, e va analizzata e spiegata. Da tempo ormai il calendario italiano si è riempito di giorni della memoria e del ricordo e si cerca di far passare l’idea che la memoria abbia una sorta di dignità parallela a quella della storia. Forse perché la memoria appartiene alle vittime, mentre la storia ai vincitori? In realtà non è così. La differenza è un’altra e ben più sostanziale. La memoria appartiene alla sfera privata, mentre la storia è pubblica. La memoria non si può verificare, laddove la storia attende un riscontro da parte della comunità scientifica. La memoria non sostituisce la storia, né si affianca ad essa; offre delle fonti, tutte da vagliare. Per questo, un incontro tra la vedova Pinelli e la vedova Calabresi può avere luogo solo nel giorno della memoria. Perché nella memoria si perdono i ruoli e Pinelli e Calabresi sono visti semplicemente come vittime. Nella storia, però, i ruoli sono attribuiti in un altro modo. L’assassinio di Pinelli è stato perpetrato all’interno di una struttura dello Stato nel corso di un’indagine sulla strage di piazza Fontana. Quello di Calabresi, in un contesto diverso e qualcuno che potrebbe spiegarcelo non vuole farlo. E, stranamente, a questi non si chiede di tacere. Ora, nel diritto moderno è lo Stato che regola il rapporto tra il reo e la giustizia, tanto che il pubblico ministero non difende i parenti delle vittime, ma sostiene l’accusa in nome del popolo italiano. La vittima, o i suoi parenti, si possono costituire parte civile, con un avvocato a rappresentarli. Il giudice, quindi, è terzo rispetto alle parti e non potrebbe essere altrimenti, da quando la dottrina giuridica e le costituzioni moderne hanno tolto alla famiglia il diritto di vendetta, sostituendolo con quello della giustizia. La memoria rientra nella sfera privata e sembra più vicina alla vendetta che alla giustizia, se usata come rivendicazione. Ovviamente i parenti di una vittima hanno tutto il diritto di scrivere, appellarsi e indignarsi. Non lo ha però lo Stato, che ha compiuto il proprio dovere arrestando i brigatisti e riuscendo a farli condannare, debellando il fenomeno. Dato però che lo Stato non dovrebbe vendicarsi, non può condannare nessuno né al silenzio, né all’oblio. Anzi, ne guadagnerebbe se, ora che la guerra è finita da tempo, si impegnasse per capire il motivo che ha indotto una generazione e una classe sociale a dire «mai più senza fucile», agendo di conseguenza. Gli ex lo possono spiegare, ed è interesse di tutta la comunità che lo facciano.
Link
Magris – Anni di piombo quei terroristi pentiti con la pappa nel cuore
Miccia corta e cervello pure
A Fabrizio Pelli, lasciato morire in carcere…30 anni fa
FABRIZIO PELLI
– Nasce a Reggio Emilia, l’11 luglio 1952
– Lavora come cameriere
– Milita nelle Brigate Rosse
– Viene arrestato a Pavia nel dicembre 1975
– Muore di leucemia nel carcere di San Vittore, Milano, l’8 agosto 1979
Documenti prodotti da organizzazioni armate
– Non ne sono stati prodotti, ma a Fabrizio Pelli vengono intitolate una Brigata e un’organizzazione armata a Salerno
Documenti prodotti da gruppi sociali
– Comitato di lotta del Campo dell’Asinara, “Onore al compagno Fabrizio Pelli” in: Controinformazione 16, Milano 1979
“Per ogni comunista la morte è un evento naturale e Fabrizio Pelli era comunista combattente.
Anche il mare più incurabile per un rivoluzionario è occasione di lotta e Fabrizio, con il suo comportamento, lo ha dimostrato a tutta la sua classe e ai suoi nemici, in quest’ultima, solitaria battaglia.

Fabrizio Pelli _Questa foto aveva le sbarre, quelle che lo hanno tenuto costretto fino alla sua morte: sono state tolto, almeno così è LIBERO_
Invano i corvi borghesi hanno atteso un suo cenno di debolezza per piegarlo, per ricondurlo al compromesso dentro l’ordine dell’oppressione. A nulla è servito tenerlo isolato fino all’ultimo istante, privato della posta e della vicinanza dei suoi compagni, negargli – come neppure il fascismo osava fare – di trascorrere le ultime ore di visita in compagnia dei suoi familiari, a casa sua.
La speranza delle iene è andata delusa di fronte ad un comunista che aveva maturato a fondo un principio essenziale: uomini che si rifiutano di interrompere la loro lotta, o vincono o muoiono, invece di perdere o morire!
Il Tribunale di Milano, così sollecito a concedere la libertà provvisoria per motivi di salute ai fascisti assassini di proletari come Braggion, non è che l’ultimo anello di una catena di infamie, cominciata proprio qui, all’Asinara, dove il medico Silvetti si guardò bene dal rilevare il reale stato di salute del compagno Fabrizio, quando nell’estate dello scorso anno cominciò ad accusare i sintomi della malattia.
I Campi di Trani, Fossombrone e Milano sono altrettanti anelli del suo progressivo annientamento che medici e direttori hanno perseguito con lucida e spietata determinazione in occulta armonia con i funzionari del ministero di Grazia e Giustizia. E non vogliamo dimenticare, in questo elenco di canaglie ancora viventi, carabinieri e poliziotti che hanno sottoposto i familiari di Fabrizio alle perquisizioni più vili e che in ogni modo hanno tramato per interrompere il proseguimento delle cure.
Noi proletari prigionieri del Campo dell’Asinara, che con Fabrizio abbiamo lottato e che, anche per il suo contributo, abbiamo rafforzato la nostra identità e la nostra organizzazione, oggi diciamo, senza alcuna retorica, che i suoi nemici sono anche i nostri, che i suoi assassini non resteranno impuniti!
Onore al compagno Fabrizio Pelli!
Onore a tutti i compagni caduti combattendo per il comunismo!”
Testimonianza al Progetto Memoria
– Renato Curcio, Roma 1994
“Ho conosciuto Fabrizio, Bicio per gli amici, nel 1969.
Aveva 17 anni ma, a Reggio Emilia, già da tempo aveva fatto parlare di sé. “Per un colpo di flobert indirizzato ai glutei di un politico del partito liberale”, mi dissero, tra l’ammirato e l’ironico i suoi compagni di allora.
Non aveva ancora 18 anni quando venne a Milano con tutte le sue curiosità per la metropoli. Ma ciò che veramente lo spingeva, in verità era una cosa sola: l’impegno militante a fianco di studenti e operai, di chiunque in qualsiasi modo lottasse, per cambiare le cose.
Si sentiva un po’ anarchico ma il fascino della rivoluzione bolscevica era su di lui così potente che trascorreva infinite notti a leggere, oltre ai testi canonici, qualsiasi saggio, opuscolo, libello che in qualche modo potesse arricchire le sue conoscenze. E se qualcuno per caso citava un’opera che gli era sfuggita, s’infuriava, non sembrandogli lì per lì possibile che quell’opera esistesse veramente. Se non era a volantinare, in qualche manifestazione o a organizzare qualche azione di lotta potevi star sicure che il suo tempo era speso in letture.
Politiche, s’intende. Una dedizione totale, senza mezze misure. Senza concedere a se stesso nemmeno gli spazi dell’esplorazione della vita.
Quando entrò nella lotta armata, nel 1971, se non era il più giovane certo si contendeva il primato. Proprio in relazione alla sua giovanissima età, con altri due compagni ci chiedemmo se fosse il caso di accoglierlo nella vita clandestina che, per ovvie ragioni, non è tra le più permissive. Ma a Bicio il carattere non faceva difetto e non ne volle sapere di tutti gli argomenti che gli mettevamo davanti per dissuaderlo.
Era molto orgoglioso e un po’ testardo. Capitava così che non accettasse di buon grado che altri gli insegnassero qualcosa. Ricordo che una volta si infuriò con un militante: non ritenendolo adeguatamente colto in dottrina marxista, gli negava il diritto di insegnarli a guidare l’automobile. L’altro, naturalmente, lo mollò giù dalla macchina, in piena campagna, dicendogli “Beh, ora vado a studiare, tu raggiungimi a piedi!”
Quando, nel 1975, dopo l’evasione da Casale, lo incontrai di nuovo, a Milano, Fabrizio si era innamorato. Nella sua vita era la prima volta. E il calore di questa nuova e magnifica esperienza scioglieva tumultuosamente tutte le sue rigidezze. Della sua proverbiale rigorosità, in quei giorni non rimase traccia. A metà della riunione più delicata, lui si alzava e borbottava “Scusate…”, in pieno candore se ne andava a telefonare. Alla vita clandestina il suo stato di grazia causò qualche problema, ma alla sua vita personale certo fece un gran bene.
Ho appreso la notizia del suo arresto alla radio, pochi giorni prima di essere a mia volta arrestato. L’ultimo nostro incontro, dunque, avvenne in carcere, all’Asinara. Alcune divergenze politiche che poco prima del suo arresto lo avevano portato a distaccarsi dalle Brigate Rosse non avevano in alcun modo intaccato il nostro affetto. I giorni trascorsi nella stessa cella, al bunker dell’isola, furono così pieni di confidenze sulla nostra vita privata. Giocammo a scacchi –costruiti con la mollica di pane – ridendocela a più non posso sul nostro incontro qualche anno prima, con quel gioco. Nel tempo della clandestinità, a Torino. Sull’onda del duello tra Carpov e Fisher Bicio aveva deciso di “sapere tutto” sugli scacchi, proprio come qualche anno prima aveva fatto con la rivoluzione bolscevica. S’era quindi comperato una scacchiera , tanti libri, riviste e s’era sprofondato nello studio. Venne finalmente il giorno della prima prova. Si sentiva pronto e col sorriso diceva: adesso ti faccio vedere… Ci provai col fatidico “scacco del barbiere”: scacco matto in pochissime mosse. E la sua inesperienza ebbe la peggio. Come al solito andò su tutte le furie e per un bel po’ di tempo di scacchi preferimmo non parlarne più.
All’Asinara mi disse anche dei malori che poco dopo lo portarono, rapidamente, alla morte. Ma di cosa effettivamente si trattasse, in quel carcere senza alcuna servizio medico, non fu possibile stabilirlo. Non si lamentò mai delle mancate cure: per lui era scontato. E anche questo, ricordando Bicio, non può essere più dimenticato”.

A Carlo Giuliani, 8 anni dopo
Scrivere a te mi è stato facile per molto tempo, quasi naturale … ora non lo è più.
E’ ogni giorno, ogni anno più doloroso e gli anni ormai son tanti, son otto.
Otto anni fa eri ancora vivo, lo eri a pochi passi da me, lo eravamo ancora tutti.
Quell’urlo, le urla di ognuno di noi squarciarono quel cielo maledetto, quel cielo violentemente limpido,
che appariva lontanissimo per il persistere dei fumi dei lacrimogeni… quel maledetto cielo che sarebbe stato meglio ci cascasse addosso: sarebbe stato meno doloroso di quell’urlo maledetto. Genova assassina e maledetta, Genova che mai liberammo, Genova che spezzò le nostre gambe senza farle mai rialzare..
Quell’urlo indimenticabile…che c’ha ammazzato tutt@ sette anni fa, e che persiste…
Carletto col nostro stesso sangue, Carletto con la stessa identica necessità di noi tutt@ di essere lì quel giorno,
Carletto e la sua voglia di vivere che l’ha fatto scendere in strada,
Carletto e il suo estintore, e il suo istinto di re-azione davanti a quel nemico marciante, mai visto prima in quel modo.
Un nemico nuovo, mai più come prima.
E in quello spartiacque sei scomparso tu, sangue nostro.
Tu e il tuo magro passamontagna.
Tu, ad aggiungerti a già troppi nomi, tu ad aprire la lista dei morti nostri, della mia generazione.
Ciao Carle’, mi vivi dentro passo dopo passo
A Carlo Giuliani, al suo assassino stupratore
“Non è un tipo che si fa ingabbiare”
Dieci, Nessuno, Trecentomila
Genova, dieci anni dopo
La vergogna di Strasburgo
Quel passo in più
A Dario Bertagna
DARIO BERTAGNA
– Nasce a Comerio (BG) l’8 luglio 1950
– lavora come impiegato presso una ditta di produzione di vernici di Vimercate (MI)
– milita nei Reparti Comunisti d’Attacco
– viene arrestato a Milano il 23 giugno 1980
– muore suicidia nel carcere di Busto Arsizio (VA) il 17 luglio 1988
Scritture di Dario Bertagna
– Dario Bertagna, lettera al Bollettino, 27-8-84, carcere di Fossano:
“Come mai allora questo trasferimento improvviso al manicomio di Reggio Emilia? Le cose stanno così: la dottoressa psichiatra del carcere, dopo una sbrigativa visita, aveva diagnosticato che L.V. era schizofrenico. Ma vi rendete conto?  Una persona legge quattro scartoffie riguardanti un carcerato, lo visita cinque minuti e lo giudica nientemeno che schizofrenico. Mi rendo conto che questa dottoressa probabilmente ha agito in buona fede e che ancora più facilmente le responsabilità maggiori stanno in qualche altro ingranaggio dell’apparato di potere. Sta di fatto che questi signori si rendono conto che non sono altro che dei meccanismi di una macchina mostruosa, ingranaggi più o meno determinanti, ma ciascuno facendo parte di un congegno degenerato che a sua volta genera le singole parti.
Una persona legge quattro scartoffie riguardanti un carcerato, lo visita cinque minuti e lo giudica nientemeno che schizofrenico. Mi rendo conto che questa dottoressa probabilmente ha agito in buona fede e che ancora più facilmente le responsabilità maggiori stanno in qualche altro ingranaggio dell’apparato di potere. Sta di fatto che questi signori si rendono conto che non sono altro che dei meccanismi di una macchina mostruosa, ingranaggi più o meno determinanti, ma ciascuno facendo parte di un congegno degenerato che a sua volta genera le singole parti.
Sia chiaro comunque che anche singoli proletari possono benissimo essere incorporati in questo brutale meccanismo e, anche se saranno rotelle di poco conto, si renderanno pur sempre funzionali al sistema. Mi riferisco tra l’altro specialmente ai vari dissociati, di nome o di fatto, o tutti e due. Certo lo Stato non manda costoro a Reggio Emilia e magari concede loro anche qualche zuccherino.
Facciamo bene i contri e vedremo con chiarezza che schizofrenico è questo sistema e tutti i suoi ingranaggi e non certo il compagno L.V.”
– I Compagni del movimento e i familiari dei detenuti, Volantino, 23 luglio 1988, Busto Arsizio
“Domenica scorsa, 17 luglio, il compagno Dario Bertagna si è tolto la vita nel carcere di Busto Arsizio, dopo aver scontato 8 anni di galera per reati politici. Malgrado la marginalità delle responsabilità penali, nel processo che ha deciso la messa in collaborazione dei pentiti come Barbone e di altri imputati che hanno scelto la strada della collaborazione e l’abiura, Dario subì una condanna a 15 anni di carcere. E’ questa l’ennesima dimostrazione di come le leggi e le prassi giuridiche nate dall’emergenza abbiano legato l’entità della condanna all’identità politica e al comportamento degli imputati, malgrado le autorità e gli intellettuali più o meno di regime, insieme ai partiti, abbiano ripetuto fino alla noia che “tutto si è sempre svolto nella legalità e nel rispetto delle regole della democrazia.”
 Dario non era né pentito né dissociato ed ha sempre lottato, con tutte le sue forze, per salvaguardare la propria dignità umana e la propria identità politica. Per 8 anni ha lottato contro la macchina di distruzione che è il carcere, in condizioni psicofisiche sempre più instabili, come i medici del carcere hanno avuto modo di constatare più volte. La sua morte, come tutte le morti avvenute in carcere, peserà come un macigno anche sui responsabili della disastrosa gestione dell’assistenza sanitaria, su quanti permettono che passino giorni e settimane prima di un ricovero, su chi tra la salute del detenuto e la sicurezza dell’istituzione sceglie sempre quest’ultima.
Dario non era né pentito né dissociato ed ha sempre lottato, con tutte le sue forze, per salvaguardare la propria dignità umana e la propria identità politica. Per 8 anni ha lottato contro la macchina di distruzione che è il carcere, in condizioni psicofisiche sempre più instabili, come i medici del carcere hanno avuto modo di constatare più volte. La sua morte, come tutte le morti avvenute in carcere, peserà come un macigno anche sui responsabili della disastrosa gestione dell’assistenza sanitaria, su quanti permettono che passino giorni e settimane prima di un ricovero, su chi tra la salute del detenuto e la sicurezza dell’istituzione sceglie sempre quest’ultima.
Oltre a tutto ci preme ricordare che non più di un mese fa il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva negato a Dario la semilibertà, nonostante gli 8 anni di galera scontati, le sue precarie condizioni di salute e l’ottenimento di un posto di lavoro in una fabbrica del suo territorio. In carcere non avevano pesato sul suo contro gravi rapporti disciplinari o denunce. (…)
Con il suo ultimo gesto Dario ha gridato ancora una volta il suo rifiuto a piegarsi al patto infame che impone la svendita della propria dignità in cambio della scarcerazione.
Noi siamo oggi davanti al carcere di Busto Arsizio e poi in piazza per ricordare alla gente che l’angolo di barbarie costruito negli anni dell’emergenza e nel quale sono già morti troppi detenuti non deve continuare la sua opera di distruzione.”
– Giulio Petrilli, Testimonianza al Progetto Memoria, L’Aquila 1995
“Ricordare Dario è ricordare un compagno col quale ho condiviso dei momenti, delle lotte, dei sogni, in una realtà particolare come il carcere di San Vittore, dal dicembre ’80 alla metà dell’83. Un momento di grandi lotte in uno dei carceri metropolitani più particolari, più complessi. Dario l’ho conosciuto esattamente il 6 gennaio 1981, in una cella del secondo raggio, la nostra cella per tanto tempo, poi i trasferimenti ci hanno diviso.
Ricordo quel pomeriggio del 6 gennaio, dopo diversi giorni nelle celle d’isolamento fui fatto salire su in sezione, stavo un po’ sbandato tra arresto e isolamento, ma entrando in cella subito mi sentii a mio agio in un ambiente caldo; eravamo in cinque, un po’ stretti ma stavamo bene. E’ lì che conobbi Dario, mi sembrò subito così come poi l’ho conosciuto nel tempo: un ragazzo riservato ma estremamente dolce, il suo aspetto rispecchiava il suo carattere, con quel sorriso un po’ triste negli occhi azzurri. Ricordo mi offrì subito una birra, e preparò insieme agli altri una bella cenetta; e poi quelle birre che hanno accompagnato tanti nostri pomeriggi e tante serate. Ricordo che mi riempì di domande, sai appena arriva uno nuovo è un po’ d’abitudine in carcere sentire i racconti della vita fuori. Lui disse che era stato arrestato nel giugno precedente, e che da poco si trovava a San Vittore. In precedenza era stato a Fossano, un carcere penale e mi raccontò della vita lì, delle diversità con San Vittore anche perché poi lì al secondo raggio eravamo tutti politici, mentre lì, con i comuni c’era un’altra realtà, più da logica carceraria. Poi iniziò a raccontarmi della sua vita fuori; era tecnico di una piccola azienda di elettrodomestici, vicino a Milano; mi raccontò del paese vicino Varese, dove abitava e quando ne parlava si capiva che lui preferiva vivere lì e non in una grande città, anche perché da piccolo aveva vissuto in un paesino del bergamasco. Poi mi raccontò della sua esperienza politica a Milano, la sua politicizzazione passata attraverso la sindacalizzazione nella fabbrica dove lavorava, i contrati, le lotte, l’inasprimento del padronato, la coscienza sempre più approfondita che lui andava maturando, lo scontro con le logiche di totale mediazione, che lui chiamava “arrendevolezza del vertice del sindacato”, il suo travaglio e la rottura completa con il sindacato. La sua incredulità nel raccontare che molti dirigenti d’industria e capi reparto tra i più duri erano iscritti al PCI.  Lui non se ne faceva capace che chi imponeva la produttività, il sacrificio, la logica di lottare, ma portando sempre il profitto all’azienda, erano quelle le persone che a parole si dicevano comuniste. Questa cosa per lui era totalmente inammissibile, da lì maturò la scelta della lotta armata. E questa sua scelta, maturata proprio partendo dall’avversione verso la cultura stalinista e produttivista del PCI, se l’è portata dietro sempre, con coerenza fino alla fine.
Lui non se ne faceva capace che chi imponeva la produttività, il sacrificio, la logica di lottare, ma portando sempre il profitto all’azienda, erano quelle le persone che a parole si dicevano comuniste. Questa cosa per lui era totalmente inammissibile, da lì maturò la scelta della lotta armata. E questa sua scelta, maturata proprio partendo dall’avversione verso la cultura stalinista e produttivista del PCI, se l’è portata dietro sempre, con coerenza fino alla fine.
Dario era chiuso, un po’ introverso ma estremamente determinato e lucido; io non concordavo alcune questioni del suo ragionamento ma in fondo ero con lui, soprattutto in quegli anni a San Vittore. Poi le nostre strade si sono divise, ci siamo scritti qualche lettera, lui non concordava la mia scelta critica al metodo della lotta armata che secondo me non si adattava più, ma c’è sempre stato dell’affetto.
Poi siamo nati lo stesso giorno, l’8 luglio festeggiavamo i compleanni insieme, sognavamo insieme, io ci scherzavo un po’ su, sulla sua rigidità. Abbiamo studiato tanti libri, documenti, insieme, nelle lunghe e interminabili discussioni e passeggiate nel cortile, dove lui, tra una sigaretta e l’altra, si faceva chilometri a piedi, molto spesso da solo, assorto nel suo mondo. E io scherzavo dicendo: “Torna in terra, vieni a giocare a pallavolo, a correre”. Con l’ironia e lo scherzo molto spesso comunicavo con lui , con quel suo modo d’essere reticente nel parlare anche della sua vita privata, dei suoi amori. Con quel suo bene grande che voleva alla sorella, che spesso veniva a trovarlo, portandogli anche dei pacchi che consumavamo insieme.
Poi, come spesso accade, ci siamo persi. E ci siamo ritrovati tanti anni dopo, nel maggio dello scorso anno, sfogliando una pagina del libro La mappa perduta, ho letto il suo nome e l’ho rivisto nel cuore, in quel suo grande cuore che non voleva mai manifestare, che voleva quasi coprire, proteggere, con un po’ di scontrosità”.
AD ANNAMARIA MANTINI
ANNAMARIA MANTINI
-Nacque a Fiesole, l’11 aprile 1953
-Frequenta le scuole a Firenze e nel 1973 si iscrive a Lettere e Filosofia
– Nel 1975 si trasferisce a Roma
– Milita nei Nuclei Armati Proletari
– Viene uccisa dai carabinieri a Roma l’8 luglio 1975
Documenti prodotti da organizzazioni armate per la per persona o per l’evento in cui ha incontrato la morte:
– Nuclei Armati Proletari, Comunicato 9-7-75 in: Soccorso Rosso napoletano (a cura di), I nap, Milano 1976, Collettivo Editoriale Libri Rossi.
“9 luglio 1975: Ieri in un agguato teso dalla polizia, è stata uccisa a freddo la compagna Annamaria. La volontà del potere di chiudere la partita con i compagni che si organizzano clandestinamente, ha armato la mano del killer di turno, che con la precisa coscienza di uccidere, ci ha privato di una compagna eccezionale.
Annamaria era uno dei compagni che hanno dato vita al nucleo “29 ottobre”. Ha fatto parte del gruppo che ha sequestrato sotto casa il magistrato Di Gennaro, e il contributo che ha dato alla costruzione ed esecuzione di questa azione, dimostrando il livello politico militare che aveva raggiunto. E’ enorme l’abisso che separa una compagna rivoluzionaria da uno sbirro. Non basterebbero la vita di cento Tuzzolino per pagare la vita di Annamaria.
Questo non significa che dimenticheremo i Tuzzolino, i Barberis, così come non abbiamo dimenticato i Conti e i Romaniello.
La mano che uccide un proletario ci è nemica come i porci che la armano. Ma lo ripetiamo, non è uccidendo uno o più sbirri che i proletari si possono ripagare del prezzo che stanno pagando per liberarsi. E per questo prezzo altissimo, in noi come in tutti i rivoluzionari, non c’è solo la rabbia ma anche la coscienza che il movimento si sta arricchendo in maniera definitiva del patrimonio di importantissime esperienze che questi compagni ci lasciano.
Le giornate di aprile, le innumerevoli azioni armate, gli espropri per autofinanziamento, le azioni nelle carceri, dimostrano la crescita di una nuova generazione di combattenti, e non bastano gli omicidi e gli arresti per distruggerla.
La nostra esigenza di comunismo è indistruttibile.
Luca Mantini, Sergio Romeo, Bruno Valli, Vito Principe, Gianpiero Taras, Margherita Cagol, Annamaria Mantini.
Non siete i soli e non sarete gli ultimi, ma rappresentate per tutti i rivoluzionari una scelta irrinunciabile.
Lotta armata per il comunismo
Nucleo Armato 29 ottobre.
Documenti prodotti da gruppi sociali
– Anna Maria Mantini, in: Nuclei Armati Proletari, Quaderno n.1 di Controinformazione, Milano 1976
“Comunista da sempre, ma solo a 17 anni inizia ad interessarsi attivamente di politica sull’onda della contestazione studentesca del ’68. Quando il fratello viene arrestato (’72) entra a far parte dell’allora Soccorso Rosso fiorentino. L’esperienza diretta, la grande sensibilità nei confronti delle esigenze del proletariato detenuto la portano alla spontanea scelta verso questo settore di intervento.
Vive dall’interno le contraddizioni dei “nuclei carceri” di Lotta Continua.
 Di sua iniziativa prende contatti con altri detenuti ed ex-detenuti, con i quali mantiene rapporti sempre più intensi: sono loro lo stimolo principale alla sua maturazione politica, il suo punto di riferimento ed è con loro che critica le posizioni attendeste di LC.
Di sua iniziativa prende contatti con altri detenuti ed ex-detenuti, con i quali mantiene rapporti sempre più intensi: sono loro lo stimolo principale alla sua maturazione politica, il suo punto di riferimento ed è con loro che critica le posizioni attendeste di LC.
Dopo una breve militanza in Potere Operaio ne esce per dar vita insieme ad altri compagni al Collettivo G. Jackson.
Il radicalizzarsi delle posizioni all’interno e all’esterno del carcere la rendono cosciente della necessità di operare sui livelli più avanzati dello scontro, ciò la spinge ad approfondire i rapporti con i compagni dei NAP.
Con l’assassinio di due di loro durante un’azione di autofinanziamento viene a rompersi un legame politico e umano fortissimo. “E’ inutile che io nasconda dietro la mia fede politica la mutilazione grossissima che ho avuto” scrive ad un mese dalla morte del fratello.
Ma non per questo affretta o decelera una scelta che già da tempo aveva fatto. La maturità politica, la carica umana, l’odio profondo per l’istituzione carceraria la vedono fondatrice del nucleo 29 Ottobre. Verrà assassinata a 22 anni, ma come spesso ripeteva lei stessa: “E se la morte ci sorprende all’improvviso, che sia la benvenuta, purchè il nostro grido di guerra giunga ad un orecchio che lo raccolga, un’altra mano si tenda per impugnare le nostre armi e altri uomini si apprestino ad intonare canti funebri con il crepito delle mitragliatrici e nuove grida di guerra e di vittoria.”
QUI, il mio omaggio agli altri compagni uccisi dallo stato: omaggio che giorno dopo giorno cerco di completare per non dimenticare nessun@
A loro, sangue nostro.
Ad Antonio Lo Muscio
ANTONIO LO MUSCIO
– Nasce a Trinitapoli (FG) il 28 marzo 1950
– Non risponde alla chiamata per il servizio militare ed è quindi arrestato nel 1970 dove rimane per 2 anni
– torna in carcere più volte
– nel 1975 lavora alla Fargas di Novate milanese per qualche tempo
– milita nei Nuclei Armati Proletari
– viene ucciso dai carabinieri a Roma, il 1 luglio 1977
Scritture di Antonio Lo Muscio
– “Lettera ad un amico”, carcere di Procida, 5 Marzo 1974
Caro compagno spero tanto che tu stia sempre bene. Quando uscirò oltre a lavorare normalmente, cercherò di svolgere anche un certo lavoro politico coinvolgendo se sarà possibile gli stessi elementi che ieri come me vivevano al di fuori della realtà. In un mondo diverso da quello reale dove si vede nel denaro la sola via d’uscita, così come ci ha insegnato la borghesia, che con i soldi fa e disfa a suo piacimento. Bisogna far capire loro come ho capito io che chi ha il potere di fare e disfare a suo piacimento è uno solo, il popolo. E’ questa la vera forza che fa cambiare il mondo, e non il denaro. Tutte le soddisfazioni ce le potremo prendere una volta abbattuti gli sporchi capitalisti e tutte le forze reazionarie esistenti. Solo quando questo sarà attuabile tutti gli uomini si potranno ritenere uomini, oggi siamo sulla via di transizione, cioè uomini lo stiamo diventando solo ora.
– “Lettera ad un amico”, carcere di Perugia, 5 Gennaio 1975
Carissimo compagno, come sai fra non molto sarò fuori precisamente fra 18 giorni. Di questo sono contentissimo per il fatto che uscendo potrò veramente dedicarmi alla lotta politica e in questo modo darò un significato alla mia stessa vita. Dico questo in riferimento a ciò che ero prima, cioè prima che entrassi in carcere. Sono del parere, se il tempo della detenzione viene usato bene, che, almeno una volta, tutti, senza escludere nessuno, dobbiate venire in carcere a vedere da vicino quello che veramente è l’istituzione carceraria e la sua violenza.
Testimonianze al Progetto Memoria
– Silvana Innocenzi, Testimonianza al Progetto Memoria, Firenze 1995
“Un ragazzo intelligente, timido e sensibile. Un sorriso spontaneo, carico di tenerezza e di entusiasmo per la vita. Così la mia mente ricorda il primo incontro con Antonio. Mi colpì la disponibilità e la generosità che aveva nei confronti degli altri, la sua capacità di ascoltare.
Bello, dicevano le compagne che lo incontravano o che hanno avuto modo di conoscerlo nella sua passione politica. Io ero rimasta affascinata dal suo carattere, dal suo mondo interiore. […]
Arrivò il servizio militare e venne inviato a Como proprio mentre era nata un’intensa storia d’amore. La ragazza rimane incinta ( un figlio che poi non nascerà a causa di un aborto spontaneo )… e lui la raggiunge… la classica fuga.
Viene raggiunto a casa e dichiarato in stato di arresto. Ne nasce un tafferuglio… processato e condannato venne rinchiuso nel carcere di Forte Boccea e poi a Gaeta. E’ l’inizio dell’impatto con il carcere.
Il padre iscritto al PCI discuteva spesso con lui. Discussioni animate in cui Antonio, con la passione politica che aveva maturato contestava al padre la politica riformista e revisionista del PCI. In quegli anni lui era ideologicamente più vicino alla sinistra extraparlamentare. Fin da ragazzo era alla continua ricerca di un mondo diverso, più giusto, con meno differenze sociali, con meno sfruttamento e meno emarginazione.
Il suo primo sguardo l’ho incrociato dietro un bancone di una sala colloqui del carcere di Perugia. Era finito lì, dopo la detenzione militare, per un reato definitivo di furto.
 A Perugia insieme ad altri compagni aveva dato vita al Collettivo delle Pantere Rosse, sull’onda del movimento delle Black Panthers americane. […]
A Perugia insieme ad altri compagni aveva dato vita al Collettivo delle Pantere Rosse, sull’onda del movimento delle Black Panthers americane. […]
I nostri incontri a colloquio, erano dei momenti intensi di confronto e scambio, di comunicazione tra realtà diverse. Io che frequentavo il movimento di liberazione della donna e lui che mi parlava dell’assurda vita coatta. Delle vite e delle sofferenze che erano rinchiuse all’interno delle mura di un carcere. Dell’uso dei letti di contenzione e dei manicomi giudiziari per le persone che meno si adattavano alla vita del carcere, alle sue regole.
Era felice quando poteva comunicarmi una piccola conquista interna, sia che si trattasse di spazi di socialità, di condizioni lavorative migliori o della possibilità di far entrare libri e altro materiale scritto senza l’intervento della censura.
Era felice perché stava cambiando qualcosa e si rendeva contro che poteva farlo anche all’interno di un’istituzione così totale come è, ed era, il carcere.
Mi regalò il libro Col sangue agli occhi di Jackson. “Leggilo, mi disse, dimmi cosa ne pensi, secondo me è stupendo”.
Lo lessi e capii che lui lì ritrovava tutte le sue emozioni più forti: rabbia, odio, amore. Non amava il sottoproletariato di Marx, amava il proletariato di Fanon.
Intanto le rivolte nelle carceri aumentavano e quella del carcere di Alessandria fece discutere più di tutte. C’erano stati dei morti tra il personale civile sequestrato.
Alcuni detenuti della rivolta finirono anche a Perugia e iniziò anche lì un’attiva campagna di controinformazione su quanto era realmente accaduto durante il sequestro degli ostaggi,
Sognare, realizzare un’evasione è il desiderio più vivo di ogni recluso per sottrarsi ad una situazione che, per quanto può essere vivibile, toglie il bene più importante: la libertà dell’individuo.
“Liberare tutti” era il messaggio più radicato tra i detenuti di quegli anni.
Alla rabbia istintiva, individuale, cosciente di molti detenuti, i Nuclei Armati Proletari diedero una progettualità collettiva e rivoluzionaria.
Antonio ci si ritrovò.
Un giorno con discrezione mi diede un foglietto dattiloscritto, voleva sapere cosa ne pensavo. Erano delle riflessioni sulla lotta armata, sulla sua possibilità e necessità. Non riuscii subito a dargli una risposta, ero solo cosciente che lì, in carcere più che altrove, le mediazioni non erano possibili.
Uscì nel 1974. Mi presi dei giorni di ferie dal lavoro e l’aspettai all’uscita. Fu sorpreso. Aveva i capelli lunghi, la barba e un cappotto lungo che gli davano un aspetto particolare, tra l’originale e il demodé. […] Furono momenti stupendi. E solo oggi che ho anche io vissuto l’esperienza del carcere posso coglierne ulteriori sfumature.
Cercò i compagni che conosceva, gli amici che da tempo non rivedeva. Alcuni lavoravano in fabbrica e lo invitarono alle loro riunioni. Io a Roma, lui a Milano, ma continuammo a vederci circa ogni 15 giorni.
Il carcere però non lo aveva dimenticato, soprattutto non aveva dimenticato le persone che aveva lasciato e che voleva aiutare ad uscire da quei luoghi di non vita. Continuammo ad andare ai colloqui e a seguire alcuni compagni nei bisogni più immediati.
Intanto nel suo cuore c’era la speranza di entrare in contatto con i compagni dei NAP che iniziavano a fare le loro prime azioni.
Ma il passaggio decisivo alla lotta armata avvenne quando la polizia uccise a Roma, sul pianerottolo di casa, la compagna Anna Maria Mantini (presto questo blog dedicherà una pagina anche a lei). L’aveva conosciuta, apprezzata, stimata moltissimo. Ne discutemmo a lungo di questa sua morte. Non ci volle molto a capire che avrebbe continuato la sua lotta. […] La mia scelta non tardò ad arrivare.
Vivere con lui un periodo della mia militanza nei NAP è stato di un’enorme ricchezza. Era la prima volta che dividevamo insieme più cose, dalla quotidianità al grande sogno di un mondo diverso. Non c’è mai stata tra noi una grande divisione di ruoli, ci alternavamo in molte cose; quello che detestava era fare acquisti, anche quanto le cose servivano a lui. Non viveva la sua scelta separata alle altre dimensioni della vita. La sua concezione di guerriglia conciliava con tutto: azioni, amore, famiglia e figli. Tutto era un unico grande filo rosso.
Viaggiavamo sempre molto uniti, tanto da diventare oggetto di simpatica ironia per gli altri compagni.
L’ultima immagine che ho di lui vivo è quella della separazione alla stazione Termini. Io partivo per Torino, per incontrare dei compagni, e lui mi aveva accompagnato. Non voleva farmi partire, ma io insistetti. Mi girai più volte a guardarlo andare via e giurammo che al ritorno avremmo mollato tutto per festeggiare il mio compleanno.
Ma non potemmo farlo. Appena arrivata a Torino fui arrestata.
Mi raggiunge anche in carcere con simpatiche cartoline, brevi, affettuose, cariche di emotività, quasi a voler colmare il vuoto e la distanza che si era creata materialmente tra noi.
Intanto i compagni continuavano ad essere arrestati, la caccia all’uomo era diventata sempre più accerchiante, e la vita per lui e per gli altri non deve essere stata facile negli ultimi periodi.
Poi un giorno, il primo luglio 1977, la terribile notizia appresa da un banale giornale radio tra le mura di una cella di Marassi, a Genova.
Ucciso durante un conflitto a fuoco con i carabinieri a Roma, piazza san Pietro in Vincoli, vicino alla facoltà di ingegneria, all’età di 27 anni, mentre tentava di sfuggire all’arresto con altre due compagne.
Falciato dalle raffiche di mitra fu poi freddato con una pallottola sparata a pochi centimetri dalla nuca. Non volevano arrestarlo, ma ucciderlo.
Non ci rivedemmo più.
Da una testimonianza raccolta da un giornalista del Corriere della Sera e pubblicata il 2 luglio: “Prima è passato di corsa quel giovane, Lo Muscio, inseguito da un carabiniere che sparava raffiche di mitra. E’ caduto proprio a pochi metri dall’ingresso della facoltà, cercando di sostenersi con le braccia e urlando per il dolore.
E’ a questo punto che il carabiniere, fatti pochi passi, ha lasciato partire un’altra raffica e Lo Muscio è stato fulminato. Gli ultimi colpi sono stati sparati dal carabiniere con una pistola.”
– Amici di Antonio, testimonianza collettiva al Progetto Memoria, Roma 1995
“Antonio l’ho conosciuto in carcere, nelle prime lotte. E’ diventato un compagno dei NAP proprio stando insieme a noi. Antonio era un compagno generoso, molto disciplinato. Quando si accostò al collettivo di Perugia doveva uscire di lì a poco. Gli dissi, se vuoi conoscere un compagno eccezionale, vai a questo indirizzo, e gli diedi l’indirizzo di Luca Mantini (anche di Luca ne parleremo presto ). Lui uscì. E per quanto sembri incredibile, era la sera di Piazza Alberti, del giorno in cui Luca era morto in piazza Alberti. Naturalmente non poteva saperlo e andò in casa di Luca. Lì trovò Annamaria.
Vennero a casa mia insieme quella sera e fu la prima volta che lo vidi. Dopo di allora ci siamo incontrati molte volte. Con me non aveva un rapporto politico, era una cosa un po’ strana, un rapporto molto umano. Antonio era un tipo gioviale, festoso. Cantava. In macchina cantava sempre. Ricordo di un viaggio con Antonio.
Me lo ricorderò tutta la vita. Prendemmo un vassoio, pesante come un macigno. E partimmo. Attraversando mezza Italia. E durante tutto il viaggio, sebbene spossato di stanchezza, cantava. […] Si fermò all’alba in un negozio di alimentari, comprò un po’ di gnocchi di patate. Poi, da un’altra parte, del pomodoro crudo. Li condimmo così, a mano. Al controllo dei cibi, in carcere, comunque mi restituirono il vassoio con tutti quegli gnocchi, e mi dissero seraficamente di metterli in un contenitore di plastica… Mi ricordo quest’ episodio perché dice come era fatto Antonio: se c’era da fare una cosa, lui partiva all’una di notte, attraversava l’Italia e la faceva, con allegria. Antonio era subito disponibile, sempre allegro, ti sapeva mettere subito a tuo agio.
QUI, un’intervista a Franca Salerno, arrestata e pestata (con un bel pancione) insieme Maria Pia Vianale mentre Antonio veniva giustiziato.
A Lorenzo Bortoli, 30 anni dopo la sua morte
LORENZO BORTOLI
– Nasce a Torrebelvicino (VI) il 23 dicembre 1954
– Si diploma e lavora come operaio decoratore alla Blue Bell di Bassano
– milita nel movimento studentesco
– convive con Maria Antonietta Berna, nella casa di Thiene dove avviene l’esplosione dell’11 febbraio 1979
-viene arrestato il 12 febbraio 1979 nell’inchiesta sui Collettivi Politici Veneti
-muore suicida nel carcere di Verona, il 19 giugno 1979
Scritture di Lorenzo Bortoli
– Verbale di confronto tra coimputati, Padova 15-6-79
“Il Bortoli al P.: “Ripeto ancora una volta che è falso quello che tu hai detto; ricordati di questo particolare: nella comune cella, mentre giocavamo a carte io ho estratto di tasca l’ultimo mandato di cattura notificatomi e nel leggerne la motivazione dove si faceva cenno a dichiarazioni di coimputati ebbi un moto di sorpresa; tu spontaneamente mi dicesti che eri stato tu e che avevi riferito su confidenze non vere perché ti era stata promessa dagli inquirenti la derubricazione delle imputazioni e la concessione della libertà provvisoria.”
– Foglio di richiesta, Carcere di Verona 18-6-79
“Al signor direttore della casa circondariale di Verona.
Le sarei veramente grato se potesse far pervenire ai miei familiari il seguente telegramma: “Raggiunto Antonia. Vi prego di essere sepolto con lei. Vi assicuro che sto bene così. Un abbraccio. Dite a Vanna di non piangere, ma di ricordarsi come eravamo felici come ora che siamo nuovamente insieme. Lorenzo”
La pregherei di far pervenire anche il gruppo di fotografie, difalcando le spese dal mio conto personale. La ringrazio vivamente.
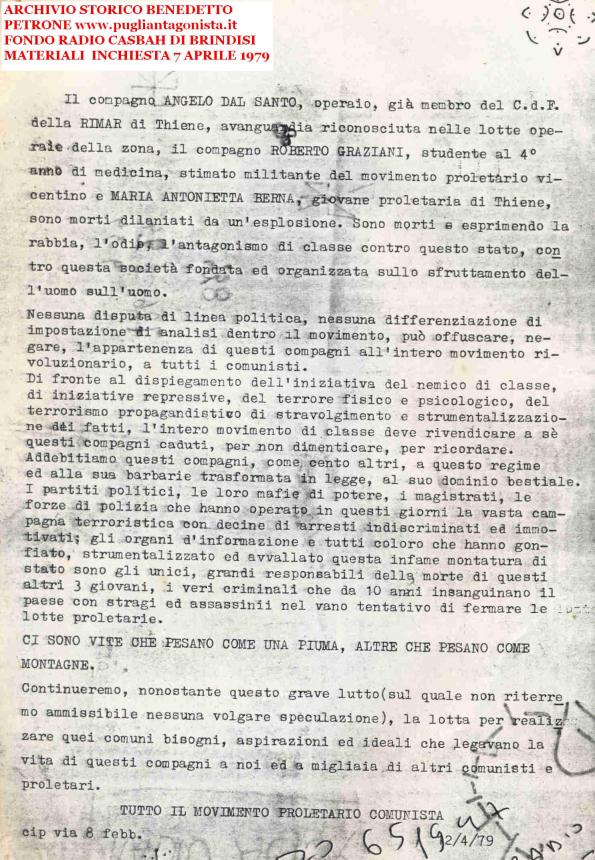 Documenti prodotti da organizzazioni armate:
Documenti prodotti da organizzazioni armate:
-Movimento Comunista Organizzato, Manifesto A Lorenzo Bortoli 19-6-80
“Questo non vuole essere un epitaffio commemorativo, tu per primo non lo vorresti. Lasciamo alla società borghese la misera forma ipocrita di commemorare i propri morti.
Noi vogliamo ricordarti da comunista, da proletario in lotta contro la barbarie del capitale, dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, delle morti “bianche” e per aborto, del rifiuto ad una vita invivibile. Questo è un filo rosso che unisce la tua vita alla nostra, la tua militanza comunista alla vita di milioni di proletari che quotidianamente lottano contro i propri sfruttatori. La tua vita continua in noi nella volontà e nell’impegno che ci assumiamo nel non voler dimenticare chi ti ha costretto al suicidio.
Certo credevano attraverso la tua morte di annientare e terrorizzare centinaia di compagni che come te lottavano e soffrivano in carcere mentre in realtà la tua morte ha smascherato ancora una volta e per sempre chi si nasconde dietro il paravento della legge e della democrazia.
La tua scelta è stata una forma di lotta, non una sconfitta. Questo tutti i rivoluzionari ed i veri comunisti lo hanno capito.
Mai dimenticheremo con quanto odio le bande armate di Dalla Chiesa ti hanno aggredito; come il PM Rende ha pianificato sin dall’inizio la tua morte, attraverso l’isolamento, il non ricovero in ospedale dopo il tuo primo tentativo di suicidio, con la provocazione dell’inserimento con te in cella del burattinaio vigliacco C.P.
Vogliamo gridare guardandoli in faccia tutto il nostro odio verso queste figure, vogliamo che sentano continuamente tutto il nostro disprezzo proletario: spregevoli giocattoli nelle mani dei loro padroni.
Certamente questo non ti farà essere fisicamente tra noi. Tu vivi nella nostra irriducibilità al sottometterci allo Stato del capitale, vivi nel nostro bisogno di comunismo. Per tutto questo ti onoriamo e ricordiamo.
O tutti o nessuno.
Onore a Lorenzo, Angelo, Alberto e Antonietta.
Per il comunismo.
Documenti prodotti da gruppi sociali:
– Comitato di zona Partito Comunista Italiano, “Un suicidio che riempie di sdegno, Thiene 21-6-79
“Apprendiamo con profondo sgomento e indignazione la notizia della morte, nel carcere di Verona, di Lorenzo Bortoli. E’ accaduto ciò che si temeva e ciò che le forze dell’amministrazione della giustizia erano tenute ad evitare. Era infatti evidente che dopo 2 tentativi di suicidio Lorenzo Bortoli si trovava in uno stato psicofisico di estrema prostrazione e che, in mancanza di cure adeguate, di un’attenta assistenza e sorveglianza, di un trattamento più umano e non assolutamente segregante, non avrebbe desistito nel suo intento di togliersi la vita. Proprio queste cure, questa assistenza, avevamo 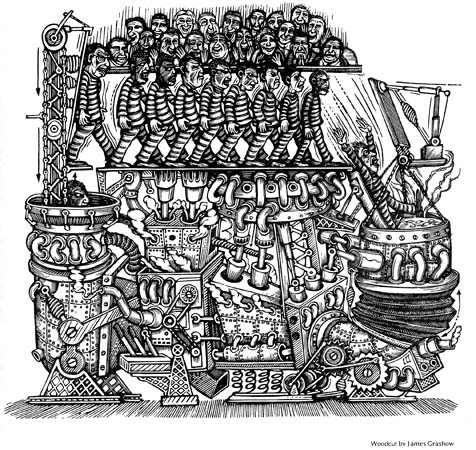 sollecitato aderendo all’appello del 30 Maggio lanciato da alcune personalità e cittadini democratici sul Giornale di Vicenza. Anche alla luce di ciò, il comportamento delle autorità giudiziarie e dell’amministrazione carceraria è tale da suscitare sdegno e riprovazione, in quanto si è dimostrato insensibile e incurante verso il diritto fondamentale di ogni essere umano: il diritto alla vita, e verso i diritti costituzionali di un imputato di potersi difendere, nella pienezza delle proprie facoltà intellettuali e fisiche, dalle accuse mossegli. Il suicidio di Lorenzo Bortoli è quindi un fatto di eccezionale gravità. Le responsabilità nel comportamento delle autorità carcerarie e giudiziarie vanno perciò indgate e punite, per salvaguardare i valori dello stato di diritto e le garanzie che la Costituzione da ad ogni cittadino.”
sollecitato aderendo all’appello del 30 Maggio lanciato da alcune personalità e cittadini democratici sul Giornale di Vicenza. Anche alla luce di ciò, il comportamento delle autorità giudiziarie e dell’amministrazione carceraria è tale da suscitare sdegno e riprovazione, in quanto si è dimostrato insensibile e incurante verso il diritto fondamentale di ogni essere umano: il diritto alla vita, e verso i diritti costituzionali di un imputato di potersi difendere, nella pienezza delle proprie facoltà intellettuali e fisiche, dalle accuse mossegli. Il suicidio di Lorenzo Bortoli è quindi un fatto di eccezionale gravità. Le responsabilità nel comportamento delle autorità carcerarie e giudiziarie vanno perciò indgate e punite, per salvaguardare i valori dello stato di diritto e le garanzie che la Costituzione da ad ogni cittadino.”
– AA.VV. Frammenti di coordinamenti, collettivi, radio.
“Lorenzo Bortoli, operaio decoratore alla Blue Bell di Bassano, arrestato dopo l’esplosione dell’11 febbraio di Thiene dove era tragicamente morta la sua compagna Maria Antonietta Berna, si è tolto la vita impiccandosi nel carcere di Verona. E’ un suicidio che noi chiamiamo assassinio e del quale riteniamo responsabili tutti coloro che hanno abbandonato Lorenzo a se stesso, spingendolo prima alla disperazione con l’accusa di omicidio nei confronti della persona che amava di più, diffamandolo poi come dedito alla droga quando tentò di suicidarsi una prima e una seconda volta ingerendo dei medicinali, rifiutando infine il suo ricovero in ospedale come da tempo richiesto dal collegio di difesa e sollecitato anche da organismi sindacali e sociali della provincia, ma negato dai giudici del tribunale di Vicenza.
Tutto ciò è stato fatale per Lorenzo. L’obiettivo di questo Stato, cioè la distruzione fisica dei suoi avversari, ancora una volta è stato raggiunto. (…).
A tutte le strutture di movimento, a tutti i proletari della provincia proponiamo che la mobilitazione continui e si allarghi ponendosi come obiettivo centrale la messa in stato di accusa di tutti i responsabili della morte di Lorenzo. (…)”
Il coraggio dell’amnistia
Oggi il nuovo quotidiano L’Altro, ha aperto con un editoriale di Sansonetti decisamente importante, che riporterò qui sotto.
In questi giorni proverò a mettere un po’ di materiale sull’amnistia: perchè è una battaglia che dovremmo sentire nel sangue.
Per allontanare “dar catenaccio” chi ancora è costretto dentro un carcere…
IL CORAGGIO DELL’AMNISTIA di Piero Sansonetti (editoriale del quotidiano L’Altro di sabato 16 maggio 2009)
Giampiero Mughini ha raccontato ieri al Corriere della Sera (articolo di Aldo Cazzullo) i suoi ricordi e le sue riflessioni sull’uccisione del commissario Luigi Calabresi (anno 1972), Mughini all’epoca era vicino al gruppo dirigente di Lotta Continua, e quindi basa la sua ricostruzione (ipotetica) dei fatti su elementi di conoscenza personale (di abitudini, idee, rapporti, modi di comportarsi di quel periodo).  Mughini avanza l’ipotesi che Sofri non sia colpevole diretto, ma che sapesse. E che conosca i nomi di chi uccise Calabresi. Tesi che già in passato aveva sostenuto. Personalmente questa ricostruzione non mi convince. Penso che Sofri sia innocente. E constato che, in ogni caso, contro di lui non sono state raccolte prove, e i processi che si sono conclusi con la sua condanna erano processi indiziari, tutti fondati sulle dichiarazioni di un pentito (non verificate e non verificabili) il quale in cambio della condanna di Adriano Sofri ha ottenuto per se la libertà dopo pochissimi mesi di prigione (pur essendo stato condannato come autore materiale dell’uccisione).
Mughini avanza l’ipotesi che Sofri non sia colpevole diretto, ma che sapesse. E che conosca i nomi di chi uccise Calabresi. Tesi che già in passato aveva sostenuto. Personalmente questa ricostruzione non mi convince. Penso che Sofri sia innocente. E constato che, in ogni caso, contro di lui non sono state raccolte prove, e i processi che si sono conclusi con la sua condanna erano processi indiziari, tutti fondati sulle dichiarazioni di un pentito (non verificate e non verificabili) il quale in cambio della condanna di Adriano Sofri ha ottenuto per se la libertà dopo pochissimi mesi di prigione (pur essendo stato condannato come autore materiale dell’uccisione).
Sono assolutamente convinto del principio secondo il quale in mancanza di prove non si può condannare. E credo che un certo numero dei processi che si sono svolti negli anni ’80 (e in parte ’90) contro gli imputati di lotta armata o di reati politici, siano stati processi “zoppi”, poco convincenti, senza garanzie. Influenzati dal clima politico dell’epoca e condizionati da una legislazione speciale, basata sull’esaltazione del pentitismo, che non dava garanzie né di verità né di equanimità. Che le cose stiano così è abbastanza evidente. E ce ne accorgiamo ogni volta che le nostre autorità chiedono l’estradizione di qualcuno che fu condannato in quegli anni, con quei processi, e non la ottengono (recentissimo caso Battisti), Come mai non l’ottengono? Perché la Francia, il Brasile, il Canada, la Gran Bretagna, la Svezia, la Spagna eccetera eccetera sono paesi filo terroristi? Non mi pare una spiegazione ragionevole. Non la ottengono perché i processi sono considerati non affidabili. Tutto qui. Vedete bene che il problema esiste, e va affrontato seriamente. In che modo? Riprendendo la riflessione su quegli anni di fuoco, nei quali la lotta politica, in Italia, convisse con la lotta armata; e trovando il modo dì uscire definitivamente da quel clima e da quella storia. C’è un solo modo di uscire da quel clima e da quella storia.
Chiudendone tetti gli strascichi giudiziari e penali. Cioè con l’amnistia. Solo l’amnistia può relegare finalmente nel passato gli anni di piombo e di conseguenza permettere l’apertura di una discussione e di una riflessione seria. Quali sono gli argomenti contro l’amnistia?
In genere se ne sentono tre.
Il primo è il cosiddetto “diritto dei parenti delle vittime”.
Il secondo è la certezza della pena e il rischio che gente che ha seminato il male non paghi per il male, la faccia franca.
Il terzo è la paura che l’amnistia ci impedisca di scoprire cosa davvero è successo in quegli anni, cosa c’era dietro i delitti,
Il primo argomento mi sembra che non riguardi il diritto. Riguarda semmai la politica. I parenti delle vittime non hanno il diritto dì influire sulle pene dei colpevoli (o, talvolta, dei sospetti). Hanno il diritto ad essere risarciti, aiutati, assistiti. E spesso questo diritto non viene loro riconosciuto dallo Stato, ma l’amnistia non c’entra niente.
Il secondo argomento è sbagliato. Per un motivo molto semplice: la lotta armata degli anni settanta è l’unico capitolo della storia del delitto italiano che ha prodotto un numero altissimo di condanne e di pene. I ragazzi che furono coinvolti nella lotta armata, nella loro quasi totalità hanno pagato con anni e anni di galera. Non esistono altri “rami” del delitto dei quali si possa dire altrettanto.  Qualcuno ha pagato per le stragi di Stato? Qualcuno per la corruzione politica? Qualcuno per le responsabilità dell’ecatombe sul lavoro? Ho fatto solo tre esempi, ì più clamorosi» ma potrei continuare. E allora è curioso che si chieda la cer-tezza della pena per gli unici che la pena l’hanno scontata. Giusto?
Qualcuno ha pagato per le stragi di Stato? Qualcuno per la corruzione politica? Qualcuno per le responsabilità dell’ecatombe sul lavoro? Ho fatto solo tre esempi, ì più clamorosi» ma potrei continuare. E allora è curioso che si chieda la cer-tezza della pena per gli unici che la pena l’hanno scontata. Giusto?
Il terzo argomento è il più controverso. E’ la famosa questione del complotto. Qual è il problema? Una parte dell’opinione pubblica italiana (specialmente di sinistra) si era convinta, negli anni scorsi, che il fenomeno della lotta armata fosse troppo grande e vasto e potente per potere essere il semplice prodotto dell’impegno diretto e un po’ delirante di alcune migliaia di giovani. E che allora dovesse essere il risultato di un complotto nazionale o internazionale. Devo dire che per molti anni anche io mi ero convinto di qualcosa del genere. Avevo sospettato che il rapimento e l’uccisione di Moro fosse una losca congiura del potere. Però poi, di fronte alla realtà, bisogna arrendersi. I colpevoli sono stati tutti arrestati, sono state raccolte tonnellate di testimonianze, prove, documenti. Sono passati 30 anni. È chiaro che non ci fu complotto. Semplicemente avevamo sottovalutato la forza della rivolta armata. E allora perché negare l’amnistia con la scusa della ricerca della verità? È chiaro che le cose stanno in modo molto diverso. La verità che ancora non conosciamo, che vorremmo conoscere, è quella sulle stragi di Stato (da piazza Fontana 1969 fino alla Stazione di Bologna 1980). Cioè su quella parte di lotta armata (di controguerriglia) che fu organizzata direttamente dalle istituzioni e dal potere e che, tra l’altro, ebbe un peso forte nella nascita – per reazione – delle brigate rosse e delle altre formazioni eversive di sinistra. Nessuno è in prigione per quelle stragi (tranne alcuni estremisti d destra per la strage di Bologna, ma moltissimi esperti ritengono che essi siano innocenti). Con questi misteri l’amnistia non c’entra niente. E probabilmente se ci si decidesse a vararla potrebbe essere un aiuto per riaprire la discussione e la ricerca su quel buco nero della storia italiana.
Giorgiana Masi, per non dimenticare. Testimonianze di quel 12 maggio…
 Un piccolo omaggio a Giorgiana Masi, a 32 anni dal suo assassinio da parte della polizia di Stato guidata dal Ministro degli Interni Francesco Cossiga. Metto alcuni scatti e testimonianze di quella giornata…
Un piccolo omaggio a Giorgiana Masi, a 32 anni dal suo assassinio da parte della polizia di Stato guidata dal Ministro degli Interni Francesco Cossiga. Metto alcuni scatti e testimonianze di quella giornata…
Con l’augurio di trovarvi, come ogni anno, davanti a quel ponte, per portare un fiore a Giorgiana, sangue nostro.
Tratto da “Cronaca di una Strage” a cura del Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei
Giovanni Salvatore
Mi trovavo il 12 maggio, verso le 19,15 a Ponte Garibaldi […].
Su lungotevere Sanzio, proveniente da Ponte Sisto, ho visto un corteo a cui sono andato incontro per capire di cosa si trattasse. Ho raggiunto la testa del corteo : a questo punto la polizia che si trovava all’angolo tra Ponte Garibaldi e lungotevere Sanzio, ha lanciato bombe lacrimogene.  Sono scappato per una strada adiacente su Viale Trastevere, all’altezza di Piazza Sonnino. In quel momento la polizia è tornata indietro per fermarsi all’altro imbocco di Ponte Garibaldi, dalla parte di Via Arenula. All’imbocco del ponte dalla parte di Trastevere c’erano molte personé, sicuramente quelle che erano state disperse poco prima ed anche io mi sono fatto avanti per chiedere cosa stava succedendo. C’erano molte personé sedute sui gradini dei marciapiedi intorno a P.zza Belli, altre che facevano capannelli, mentre qualcuno ha posto al centro del ponte, facilmente riconoscibile per le sponde circolari, due macchine di traverso
Sono scappato per una strada adiacente su Viale Trastevere, all’altezza di Piazza Sonnino. In quel momento la polizia è tornata indietro per fermarsi all’altro imbocco di Ponte Garibaldi, dalla parte di Via Arenula. All’imbocco del ponte dalla parte di Trastevere c’erano molte personé, sicuramente quelle che erano state disperse poco prima ed anche io mi sono fatto avanti per chiedere cosa stava succedendo. C’erano molte personé sedute sui gradini dei marciapiedi intorno a P.zza Belli, altre che facevano capannelli, mentre qualcuno ha posto al centro del ponte, facilmente riconoscibile per le sponde circolari, due macchine di traverso
Questo era il quadro generale quando, verso le 19,45 la polizia attestata dall’altra parte dal ponte è avanzata sparando lacrimogeni.
Tra i rumorei degli spari si udivano chiaramente spari molto più Secchi, probabilmente da arma da fuoco. Ai primi spari stavano correndo tutti verso Viale Trastevere quando anche io ho iniziato a correre e davanti a me, di qualche métro Sulla mia sinistra è caduta a faccia avanti una ragazza che ho superato in corsa. A questo punto mi sono voltato ed ho visto che era ancora a terra. Sono tornato indietro per aiutarla ad alzarsi.  Ho provato a tirarla su ma non ce la facevo. Ho quindi invocato aiuto mentre continuavano a sentirsi spari di lacrimogeni ed altri spari, provenienti sempre da Ponte Garibaldi. A questo punto si sono fermate tre persone ed abbiamo sollevato la ragazza per le gambe e le braccia. Io l’ho presa per il braccio sinistro. […]
Ho provato a tirarla su ma non ce la facevo. Ho quindi invocato aiuto mentre continuavano a sentirsi spari di lacrimogeni ed altri spari, provenienti sempre da Ponte Garibaldi. A questo punto si sono fermate tre persone ed abbiamo sollevato la ragazza per le gambe e le braccia. Io l’ho presa per il braccio sinistro. […]
Una volta sollevata l’abbiamo trasportata di corsa nello slargo vicino al capolinea. Durante il percorso ha mormorato: “Oddio che male”. La persona che la trasportava per il braccio destro ha risposto “sarà stata la botta, non ti preoccupare”. Io pensavo che fosse caduta inciampando o perché colpita da un lacrimogeno, anche perché non abbiamo notato tracce di sangue.
Adagiata per terra il corpo si è immediatamente irrigidito, le mascelle serrate, le braccia tese, gli occhi sbarrati. Qualcuno ha detto che forse era una crisi epilettica. […] Si è fermata una macchina, abbiamo sollevato la ragazza e adagiata sul sedile posterioire. Ho riconosciuto il giorno successivo, sui giornali, Giorgiana Masi nella ragazza che ho soccorso.
Lelio Leone
Ho assistito personalmente al momento in cui Giorgiana cadeva. Siamo arrivati all’imbocco del ponte Garibaldi nel momento in cui la polizia arretrava verso Largo Arenula. Ci siamo spinti in avanti, fino alla metà del ponte, proprio al centro. La polizia intanto caricava alcuni compagni che scappavano nella direzione di Largo Argentina. Sul ponte non c’era nessuno. Saranno passati un paio di minuti e la polizia è tornata indietro, caricano un’altra volta nella nostra direzione. Ci si è fermati prima all’imbocco del ponte, dall’altra parte di Piazza Sonnino. Poi la polizia ha caricato una seconda volta… con le autoblindo. Correvano ed hanno sparato molto; pochi lacrimogeni e molti colpi di arma da fuoco. Insieme a me in quel momento c’erano una decina di altre persone. Gli altri compagni, all’altezza di largo Sonnino stavano formando delle barricate con delle auto. Abbiamo avuto difficoltà a scappare oltre queste barricate che dietro di noi i compagni avevano eretto. Lì c’erano mille compagni che scappavano. Assurdo dire che i colpi siano venuti dalla loro parte: io ero uno degli ultimi ed ho visto tutti con la schiena voltata. Sono stato colpito ad una gamba da un lacrimogeno, mi sono piegato e sono stato costretto a voltarmi. Ho visto tutto: una compagna, Giorgiana, correva ad un metro e mezzo da me. E’ cascata con la faccia a terra. Ha tentato di rialzarsi, a me sembrava inciampata. Poi l’abbiamo soccorsa e caricata su una Appia. L’abbiamo portata all’ospedale. Una cosa voglio sottolineare. Giorgiana era vicino a me, in un gruppo che scappava oltre le barricate che un migliaio di compagni avevano fatto più avanti. Radio Città Futura ha detto che è stata colpita al ventre: la cosa mi ha lasciato molto perplesso. I colpi venivano solo dalla parte dove c’era la polizia. Assieme alla polizia c’erano molti in borghese. Quelli in divisa erano sulle autoblindo, con le finestre aperte. Alla metà del ponte ci sono due rientranze in muratura: lì si sono appostati quelli in borghese, ed hanno sparato.
Elena Ascione
A un certo punto una parte della polizia si è mossa verso ponte Garibaldi. Non potendo attraversare mi sono mossa in direzione di Piazza Sonnino ed è a questo punto che si sono sentiti colpi d’arma da fuoco provenienti esclusivamente dalla parte in cui stava la polizia. Non sono in grado di precisare se erano colpi di pistola o di mitra. Io mi sono messa a scappare e sono stata colpita subito, mentre ero con le spalle verso il ponte e restando colpita da sinistra. Non ero in grado di vedere altre persone che cadevano. Erano circa le 20.
[Elena Ascione è stata colpita da un proiettile alla coscia mentre fuggiva verso piazza Sonnino, quasi nello stesso momento in cui è stata colpita Giorgiana Masi]
… se la rivoluzione d’ottobre
fosse stata di maggio,
 se tu vivessi ancora,
se tu vivessi ancora,
se io non fossi impotente
di fronte al tuo assassinio,
se la mia penna fosse un’arma vincente,
se la mia paura esplodesse nelle piazze,
coraggio nato dalla rabbia strozzata in gola,
se l’averti conosciuta diventasse la nostra forza,
se i fiori che abbiamo regalato alla tua coraggiosa vita
nella nostra morte diventassero ghirlande
della lotta di noi tutte, donne,
se …..
non sarebbero le parole a cercare d’affermare la vita
ma la vita stessa, senza aggiungere altro.
2° parte Commissione internazionale di inchiesta sulla morte di Ulrike Meinhof
Proseguo con la pubblicazione di alcune parti della Commissione internazionale d’inchiesta sulla morte di Ulrike Meinhof. Qui ci focalizzeremo un po’ di più su alcuni dettagli inquietanti sia delle due autopsie a cui è stata sottoposta, sia del ritrovamento del corpo, della sua posizione e della condizione della cella.
Affronteremo, la prossima volta, un accurata analisi degli accessi al braccio dove era detenuta, dell’illuminazione della stanza e dei verbali con gli interrogatori alle guardie penitenziarie che avevano il compito di sorvegliarla quella notte.
Qui la 1° parte della Commissione.
Qui invece la terza parte!
Presa di posizione di medici inglesi, 13 agosto 1976
“Com’è morta Ulrike Meinhof?
Il 9 maggio 1976, il mondo fu informato del ‘suicidio’ a Stoccarda di Ulrike Meinhof, quadro dirigente del gruppo Baader-Meinhof, nel carcere appositamente costruito, con misure di sicurezza particolari, in cui era stata detenuta per molti mesi prima e durante il processo. Da allora, sono venuti alla luce un certo numero di elementi che mettono in dubbio la versione ufficiale degli avvenimenti. Questi elementi hanno sollevato importanti quesiti, non solo per chi è impegnato politicamente, ma per tutti coloro che difendono le libertà civili.
Ulrike Meinhof è davvero morta per suicidi, per impiccagione? Oppure trattasi di morte per arresto cardiaco riflesso in seguito alla pressione esercitata sul suo collo da terzi? Vi è stata una violenza sessuale contro Ulrike Meinhof oppure solo un tentativo? IL significato di una risposta affermativa a una di queste domande non ha bisogno di essere dimostrato.
Sul corpo di Ulrike Meinhof sono state praticate due autopsie. Ci sono pervenuti entrambi i rapporti. Riteniamo necessario dare ampia diffusione all’opinione pubblica di questi risolutati profondamente inquietanti, sia per ciò che dicono, sia per ciò che non dicono.
Prendendo posizione, speriamo di sfuggire alle solite manipolazioni e alle deformazioni dei documenti fornitici; ugualmente desideriamo evitare l’orribile compiacimento “nel sangue dei martiri”, tanto caratteristico delle parrocchie e delle organizzazioni politiche. La linea politica di Ulrike Meinhof non è stata la nostra. Ma non è questo il problema.
L’autopsia ufficiale, nel suo rapporto, indica che il corpo è stato trovato mentre il tallone sinistro toccava ancora la sedia sulla quale sarebbe salita per appendersi. In altre parole, una “caduta” del corpo da una certa altezza non c’è stata. Se c’era stato suicidio, la morte avrebbe dovuto subentrare, verosimilmente, per asfissia e non per rottura della colonna vertebrale a livello delle vertebre cervicali superiori, come è solito nelle esecuzioni legali. (Infatti non c’è stato spostamento violento delle vertebre cervicali).
Uno dei segni più importanti d’asfissia per strangolamento è l’impossibilità per il sangue della testa di ritornare in circolo. Il sintomo di una tale impossibilità è la presenza di emorragie interstiziali nelle congiuntive. Ambedue i rapporti d’autopsia non rilevano simili emorragie. Inoltre, i rapporti non citano nemmeno la protusione degli occhi e della lingua, o la cianosi del viso, segni abituali della morte per asfissia. Nonostante la frattura dell’osso ioide alla base della lingua, non c’era alcuna tumefazione al collo, nella zona interna al segno lasciato dalla “corda ricavata da un asciugamano”, con la quale la detenuta si sarebbe impiccata.
Questi risultati negativi sono insoliti per una morte per asfissia; è il meno che si possa dire. Si inseriscono invece, molto bene nel quadro di morte per compressione del nervo vago, ossia di morte per pressione sulla carotide che può provocare un arresto cardiaco riflesso.
Ci sono altri risultati inquietanti. I due rapporti d’autopsia menzionano un edema importante nelle parti genitali esterne e tumefazioni ai polpacci. Le due perizie parlano di una escoriazione, coperta di sangue coagulato alla natica sinistra. Il rapporto di Janssen menziona anche un’ecchimosi nella zona dell’anca destra. L’esame dello slip della detenuta rileva macchie sospetto. Le analisi chimiche per la ricerca dello sperma, secondo la dichiarazione ufficiale, hanno dato risultati positivi malgrado l’assenza di spermatozoi. (Atti della procura, Istituto tecnico di ricerche criminologiche, rapporto dell’11 maggio 1976)”. 
Negli atti del PM il prof. Mallach constata che, malgrado un test di sperma positivom non sono stati rilevati spermatozoi. Ciò non prova nulla; se nella biancheria esistono tracce di materia fecale o di urina, gli spermatozoi sono disgregati dall’azione dei batteri e spariscono entro qualche ora. E macchie di urina sono state trovate nello slip di Ulrike Meinhof. L’azione di questi batteri attenua anche la reazione positiva dello sperma.
STRALCI DEL RAPPORTO DEL DOTT. HANS JOACHIM MEYER , membro della Commissione internazionale d’inchiesta
[…] Il materiale a nostra disposizione consiste dei rapporti di autopsia dei prof. Mallach e Rauscke e della seconda autopsia eseguita dal prof. Janssen; ambedue i rapporti sono incompleti: mancano i risultati degli esami microscopici e istologici. Inoltre vi sono i risultati dell’esame del cadavere, condotto dal prof. Rauschke il 9 maggio ’76, gli esami dell’Ufficio regionale della polizia criminale del Land di Baden-Wuttemberg e i risultati delle analisi dell’Istituto di Medicina legale a Tubinga.
I tre rapporti arrivano alla conclusione che si tratti di suicidio per impiccagione. Nel rapporto Mallach-Rauschke è detto testualmente: “LA posizione del corpo appeso alla cella, la disposizione e la lunghezza del mezzo servito all’impiccagione, nonché l’analisi degli elementi rilevati sul luogo e dei risultati medici dell’autopsia, corrispondono inequivocabilmente ad una impiccagione che si è svolta nel seguente modo: la signora Meinhof è salita sulla sedia che
aveva disposto sotto la finestra su un materasso; ha fatto passare la striscia ritagliata dall’asciugamano attraverso le maglie del reticolato della finestra, poi, dopo essersi addossata al muro sotto la finestra, ha annodato due volte la striscia sotto al mento e ha lasciato la sedia, facendo un passo nel vuoto. Pendendo liberamente al reticolato della finestra, ha presto perso conoscenza ed è morta per asfissia.”
Ecco alcune osservazioni in merito a questo rapporto:
– la Meinhof non poteva fare questo passo nel vuoto, avendo davanti lo schienale della sedia che glielo impediva
– non pendeva liberamente dal reticolato della finestra perché il piede sinistro era poggiato sulla sedia
Problematica dell’impiccagione:
Abbiamo dall’inizio insistito sul fatto che le circostanze dell’impiccagione sono state falsificate accorciando, di 29 cm, il cappio nel quale era appesa. In realtà è stata messa in un cappio di 80-82 cm che aveva quindi un diametro di 26 cm. Chiunque è in grado di verificare che si può facilmente passare la testa attraverso un cappio di questo diametro e farla uscire senza difficoltà. Per appendersi con un cappio di questo tipo bisogna inclinare la testa leggermente in avanti, appoggiare il mento sul petto, altrimenti il cappio non può sostenere il peso del corpo.
Nei casi di incoscienza, i movimenti dipendenti dalla volontà non sono più possibili, il tono muscolare a poco a poco sparisce e la persona, appesa in questo m odo, cade dal cappio, poiché il peso del corpo tende verso la testa. La testa viene tirata indietro e allo stesso modo, il cappio solleva il mento e la testa. La stretta del cappio intorno al corpo non è più possibile. Il cappio, in queste condizioni, non lascia il segno di strangolamento che aveva la Meinhof, poiché comprime solo la parte anteriore del collo e non i lati, e passa dietro la testa. Questo cappio probabilmente non potrebbe nemmeno garantire la compressione dei vasi sanguigni. 
Del tutto diversa è la situazione con un cappio della circonferenza di 51 cm. La testa non può passarvi, né uscire cadendo. Il punto in cui la corda è annodata non è più allora dietro la testa, ma dietro al collo e, effettivamente, provoca un profondo segno di strangolamento. Ed è questa l’impressione che, accorciando la circonferenza del cappio, si è voluta dare agli esperti. Tutto questo non corrisponde ai fatti.
L’impiccagione, in un cappio così largo (80-82 cm) è un modo poco appropriato per impiccare una persona r improprio per appendere un corpo e mantenerlo per ore in questa posizione. In base alle stesse leggi fisiche, un cadavere cadrebbe fuori dal cappio, come l’uomo ancora in vita che ha perduto conoscenza. Si può appendere un cadavere in un cappio troppo largo, solo se si approfitta della rigidità cadaverica per mettere la testa in una posizione fissa, che non permetta più al cappio di scivolare.
Nel caso di Ulrike Meinhof, coloro che l’hanno appesa, hanno dovuto avere dubbi rispetto alla stabilità dell’impiccagione. Comunque hanno rafforzato questa stabilità, appoggiando il piede sinistro sulla sedia davanti a lei. Quando il corpo è rigido, la gamba tesa ha lo steso effetto di un bastone di legno sul quale si potrebbe appoggiare un peso. In questo modo la pesantezza del corpo è stata alleggerita sostenendolo in parte. Per maggiore sicurezza, le spalle sono state portate in avanti perché facessero da contrappeso. La gamba sinistra è stata appoggiata sulla sedia proprio al momento della rigidità cadaverica. E’ riconoscibile dal fatto che il piede è rimasto nella sua posizione normale. Se il piede, immediatamente dopo la morte, avesse avuto questa posizione, l’avrebbe perduta al momento del rilasciamento del tono muscolare e questa posizione rilasciata sarebbe stata fissata dalla rigidità cadaverica. Non è questo il nostro caso. […]
Per quanto riguarda lo stesso strumento di strangolamento, sembra evidente che una corda di tale lunghezza non poteva essere ricavata da una striscia tagliata da un asciugamano lungo 75 cm, senza ricorrere ad una cucitura.
9 Maggio, Ulrike Meinhof. 1° parte della commissione internazionale d’inchiesta sulla sua morte
Il 9 maggio ricorre (oltre all’anniversario dell’assassinio di Peppino Impastato) l’anniversario dell’assassinio di Ulrike Meinhof, nel carcere di Stammheim. Già in passato questo blog si è occupato di questa figura degli anni ’70 tedeschi, con alcuni stralci presi dalle sue lettere e dai suoi scritti.
E’ il caso, invece, da questo momento in poi (la “serie” sarà un po’ lunga) di mettere in rete un po’ di materiale che dimostra l’assassinio che c’è dietro la sua morte e quella successiva e simultanea di altri 3 prigionieri della stessa formazione , la R.A.F. anche conosciuta come Banda Baader-Meinhof. , a partire dal Rapporto della Commissione internazionale d’inchiesta sulla morte di Ulrike Meinhof. Fu ritrovata impiccata, con ancora un piede poggiato sulla sedia, morta da ore…ma come vedremo successivamente, l’autopsia dimostra più che chiaramente come non si sia trattato di suicidio…
, a partire dal Rapporto della Commissione internazionale d’inchiesta sulla morte di Ulrike Meinhof. Fu ritrovata impiccata, con ancora un piede poggiato sulla sedia, morta da ore…ma come vedremo successivamente, l’autopsia dimostra più che chiaramente come non si sia trattato di suicidio…
Prima di affrontare la parte tecnica dell’inchiesta mettiamo la sua dichiarazione d’intenti e una parte della prima inchiesta sulla tortura ‘pulita’ applicata costantemente su tutti i detenuti politici tedeschi, e non solo.
Di tortura non si può smettere di parlare, di indagare, di archiviare e diffondere…
« …anche i giudici che condannavano ai roghi le streghe e i maghi del secolo passato, credevano di purgare la terra di più fieri nemici… » (Pietro Verri –Osservazioni Sulla tortura- 1776)
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE D’INCHIESTA SULLA MORTE DI ULRIKE MEINHOF
A conclusione dei suoi lavori, la Commissione internazionale d’inchiesta Sulla morte di Ulrike Meinhof ha preso atto del rapporto formulato dalla segreteria.Senza far propria ogni singola formulazione, la Commissione sottolinea, tuttavia, che si tratta di un lavoro serio, realizzato grazie alla collaborazione di periti qualificati, che merita di essere preso in considerazione e ampiamente diffuso.
Per riassumere i pareri sui quali i suoi membri hanno trovato un accordo, la Commissione ha constatato :
– che Ulrike Meinhof è stata sottoposta, a più riprese e per lunghi periodi, a condizioni di detenzione che si è costretti a qualificare « tortura ». Si tratta di quel tipo di tortura chiamata isolamento sociale e privazione sensoriale, comunemente applicanto nella Repubblica Federale Tedesca a numerosi prigionieri politici e anche a detenuti comuni ;
– che la tesi delle autorità statali, secondo la quale Ulrike Meinhof si sarebbe suicidata per impiccagione non è provata e che i risultati della Commissione tendono a dimostrare che Ulrike Meinhof non potuto impiccarsi da sola ;
– che i risultati dell’inchiesta suggeriscono che Ulrike Meinhof era morta quando è stata appesa e che vi sono indizi inquietanti d’intervento di terzi in relazione a questa morte. eorge
La Commissione non può esprimersi con certezza sulle circostanze della morte di Ulrike Meinhof. Tuttavia, il fatto che al di fuori del personale della prigione i servizi segreti avessero accesso alle celle del 7° piano attraverso un passaggio distinto e segreto autorizza ogni sospetto. I risultati dell’inchiesta, qui presentati dalla Commissione, rendono più urgente la nécessita di costituire una commissione internazionale d’inchiesta sui morti di Stammheim e di Stadelheim.
 La Commissione ringrazia la sorella di Ulrike Meinhof che ha messo a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, nonché tutte le persone ed organizzazioni che hanno facilitato il lavoro intrapreso, appoggiandolo e contribuendo al suo finanziamento. Il lavoro è stato finanziato esclusivamente da questi contributi e senza di essi non sarebbe stato possibile realizzarlo. La Commissione ringrazia anche tutte le persone che si sono impegnate nella pubblicazione del presente rapporto.
La Commissione ringrazia la sorella di Ulrike Meinhof che ha messo a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, nonché tutte le persone ed organizzazioni che hanno facilitato il lavoro intrapreso, appoggiandolo e contribuendo al suo finanziamento. Il lavoro è stato finanziato esclusivamente da questi contributi e senza di essi non sarebbe stato possibile realizzarlo. La Commissione ringrazia anche tutte le persone che si sono impegnate nella pubblicazione del presente rapporto.
Parigi, 15 dicembre 1978
Michelle Beauvillard, avvocato, Parigi – Claude Bourdet, giornalista, Parigi – Robert Davezies, giornalista, Parigi – Georges Casalis, teologo, Parigi – Joachim Israel, sociologo, Copenhagen – Panayotis Kanelakis, avvocato, Atene – Henrik Kaufholz, giornalista, Aarhus (Danimarca) – John McGuffin, scrittore, Belfast – Hans Joachim Meyer, neuropsichiatra, R.F.T. – Jeane-Pierre Vigier, fisico, Parigi
[stralci del Rapporto della Commissione]
1. CONDIZIONI DI DETENZIONE
Dopo l’arresto di Ingrid Schbert e di Monika Berberich, nell’ottobre 1970, i prigionieri della R.A.F. sono sottoposti ad un regolamento di detenzione, calcolato fin nei minimi dettagli : il totale isolamento e l’isolamento in Piccoli gruppi.
Rapporto di Jorgen Pauli Jensen, psicologo, Danimarca :
All’indomani dell’arresto, Ulrike Meinhof fu tenuta prigioniera, in condizioni di assoluto isolamento, nel « braccio della morte » del carcere di Colonia-Ossendorf [era in un braccio vuoto, con 6 celle vuote e lei era al centro di queste]. Questo primo periodo di isolamento totale (poi ne seguiranno altri) è durato 237 giorni.
Metodo ed effetto della tortura dell’isolamento sono in diretta interdipendenza : il metodo consiste nell’isolamento assoluto da ogni contatto sociale e nella soppressione di impressioni sensoriali differenziate, che sono una condizione necessaria al funzionamento dell’organismo umano. Rinchiudendo i detenuti in una camera silens, una cella perfettamente isolata, dunque senza alcun rumore ( o una cella nella quale si ascolta un suono incessante), buia di giorno (o dipinta di bianco e illuminata al neon giorno e notte), con ridotte possibilità di movimento e aria viziata, si tenta, in qualche modo, di esasperarne il bisogno umano di contatti e impressioni sensoriali, vale a dire di comunicazione umana. Le ricerche di psicologia sperimentale e, disgraziatamente, anche l’esperienza diretta, ci hanno insegnato con certezza che tali condizioni possono corrodere e annientare, nel giro di breve tempo, gli esseri umani fisicamente e psichicamente
A livello fisico, la funzione vegetativa è distrutta poco a poco (modificazione patologica del bisogno di dirmire e urinare, della famé, della sete, nonchè mal di testa e perdita di peso). A livello psichico si sviluppa instabilità emotiva (angoscia improvisa o collera). Sul piano psichico e su quello della  conoscenza si sviluppa entro brève tempo, un disorientamento nel tempo e nello spazio ; difficoltà di concentrazione, difficoltà nel definire un pensiero , perdita della memoria, déficit del linguaggio e della comprensione, allucinazioni ecc.
conoscenza si sviluppa entro brève tempo, un disorientamento nel tempo e nello spazio ; difficoltà di concentrazione, difficoltà nel definire un pensiero , perdita della memoria, déficit del linguaggio e della comprensione, allucinazioni ecc.
Tuttavia, non sempre questo progetto raggiunge il suo scopo : esistono donne e uomini che, malgrado la tortura dell’isolamento, conservano la loro identità politica.
Dal 1972 vengono applicati metodi speciali contro i prigionieri politici nelle carceri della R.F.T.
– isolamento sistematico dei prigionieri in rapporto agli altri ; esclusione da tutte le attività comuni, dalla vita normale della prigione ; divieto di comunicare con altri prigionieri, ogni tentativo di ignorare tale divieto viene punito con la detenzione nelle celle di punizione ;
– l’applicazione di inferriate speciali dinanzi allé finestre delle celle allo scopo di rendere impossibile la vista sull’esterno [bocche di lupo]
– solo un’ora d’aria, soli, con manette ai polsi
– divieto di ricevere visite e lettere, tranne che da familiari
– tutte le visite sono sorvegliate dalla polizia politica, che registra tutta la conversazione e l’utilizza, all’occorrenza, nel processo
– censura totale di libri e giornali
« …Che fare ? E’ chiaro, sporgere denuncia per lesioni fisiche. Allora, dai ! L’ho già detto centinaia di volte : psichiatra e –ormai l’ho capito- otorinolaringoiatra che spieghino, finalmente, scientificamente, come il ‘silenzio’ abbia gli stessi effetti degli elettrochoc, provochi lo stesso tipo di lesioni, di devastazioni nell’organo dell’equilibrio e nel cervello… » Ulrike Meinhof ai suoi avvocati, dal braccio della morte, febbraio 1974
Ad Edoardo Arnaldi
EDOARDO ARNALDI
-Nasce a Genova il 27 novembre 1925
– dal 1949 lavora come avvocato civilista, nel ’69 diventa penalista
-milita in Soccorso Rosso
– muore suicida a Genova il 19 aprile 1980, quando i carabinieri vanno a casa sua per arrestarlo. Nelle stesse ore a Milano arrestavano un altro avvocato, Sergio Spezzali, per « connivenza » con le Brigate Rosse.
Vincenzo Guagliardo : Testimonianza del Progetto Memoria, Carcere di Opera 1994
Subito dopo l’esecuzione di via Fracchia, le forze dell’ordine andarono ad arrestare l’avvocato Edoardo Arnaldi poichè Sulla base delle indicazioni di Patrizio Peci, egli ormai non poteva che essere un brigatista.
La nascita del « pentito » moderno fonda improvvisamente una nuova etica : la comunità non è piu’ orgogliosa, (per se stessa) di avere piccole « zone franche » dove il medico, o l’avvocato devono restare impuniti e devono incontrare il fuorilegge in pericolo per la propria vita o libertà. I delicati contrappesi di una cultura costruitasi in secoli spariscano in un baleno. Le definizioni usuali che ne conseguivano per l’identità e la coscienza del singolo sbiadiscono, le parole dello storico o del filosofo vengono sostituite da quelle del giudice e del poliziotto, le quali stritolano, riducono, annullano ogni differenza nella semplice e immensa visione del complotto.
Devo qui confessare che Edoardo accettò, per esempio, di incontrarsi con me, mentre ero brigatista e latitante, perchè considerava ciò un suo dovere nella sua … antiquata morale. I suoi modi, la sua voce, i suoi ragionamenti avevano una gentilezza d’altri tempi. Neppure io, all’epoca, ero cosciente dei cambiamenti avvenuti. Mi era parso dunque giusto incontrare quest’uomo onde dargli un aiuto économico per sostenere i suoi viaggi appresso ai compagni in carcere e ai loro casi. Non vedevo grandi rischi per lui.
Quando le forze dell’ordine arrivarono a casa sua per un motivo del genere, Edoardo chiese di andare un attimo in un’altra stanza, e qui si sparò un colpo di pistola e morì. Mi viene in mente la filosofia di Anders, secondo la quale l’essere umano risulta essere ormai un prodotto antiquato rispetto a ciò che ha costruito, rispetto ai suoi stessi prodotti. E a volte si ribella come può, aggiungo.
Va detto che Edoardo s’era rovinato economicamente per noi. Aveva accettato di difendere i brigatisti insieme a Sergio Spazzali, e si era ritrovato umanamente sempre più solo e senza più tanti clienti. Ma tutto questo non è niente perchè dei suoi beni svenduti penso che se ne fregasse. Il fatto è che stava pure male fisicamente : era diabetico e affetto dal morbo di Bürger, ragion per cui, quando lo rividi da clandestino, zoppicava vistosamente.
Provo ora ad interpretare il suo gesto anche se mi rendo conto dell’arroganza e dell’insufficienza di un tale tentativo di fronte alla complessità dell’essere umano che si suicida.
Edoardo era stato un partigiano, uno dei tanti che erano rimasti delusi dei risultati ottenuti dalla Resistenza. Perciò sviluppò verso i brigatisti dei complessi rapporti « paterni ». Disse in un’arringa che avevamo dovuto fare i conti con i limiti di quanto aveva ottenuto la lotta della sua generazione.
Perciò essendo ancora noi dei « ragazzi con il sangue nelle vene », avevamo dovuto cercare a modo nostro e come potevamo di finire ciò che lui e quelli come lui avevano provato a cominciare. Oserei dire che ci vedeva a errare da limiti suoi più che nostri… Penso che in questo tipo di affermazioni ci sia un ingiusto « complesso di colpa » verso se stesso, ma al tempo stesso e al di là di questo, un profondo senso storico, una coscienza della inevitabile e necessaria contraddittorietà dell’atto umano volto alla liberazione. Il limite viene individuato per rafforzare la solidarietà invece che per giudicare ; per non rinunciare al cammino.
Certo è che una persona come questa, trovatasi di fronte all’idea di finire in galera in quelle condizioni, avrà pensato più o meno : « Nelle mie condizioni fisiche finire in carcere significherà dover accettare umiliazioni per ogni cosa ».
Inoltre, c’era in lui l’uomo deluso dagli esiti della Resistenza che ora doveva fare i conti con un arresto dovuto a tradimento fondato -per giunta – su una malafede interpretativa impensabile fino a pochi anni prima. E c’era proprio uno dei suoi « figli » ideali che per cavarsela lo denunciava così. Qui l’uomo antico che era in lui si sarà ribellato : il vecchio amico dichiarato, ma non identico ai giovani brigatisti, non poteva accettare di essere così presentato e denunciato proprio da un brigatista delatore. E allora un uomo che sta male è orgoglioso, non ci sta ad accettare giorni umilianti per le sue condizioni fisiche e per una ragione del genere : un secondo tradimento dei suoi sogni. Allora va nell’altra stanza e si spara.
In un nuovo contesto, con altri pensieri più ricchi d’esperienza, bisognerà riconquistare le caratteristiche dell’ « uomo antiquato rispetto al suo prodotto », farlo rivivere.
40 anni dalla rivolta di Battipaglia
Il 9 aprile del 1969 si ebbero gravi incidenti a Battipaglia, al diffondersi della notizia della decisione di chiudere due aziende storiche come la  manifattura dei tabacchi e lo zuccherificio. Per la città è una tragedia, dal momento che metà della popolazione vive su queste due fabbriche, sulle coltivazioni e sull’indotto. La chiusura di queste aziende significherebbe quindi disoccupazione e miseria. Vengono indette manifestazioni di protesta e cortei, e lo scontro con le forze dell’ordine è drammatico. L’assedio dei dimostranti diventa un attacco, e la polizia perde la testa e spara sulla folla uccidendo due persone: Carmine Citro, operaio tipografo di 19 anni, e Teresa Ricciardi, insegnante in una scuola media di Eboli, che viene raggiunta al petto da una pallottola mentre è affacciata alla finestra di casa sua. Le cariche della polizia si susseguono per tutto il pomeriggio, ed in tutto si contano 200 feriti (di cui 100 da arma da fuoco) fra i dimostranti, e 100 tra i membri delle forze dell’ordine.
manifattura dei tabacchi e lo zuccherificio. Per la città è una tragedia, dal momento che metà della popolazione vive su queste due fabbriche, sulle coltivazioni e sull’indotto. La chiusura di queste aziende significherebbe quindi disoccupazione e miseria. Vengono indette manifestazioni di protesta e cortei, e lo scontro con le forze dell’ordine è drammatico. L’assedio dei dimostranti diventa un attacco, e la polizia perde la testa e spara sulla folla uccidendo due persone: Carmine Citro, operaio tipografo di 19 anni, e Teresa Ricciardi, insegnante in una scuola media di Eboli, che viene raggiunta al petto da una pallottola mentre è affacciata alla finestra di casa sua. Le cariche della polizia si susseguono per tutto il pomeriggio, ed in tutto si contano 200 feriti (di cui 100 da arma da fuoco) fra i dimostranti, e 100 tra i membri delle forze dell’ordine.
Il giorno seguente la gente scende in piazza inferocita, blocca ferrovie, strade e autostrade, dalle 17  alle 22 la città è in mano a tremila dimostranti, che devastano la stazione, incendiano il municipio, danno fuoco a duecento auto e poi assediano il commissariato di polizia e la caserma dei carabinieri. A Roma arriva invece la notizia che ci sono stati cinquanta morti e, temendo una insurrezione generale, viene subito trovato un accordo per la riapertura delle due aziende.
alle 22 la città è in mano a tremila dimostranti, che devastano la stazione, incendiano il municipio, danno fuoco a duecento auto e poi assediano il commissariato di polizia e la caserma dei carabinieri. A Roma arriva invece la notizia che ci sono stati cinquanta morti e, temendo una insurrezione generale, viene subito trovato un accordo per la riapertura delle due aziende.
Battipaglia nove aprile
tutti in piazza sono scesi
rossi, bianchi, d’ogni colore
per difendere il lavoro.
Come sempre li padroni
la sbirraglia hanno mandato
con i mitra caricati
come ad Avola e Viareggio.
Chista è storia di oggi
storia di povera gente
ammazzata come cani
per difendere lu pani.
Nella terra di Campania
dove Cristo s’è fermato
scorre il sangue nella strada
della gente più sfruttata.
Carmine si chiamava
lu guaglione assassinata
e Teresa la maestra
che lu core ci hanno squarciatu.
E la storia si ripete
come sempre c’è l’inchiesta
gli assassini restan fuori
e i poveri in galera.
A Mario Salvi, ucciso da un agente della polizia penitenziaria
7 Aprile 1976 __Via degli Specchi, Roma__
Mario Salvi viene ucciso con un colpo di pistola alla nuca, dopo aver lanciato alcune molotov contro un portone laterale del Ministero di Grazia e Giustizia, dall’agente carcerario in borghese Domenico Velluto.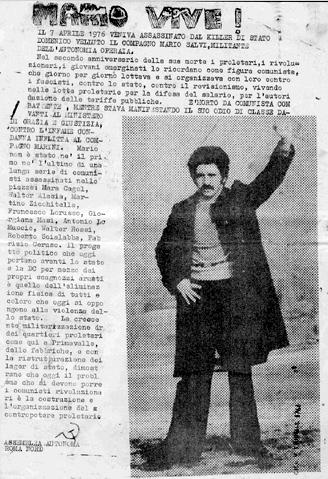 L’8 aprile, i Comitati Autonomi Operai di Roma, nel corso di una manifestazione di protesta, diffondono un documento sulla morte di Mario in cui, tra l’altro si legge : “L’agente Velluto con la pistola in pugno ha percorso centinaia di metri lungo le strade che portano a Campo de’ Fiori, alla ricerca di una vittima a cui sparare a freddo con tutta calma. Infatti quando ha sparato, nessuno stava scappando: il nostro compagno è stato freddato mentre camminava…”
L’8 aprile, i Comitati Autonomi Operai di Roma, nel corso di una manifestazione di protesta, diffondono un documento sulla morte di Mario in cui, tra l’altro si legge : “L’agente Velluto con la pistola in pugno ha percorso centinaia di metri lungo le strade che portano a Campo de’ Fiori, alla ricerca di una vittima a cui sparare a freddo con tutta calma. Infatti quando ha sparato, nessuno stava scappando: il nostro compagno è stato freddato mentre camminava…”
Il 15 aprile 1976 l’agente Velluto viene arrestato per omicidio preterintenzionale. Il 7 luglio il tribunale lo assolve ” per aver fatto uso legittimo delle armi”.
In via degli Specchi, nel quartiere di Campo de’ Fiori, all’altezza del numero civico 15 è affissa una lapide di commemorazione: “Qui è caduto Mario Salvi comunista rivoluzionario di 21 anni ucciso dal piombo di stato mentre manifestava il suo odio di classe contro la giustizia borghese. Il suo ricordo vive nelle lotte degli sfruttati. 7 settembre 1977.”
Testimonianza al Progetto Memoria. Roma, 1955 :
“Il mio ricordo di Mario Salvi è legato alla nostra comune militanza nel Comitato Proletario di Primavalle. […] Il “battesimo di fuoco” per lui, fu veramente di fuoco! La Sip staccava il telefono a chi praticava l’autoriduzione, si organizzarono come risposta una serie di sabotaggi alle cabine di derivazionei telefoniche nei quartieri borghesi, lascinado così per un po’ di tempo senza telefono gli abitanti dei Parioli e degli altri quartieri-bene della città. Io e Mario ci recammo con una vespetta all’ora stabilita al nostro obiettivo, dovevamo aprire l’armadietto metallico e sistemarvi un ordigno incendiario. Un congegno chimico doveva ritardare l’esplosione; l’acido solforico entrando in contatto  con la miscela di clorato di potassio e zucchero avrebbe innescato l’incendio della tanica di benzina; ma la qualità del profilattico che separava le fiale dell’acido dalla miscela era evidentemente scarsa, così la sua corrosione non avvenne, come preventivato, dopo qualche minuto, ma fu immediata. La fiammata illuminò la strada, saltammo sulla nostra vespetta modificata e schizzammo via a tutto gas nella notte. Le nostre capacità di artificieri ci lasciarono perplessi, ma la nostra ‘guida veloce’ ci confortò. […]”
con la miscela di clorato di potassio e zucchero avrebbe innescato l’incendio della tanica di benzina; ma la qualità del profilattico che separava le fiale dell’acido dalla miscela era evidentemente scarsa, così la sua corrosione non avvenne, come preventivato, dopo qualche minuto, ma fu immediata. La fiammata illuminò la strada, saltammo sulla nostra vespetta modificata e schizzammo via a tutto gas nella notte. Le nostre capacità di artificieri ci lasciarono perplessi, ma la nostra ‘guida veloce’ ci confortò. […]”
Mario era un giovane che, come altre migliaia di giovani e meno giovani, in quegli anni aveva fatto della militanza politica e dell’ impegno sociale una scelta di vita. Militanza ed impegno che fondamentalmente significavano solidarietà ( in quegli anni veniva definita solidarietà di classe) con gli sfruttati e con i più deboli.
7 APRILE 1979: processo all’Autonomia
7 aprile 1979.
 Stampa e tv danno notizia della maxi-retata che da poche ore ha portato in galera il presunto vertice delle Brigate Rosse. Gli arresti, avvenuti su tutto il territorio nazionale, sono stati ordinati dal sostituto procuratore di Padova Pietro Calogero.
Stampa e tv danno notizia della maxi-retata che da poche ore ha portato in galera il presunto vertice delle Brigate Rosse. Gli arresti, avvenuti su tutto il territorio nazionale, sono stati ordinati dal sostituto procuratore di Padova Pietro Calogero.
Quasi tutti gli accusati sono intellettuali: docenti universitari, scrittori, giornalisti e leaders dei diversi movimenti post-’68. Tra i più noti vi sono: Antonio “Toni” Negri, docente di Dottrina dello Stato all’università di Padova, indicato come capo e ispiratore di tutta la galassia sovversiva italiana; Nanni Balestrini (latitante), poeta e scrittore, già nel Gruppo 63 e poi autore del romanzo-culto “Vogliamo tutto”; Franco Piperno (latitante), docente di fisica all’università di Cosenza; Oreste Scalzone, insieme a Piperno leader storico del ‘68 romano; Luciano Ferrari Bravo, Guido Bianchini,
Sandro Serafini e Alisa del Re, tutti assistenti di Negri all’università di Padova; Giuseppe “Pino” Nicotri, giornalista del “Mattino” di Padova, di “Repubblica” e de “L’Espresso” (in passato si è occupato della controinformazione su Piazza Fontana, e le sue scoperte sugli spostamenti di Franco Freda sono state preziose per le indagini di Calogero); Emilio Vesce, redattore delle riviste “Rosso” e “Controinformazione. L’elenco prosegue con diversi militanti dell’Autonomia Operaia ed ex-membri del gruppo Potere Operaio, scioltosi nel 1973. Secondo gli inquirenti, Potere Operaio non si sarebbe sciolto, piuttosto sarebbe divenuto un’organizzazione clandestina, una vera e propria “cupola” della sovversione. Inoltre, malgrado l’evidenza di insanabili contrasti teorici e politici, Autonomia Operaia e Brigate Rosse sono ritenute la stessa cosa, o meglio: la “illegalità di massa” propugnata dalla prima non sarebbe che il mare magnum in cui sguazza l’avanguardia clandestina rappresentata dalle seconde. Per alcuni degli arrestati vale solo la seconda parte del mandato, cioè l’accusa di associazione sovversiva. Al contrario, su Negri e alcuni altri sta per rovesciarsi una valanga di fantasiosi mandati di cattura per gli episodi più diversi. Nei giorni successivi il processo si estende ai redattori della rivista romana “Metropoli”, su cui scrivevano anche Scalzone e Piperno. I nuovi inquisiti sono Libero Maesano, Lucio Castellano e Paolo Virno. Anche loro apparterrebbero in blocco all’organizzazione eversiva “costituita in più bande armate variamente denominate”, per il semplice motivo di… aver scritto su “Metropoli”. Pleonasmi a non finire. Davvero curiosa questa “guerra civile” combattuta a colpi di saggi, editoriali, recensioni… e anche fumetti: su “Metropoli” è comparsa una drammatizzazione a fumetti del caso Moro. Secondo gli inquirenti, alcune vignette contengono l’esatta riproduzione della “prigione del popolo” in cui era rinchiuso Moro. Poi si verrà a sapere che l’autore si è ispirato a un fotoromanzo di “Grand Hotel”. Ormai sappiamo tutti che Toni Negri non era il capo delle Brigate Rosse, né il telefonista dei rapitori di Moro, né l’assassino di Carlo Saronio. Eppure un giudice, su basi così palesemente assurde, imbastì nel 1979 il processo simbolo del periodo dell’ “emergenza”, rimasto noto come “il caso 7 aprile”. Vi furono coinvolti prima una ventina di imputati, quasi tutti docenti e ricercatori della facoltà di Scienze Politiche di Padova, poi divenuti oltre un centinaio. Molti furono incarcerati, altri costretti all’esilio, uno (“Pedro”) perse la vita, ucciso dalle forze dell’ordine mentre era armato di un semplice ombrello. Inutile dire che gli assassini di Pedro rimasero impuniti, e che il magistrato che gestì il processo ha tranquillamente fatto carriera.
Poi si verrà a sapere che l’autore si è ispirato a un fotoromanzo di “Grand Hotel”. Ormai sappiamo tutti che Toni Negri non era il capo delle Brigate Rosse, né il telefonista dei rapitori di Moro, né l’assassino di Carlo Saronio. Eppure un giudice, su basi così palesemente assurde, imbastì nel 1979 il processo simbolo del periodo dell’ “emergenza”, rimasto noto come “il caso 7 aprile”. Vi furono coinvolti prima una ventina di imputati, quasi tutti docenti e ricercatori della facoltà di Scienze Politiche di Padova, poi divenuti oltre un centinaio. Molti furono incarcerati, altri costretti all’esilio, uno (“Pedro”) perse la vita, ucciso dalle forze dell’ordine mentre era armato di un semplice ombrello. Inutile dire che gli assassini di Pedro rimasero impuniti, e che il magistrato che gestì il processo ha tranquillamente fatto carriera.  L’impianto dell’inchiesta crollò solo grazie alle confessioni di Patrizio Peci, che dimostrarono come Negri, Piperno, Scalzone e gli altri del 7 aprile, con le Brigate Rosse, non avessero nulla a che spartire. Il teorema Calogero è rimasta la più impressionante montatura mediatico-giudiziaria dell’Italia repubblicana.
L’impianto dell’inchiesta crollò solo grazie alle confessioni di Patrizio Peci, che dimostrarono come Negri, Piperno, Scalzone e gli altri del 7 aprile, con le Brigate Rosse, non avessero nulla a che spartire. Il teorema Calogero è rimasta la più impressionante montatura mediatico-giudiziaria dell’Italia repubblicana.
A trent’anni da quel giorno, martedì 7 aprile 2009 Filorosso organizza un’iniziativa dal titolo “Una storia da ricordare” con alcuni dei protagonisti, loro malgrado di quella vicenda: Franco Piperno, Oreste Scalzone (in collegamento da Parigi) e Francesco Febbraio, che in quel periodo era studente e attivista politico all’Università di Padova.
La discussione si terrà alle ore 17:30 presso il Capannone del Filorosso nell’edificio Polifunzionale dell’Unical di Cosenza. L’iniziativa è rivolta agli studenti universitari che nel ’79 non erano ancora nati e che avranno l’occasione di ascoltare una pagina di storia raccontata dalla voce viva di chi l’ha vissuta sulla sua pelle.
QUI UN BRANO DI FORTINI SUL 7 APRILE
30 marzo: la Giornata della terra, libera e palestinese
Il 30 marzo di ogni anno la Palestina e il suo popolo celebrano e festeggiano la giornata della terra.
 Giornata per ricordare tutti coloro che sono stati uccisi nel difendere il diritto di vivere nella propria terra per i palestinesi e per lottare e portare avanti la resistenza contro il continuo furto di terre e il trasferimento forzato della popolazione araba. Per dire no allo stato d’assedio, al muro dell’Apartheid, alla perenne perpetrazione di crimini contro l’umanità ai danni di civili arabi.
Giornata per ricordare tutti coloro che sono stati uccisi nel difendere il diritto di vivere nella propria terra per i palestinesi e per lottare e portare avanti la resistenza contro il continuo furto di terre e il trasferimento forzato della popolazione araba. Per dire no allo stato d’assedio, al muro dell’Apartheid, alla perenne perpetrazione di crimini contro l’umanità ai danni di civili arabi.
Il 30 marzo del 1978 sette giovani palestinesi, cittadini dello Stato d’Israele, furono uccisi dal piombo dello Tsahal mentre manifestavano pacificamente contro l’esproprio di terre in Galilea, nel Neghev e nel triangolo
O scolari di Gaza
insegnateci
un po’ di ciò
che noi abbiamo dimenticato
Insegnateci
a essere uomini
da noi gli uomini
sono diventati pasta morbida
Insegnateci
come i sassi
tra le mani dei bambini
diventano diamanti preziosi
Insegnateci
come fa la bicicletta di un bambino a diventare una mina
e il nastro di seta,
un’imboscata
Come la bottiglia del latte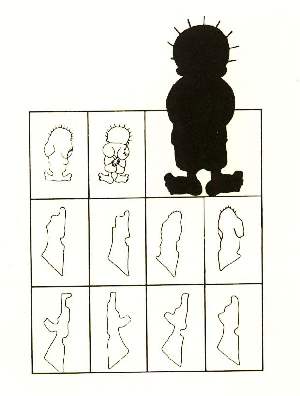
se non la imprigionano
diventa un coltello.
O scolari di Gaza
non date retta
alle nostre trasmissioni
non ascoltateci
colpite
colpite
con tutta la vostra forza
occupatevi del vostro lavoro
e non chiedete a noi
Noi siamo la gente dei conti
dell’addizione
e della sottrazione
conducete le vostre guerre
e lasciateci
Noi siamo i disertori
che hanno abbandonato l’esercito
prendete allora le vostre corde
e impiccateci
Noi siam morti
che non hanno una tomba
e orfani
che non hanno occhi
che restano chiusi nelle loro tane
e vi abbiamo chiesto
di combattere il drago
Siamo diventati più piccoli davanti a voi
di mille secoli
E voi, in un mese
più grandi di secoli
O scolari di Gaza
non fate ritorno
a ciò che abbiamo scritto e non leggeteci
Noi siamo i vostri padri
non somigliateci, quindi
noi siamo i vostri idoli
non adorateci
Noi pratichiamo
la menzogna politica
e la repressione
costruiamo tombe
e carceri
liberateci
dai vincoli della paura che è dentro di noi
cacciate via
l’oppio che c’è nelle nostre teste
Insegnateci
l’arte di aggrapparsi alla terra
non abbandonate
il Messia sofferente
Piccoli amati
la pace su di voi
che Dio possa fare del vostro giorno
un gelsomino
Dalle fessure della terra in rovina
siete sorti
e avete seminato nelle nostre ferite
la rosa selvatica
Questa è la rivoluzione dei quaderni
e dell’inchiostro
diventate sulle labbra
melodie
fate piovere su di noi
valore e fierezza
Lavateci via la nostra bruttezza
lavateci
non abbiate paura del Faraone
né degli incantesimi di Mosè
e preparatevi a raccogliere le olive
Davvero questa epoca ebraica
un giorno si dissolverà
se ne possediamo la certezza
Folli di Gaza
mille volte benvenuti
i folli
se ci libereranno
L’era della ragione politica
se ne è andata da tempo
insegnateci la follia
Il lavoro è sfruttamento
“Cioè io avevo fatto tutti i lavori nella mia vita. L’operaio edile nelle carovane di facchini il lavapiatti in un ristorante avevo fatto il bracciante e lo studente che è anche quello un lavoro. Avevo lavorato all’Alemagna, alla Magneti Marelli all’Ideal Standard. E adesso ero stato alla Fiat a questa  Fiat che era un mito per tutti i soldi che lì si guadagnavano. E io veramente avevo capito una cosa. Che col lavoro uno può soltanto vivere. Ma vivere male da operaio sfruttato. Gli viene portato via il tempo libero della sua giornata tutta la sua energia. Deve mangiare male. Viene costretto a alzarsi a delle ore impossibili secondo in che reparto sta o che lavoro fa. Avevo capito che il lavoro è sfruttamento e basta.
Fiat che era un mito per tutti i soldi che lì si guadagnavano. E io veramente avevo capito una cosa. Che col lavoro uno può soltanto vivere. Ma vivere male da operaio sfruttato. Gli viene portato via il tempo libero della sua giornata tutta la sua energia. Deve mangiare male. Viene costretto a alzarsi a delle ore impossibili secondo in che reparto sta o che lavoro fa. Avevo capito che il lavoro è sfruttamento e basta.
Adesso finiva anche quel mito della Fiat. Cioè avevo visto che il lavoro Fiat era un lavoro come quello edile come il lavapiatti. E avevo scoperto che non c’era nessuna differenza tra l’edile e il metalmeccanico e il facchino tra il facchino e lo studente. Le regole che usavano i professori in quella scuola professionale e le regole usate dai capi reparto in tutte le fabbriche dove ero stato erano la stessa cosa. E allora si poneva un grosso problema per me. Cioè pensavo che faccio adesso. Cosa faccio cosa devo fare.
E allora si poneva un grosso problema per me. Cioè pensavo che faccio adesso. Cosa faccio cosa devo fare.
Non avevo mai rubato ancora non avevo mai avuto una pistola. Non avevo mai avuto amicizie con gente così detta della malavita. Che almeno avrei avuto uno sbocco da darmi. Da dare sia alla mia incazzatura alla mia insoddisfazione e sia ai miei bisogni alla mia vita materiale. Non ero né un medico né un avvocato o un professionista. Per cui non è che dicevo mo’ mi metto a fare il rapinatore o il professionista. Insomma veramente non ero niente non potevo fare niente.
Eppure c’avevo sta voglia di vivere di fare qualcosa. Perché ero giovane e sto sangue mi pulsava nelle vene. La pressione era abbastanza alta insomma. Volevo fare qualcosa. Ero disposto a fare qualsiasi cosa. Ma è chiaro che qualsiasi cosa per me significava non fare più l’operaio. Questa parola era ormai abbastanza sputtanata per me. Non significava più niente ormai per me. Significava continuare ancora a fare la vita di merda che avevo fatto finora insomma. “
TRATTO DA “VOGLIAMO TUTTO” di Nanni Balestrini
Feltrinelli 1971
NON DIMENTICARE MAI
Nemesi
Non dimenticare
Non dimenticare mai
Non devi dimenticare
Alekos Panagulis
Carcere di Boiati, isolamento, marzo 1972
Scritta dopo una bastonatura particolarmente selvaggia durante uno sciopero della fame
un fiore rosso per Osvaldo, Giangiacomo Feltrinelli
15 marzo 1972
Località Cascina Nuova, Segrate, Milano
Ai piedi del traliccio dell’altra tensione n.71, all’alba, viene rinvenuto il corpo di un uomo dilaniato da una carica esplosiva. Dalla carta d’identità che porta con sé, risulta chiamarsi Vincenzo Maggioni. Ventiquattro ore dopo il rinvenimento, gli inquirenti sono però in grado di stabilire che si tratta di Giangiacomo Feltrinelli, militante dei Gruppi d’Azione Partigiana.
NOME DI BATTAGLIA OSVALDO, FORMA LA PRIMA ORGANIZZAZIONE ARMATA CLANDESTINA, CHE COMPARE SULLA SCENA ITALIANA TRA L’APRILE E IL MAGGIO 1970. TRA LA FINE DEL ’70 E L’INIZIO DEL ’71, I GRUPPI D’AZIONE PARTIGIANA SI PROCURANO UN CERTO NUMERO DI RADIO MODIFICATE PER INTERFERIRE SUI CANALI DELLE RETI NAZIONALI, PER POTER COSI’ INCORAGGIARE ALTRI GRUPPI ALL’AZIONE CLANDESTINA.
26 MARZO 1972: IL SALUTO DALLE PAGINE DI POTERE OPERAIO
Un rivoluzionario è caduto
Lo dipingono ora come un isolato, un avventuriero, come un deficiente o come un crudele terrorista. Noi sappiamo che dopo aver distrutto la vita del compagno Feltrinelli ne vogliono infangare e seppellire la memoria – come si fa con i parti mostruosi. Si, perchè feltrinelli ha tradito i padroni, ha tradito i riformisti. Per questo tradimento è per noi un compagno. Per questo tradimento i nostri militanti, i compagni delle organizzazioni rivoluzionarie, gli operai di avanguardia chinano le bandiere rosse segno di lutto per la sua morte. Un rivoluzionario è caduto.
Giangiacomo Feltrinelli è morto. Da vivo era un compagno dei GAP (Gruppi d’Azione Partigiana) – una organizzazione politico-militare che da tempo si è posta il compito di aprire in Italia la lotta armata come unica via per liberare il nostro paese dallo sfruttamento e dall’ingiustizia. A questa determinazione Feltrinelli era arrivato dopo una bruciante e molteplice attività – dalla partecipazione alla guerra di liberazione, alla milizia nel PCI, all’impegno editoriale, alla collaborazione con i movimenti rivoluzionari dell’ America Latina. L’indimenticabile ’68, lo aveva spinto ad un ripensamento di tutta la sua milizia politica; la breve ma intensa confidenza con Castro e Guevara gli forniva gli strumenti teorici attraverso cui analizzare il fallimento storico del riformismo e, ad un tempo, la prospettiva da seguire per una ripresa del movimento rivoluzionario in Europa. La forte passione civile, la rivolta ad ogni forma di sopraffazione e di ingiustizia ( si pensi all’ attenzione con cui ha sempre seguito le rivendicazioni autonomiste delle minoranze linguistiche italiane ) lo spingevano a saltare i tempi, a bruciare le mediazioni. E’ l’inquietudine di cui parla oggi con disprezzo misto a compatimento il <<Corriere della sera>>. In realtà è l’inquietudine che porta con sè ogni uomo che non si adatti a vivere come un bue, che nutre un odio profondo per tutti i cani ed i porci dell’ umanità. Certo nell’azione di questo compagno ci sono stati errori, ingenuità, improvvisazioni. Grave soprattutto ci è sembrata e ci sembra, nel programma politico dei GAP, la sottovalutazione delle lotte operaie, della loro capacità di andare oltre il terreno rivendicativo per porre la questione dei rapporti di forza tra le classi cioè del potere politico. Ma i suoi errori, la sua impazienza, appartengono al movimento rivoluzionario e operaio; <<assalto al cielo>> che da qualche anno migliaia di militanti hanno cominciato a ricostruire dopo decenni di oscurità e di paura. Fanno parte di questo cammino che, come diceva Lenin, non è diritto e piano ma tortuoso e difficile, e dove accanto all’estrema determinazione di percorrerlo non v’è alcuna certezza sui tempi necessari a mandare in rovina lo stato delle cose presenti.
Il compagno Feltrinelli è morto. E gli sciacalli si sono scatenati. Chi lo vuole terrorista e chi vittima. Destra e sinistra fanno il loro mestiere di sempre. Noi sappiamo che questo compagno non è né una vittima, né un terrorista. E’ un rivoluzionario caduto in questa prima fase della guerra di liberazione dello sfruttamento. E’ stato ucciso perchè era un militante dei GAP. E carabinieri, polizia, fascisti esteri e nostrani lo sapevano e lo sanno benissimo.  E’ stato ucciso perchè era un rivoluzionario che con pazienza e tenacia, superando abitudini, comportamenti, vizi, ereditati dall’ambiente alto-borghese da cui proveniva, s’era posto sul terreno della lotta armata, costruendo con i suoi compagni i primi nuclei di resistenza proletaria.E’ probabilmente vero che la ricerca affannosa che, da mesi, fascisti e servizi segreti vari avevano scatenato per prendere Feltrinelli, si è intensificata dopo il contributo ulteriormente portato dei GAP nello smascheramento dei mandanti e degli esecutori della strage del dicembre del ’69. E’ probabilmente vero che questo compagno ha commesso, per generosità, errori fatali di imprudenza – cadendo così in un’ imboscata nemica la cui meccanica è a tutt’ oggi oscura. Quello che è certo è che di questo assassinio si sono fatti complici tutti coloro che cercavano un <<mandante ed un finanziatore>> per l’attività dei gruppi rivoluzionari. Dal Secolo all’ Unità in una paradossale unità d’intenti dopo la manifestazione del giorno 11 a Milano, tutti hanno latrato : vogliamo il mandante, vogliamo il finanziatore. Come se la lotta di strada, la lotta di piazza avesse bisogno di finanziatori. Le bottiglie <<molotov>> sono generi di largo consumo nell’ Italia degli anni 70. Costano poche centinaia di lire. Come dire alla portata di qualsiasi militante. Sono le attrezzatissime bande fasciste, sono i giornali di partito senza lettori, sono le costose campagne di pubblicità elettorale, sono i mastodontici apparati di Partito che richiedono e trovano i finanziamenti di Cefis, di Agnelli, di Borghi, di Ravelli – oltrechè il generoso contributo delle casse statali e parastatali. Comunque loro – destra e sinistra – volevano il mandante, il finanziatore. Fascisti e servizi segreti glielo hanno trovato. Un cadavere straziato di un pericoloso rivoluzionario che aveva deciso di far sul serio è diventato utile per la bisogna – perchè era Giangiacomo Feltrinelli discendente di una delle famiglie più ricche del paese. Ed i giornali della borghesia si sono affrettati a sputare sopra il cadavere. Con tutto l’odio che si sente per un traditore. Perchè è vero. Giangiacomo Feltrinelli li aveva traditi. Aveva rotto con il suo ed in tre anni densi di attività minuta, continua e coraggiosa era diventato un rivoluzionario. E i miliardari che finanziano i partiti, si drogano al <<Number One>>, vogliono l’ordine e la morale nelle fabbriche e nelle scuole – e per questo utilizzano le bande fasciste – non possono perdonare questo figlio degenere.
E’ stato ucciso perchè era un rivoluzionario che con pazienza e tenacia, superando abitudini, comportamenti, vizi, ereditati dall’ambiente alto-borghese da cui proveniva, s’era posto sul terreno della lotta armata, costruendo con i suoi compagni i primi nuclei di resistenza proletaria.E’ probabilmente vero che la ricerca affannosa che, da mesi, fascisti e servizi segreti vari avevano scatenato per prendere Feltrinelli, si è intensificata dopo il contributo ulteriormente portato dei GAP nello smascheramento dei mandanti e degli esecutori della strage del dicembre del ’69. E’ probabilmente vero che questo compagno ha commesso, per generosità, errori fatali di imprudenza – cadendo così in un’ imboscata nemica la cui meccanica è a tutt’ oggi oscura. Quello che è certo è che di questo assassinio si sono fatti complici tutti coloro che cercavano un <<mandante ed un finanziatore>> per l’attività dei gruppi rivoluzionari. Dal Secolo all’ Unità in una paradossale unità d’intenti dopo la manifestazione del giorno 11 a Milano, tutti hanno latrato : vogliamo il mandante, vogliamo il finanziatore. Come se la lotta di strada, la lotta di piazza avesse bisogno di finanziatori. Le bottiglie <<molotov>> sono generi di largo consumo nell’ Italia degli anni 70. Costano poche centinaia di lire. Come dire alla portata di qualsiasi militante. Sono le attrezzatissime bande fasciste, sono i giornali di partito senza lettori, sono le costose campagne di pubblicità elettorale, sono i mastodontici apparati di Partito che richiedono e trovano i finanziamenti di Cefis, di Agnelli, di Borghi, di Ravelli – oltrechè il generoso contributo delle casse statali e parastatali. Comunque loro – destra e sinistra – volevano il mandante, il finanziatore. Fascisti e servizi segreti glielo hanno trovato. Un cadavere straziato di un pericoloso rivoluzionario che aveva deciso di far sul serio è diventato utile per la bisogna – perchè era Giangiacomo Feltrinelli discendente di una delle famiglie più ricche del paese. Ed i giornali della borghesia si sono affrettati a sputare sopra il cadavere. Con tutto l’odio che si sente per un traditore. Perchè è vero. Giangiacomo Feltrinelli li aveva traditi. Aveva rotto con il suo ed in tre anni densi di attività minuta, continua e coraggiosa era diventato un rivoluzionario. E i miliardari che finanziano i partiti, si drogano al <<Number One>>, vogliono l’ordine e la morale nelle fabbriche e nelle scuole – e per questo utilizzano le bande fasciste – non possono perdonare questo figlio degenere.




























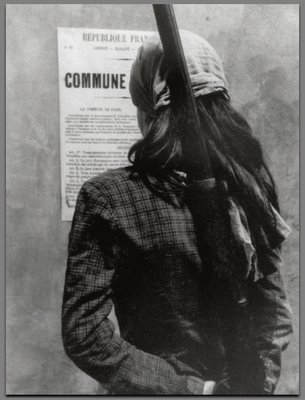
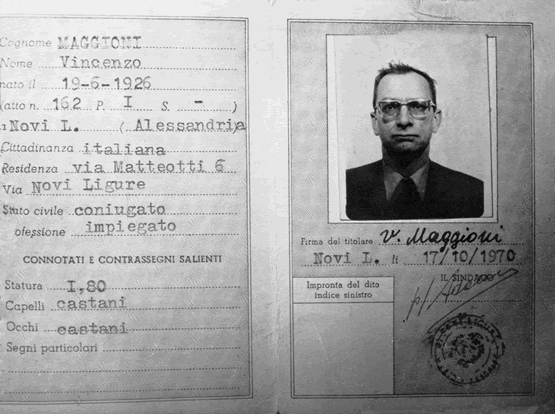




























Commenti recenti