Archivio
Jean-Paul Sartre sulla Tortura
Nel 1943, in via Lauriston, erano dei francesi a gridare d’angoscia e di dolore.
La Francia intera li udiva. L’esito della guerra non era certo, e non si voleva neppure pensare al futuro; ma una sola cosa ci pareva comunque impossibile: che si sarebbero fatti urlare altri uomini, un giorno, in nostro nome.
Ma impossibile non è francese: nel 1958, ad Algeri, si tortura abitualmente, sistematicamente; tutti lo sanno, da Lacoste ai contadini dell’Aveyron. Nessuno ne parla, o quasi: fili di voce si estinguono, nel silenzio. La Francia non era più muta di oggi sotto l’occupazione; ma aveva almeno la scusa di essere imbavagliata. All’estero, il caso nostro è già giudicato: la Francia continua a degradarsi: dal ’39 secondo alcuni, dal ’18 secondo altri.
Io non credo però così facilmente alla degradazione di un popolo; credo ai suoi marasmi e alle sue ottusità. Durante la guerra, quando la radio inglese o la stampa clandestina ci parlavano dei massacri di Ouradour, guardavamo i soldati tedeschi che passeggiavano per le vie con aria innocua, e ci capitava di osservare tra noi: “Eppure sono uomini che ci rassomigliano: come possono fare quello che fanno?” Eravamo fieri di noi, perché riuscivamo a non capirli.
Oggi sappiamo che non c’è nulla da comprendere; tutto si è compiuto insensibilmente, con abbandoni impercettibili; quando abbiamo levato il capo, abbiamo visto nello specchio un volto sconosciuto, odioso: il nostro. Atterriti dallo stupore, i francesi scoprono questa evidenza terribile: se niente vale a proteggere una nazione contro se stessa -né il suo passato, né le sue fedeltà, né le sue proprie leggi,- se bastano quindici anni per cambiare le vittime in carnefici, allora chi decide è l’occasione; basta l’occasione a trasformare la vittima in carnefice: qualsiasi uomo, in qualsiasi momento.
Felici quelli che sono morti senza aver mai dovuto domandarsi: “Se mi strappano le unghie, parlerò?” Ma più felici quelli che non sono stati costretti, usciti appena dall’infanzia, a porsi l‘altra domanda: “Se i miei amici, i miei compagni d’armi, i miei capi strappano le unghie a un nemico dinanzi ai miei occhi, cosa farò?”
Che sanno di loro stessi questi giovani messi con le spalle al muro dalle circostanze? Essi indovinano che qualsiasi decisione possano prendere qui, sembrerà loro astratta e vuota nel momento decisivo; che tutto il loro essere sarà rimesso in gioco da situazioni imprevedibili; e che le loro decisioni per la Francia, per se stessi, dovranno prenderle laggiù, da soli. Essi partono. Altri ritornano, dopo aver sperimentato la propria impotenza, serbando nella maggior parte dei casi un silenzio pieno di rancore. Nasce la paura: la paura degli altri e di se stessi, e dilaga in ogni ambiente. La vittima e il boia si confondono nella nostra stessa immagine. Poiché, nei casi estremi, l’unica maniera di rifiutare una delle due parti consiste nell’accettare l’altra.
Una tale scelta non si impone -almeno non ancora- ai francesi in Francia. Ma proprio queste indeterminatezza ci pesa: noi siamo la ferita e il coltello: l’orrore di questo e il terrore di quella si bilanciano e si rafforzano reciprocamente. I ricordi riaffiorano.  Quindici anni or sono i migliori della nostra Resistenza avevano paura di non resistere alla sofferenza, più che della sofferenza stessa. Essi dicevano :” Quando tace, la vittima salva ogni cosa; ma quando parla, nessuno ha diritto di giudicarla, neppure colui che non ha parlato: essa s’accoppia col suo carnefice, diventa la sua femmina, e questa coppia allacciata sprofonda nella notte dell’abiezione”. L’abiezione ritorna.
Quindici anni or sono i migliori della nostra Resistenza avevano paura di non resistere alla sofferenza, più che della sofferenza stessa. Essi dicevano :” Quando tace, la vittima salva ogni cosa; ma quando parla, nessuno ha diritto di giudicarla, neppure colui che non ha parlato: essa s’accoppia col suo carnefice, diventa la sua femmina, e questa coppia allacciata sprofonda nella notte dell’abiezione”. L’abiezione ritorna.
A El-Biar, essa ritorna ogni notte. In Francia è la fuliggine dei nostri cuori. Ecco, una propaganda sussurrata insinua appunto che “tutti parlano”; e così la tortura si giustifica con l’umana ignoranza: ciascuno di noi essendo un traditore potenziale, il boia che è in ciascuno di noi trova giustificazione. Tanto più che la gloria della Francia lo esige, come voci suadenti insinuano ogni giorno. Un buon patriota non può avere che buona coscienza. Solo un disfattista può averla cattiva.
Allora, lo sbigottimento diviene disperazione: se il patriottismo deve precipitarci all’abiezione, se nessuna sorveglianza, mai, ha impedito alle nazioni e all’umanità tutta di perdersi in una follia disumana, allora, a che scopo tormentarci per divenire o rimanere degli uomini? Essere disumani è la nostra verità.
Ma se di vero non c’è altro che il terrore, terrorizzare o essere terrorizzati, a che scopo vivere e restare patrioti?
Questi pensieri sono stati seminati in noi con la violenza. Nella loro oscurità e nella loro falsità, discendono tutti da questa premessa: l’uomo è inumano. Il loro obiettivo è convincerci della nostra impotenza, e ci riusciranno, finché non li guarderemo in faccia. Ma bisogna che all’estero si sappia che il nostro silenzio non significa consenso. Esso deriva da angosce provocate, esasperate, sapientemente dirette. Lo sapevo da tempo, ma aspettavo la prova decisiva.
Essa è venuta.
 Quindi giorni fa, presso le Editions de Minuit, usciva un libro: La Tortura.
Quindi giorni fa, presso le Editions de Minuit, usciva un libro: La Tortura.
Il suo autore, Henri Alleg, tuttore detenuto in una prigione di Algeri, racconta senza commenti inutili, con precisione ammirevole, gli “interrogatori” che ha subito. I carnefici, come gli avevano promesso, lo hanno “curato”: “telefono da campo”, supplizio dell’acqua come al tempo della Brinvilliers, ma coi perfezionamenti tecnici del nostro tempo, supplizio del fuoco, della sete, etc.
E’ un libro che sconsigliamo alle anime tenere.
Finora, solo qualche richiamato alle armi e soprattutto qualche sacerdote avevano osato portare testimonianze. Avevano vissuto in mezzo ai torturatori, loro e nostri fratelli. Delle vittime, per lo più. Non conoscevano che le urla, le ferite, le sofferenze; additavano i segni del sadismo su brandelli di carne. Ma che cosa ci distingueva da questi sadici? Nulla, dal momento che tacevamo.
La nostra indignazione poteva anche parerci sincera: ma avremmo saputo provarla vivendo laggiù, o non ci saremmo piuttosto abbandonati a una cupa rassegnazione, a un universale disgusto? Per mio conto, leggevo talvolta per dovere e magari pubblicavo, ma detestandomi, quei racconti, che ci mettevano spietatamente in causa, e che non ci lasciavano speranza.
Con La Tortura, tutto cambia. Alleg ci risparmia vergogna e disperazione, perché è una vittima e ha “vinto” la tortura.  C’è un sinistro umorismo, in questo rovesciamento di posizioni; lo hanno martirizzato in nome nostro, e noi, grazie a lui, ritroviamo un poco della nostra fierezza: siamo fieri che sia un francese. I lettori si incarnano in lui con passione, l’accompagnano sino al passo estremo della sofferenza. Con lui, soli e nudi, lottano e resistono. Sarebbero questi lettori, saremmo noi capaci davvero di tanto? Questo è un altro affare. Quello che conta è che la vittima ci libera facendoci scoprire, come lo scopre lei stessa, che abbiamo la possibilità e il dovere di sopportare tutto.
C’è un sinistro umorismo, in questo rovesciamento di posizioni; lo hanno martirizzato in nome nostro, e noi, grazie a lui, ritroviamo un poco della nostra fierezza: siamo fieri che sia un francese. I lettori si incarnano in lui con passione, l’accompagnano sino al passo estremo della sofferenza. Con lui, soli e nudi, lottano e resistono. Sarebbero questi lettori, saremmo noi capaci davvero di tanto? Questo è un altro affare. Quello che conta è che la vittima ci libera facendoci scoprire, come lo scopre lei stessa, che abbiamo la possibilità e il dovere di sopportare tutto.
Eravamo come affascinati dalla vertigine dell’inumano, ma basta che un uomo duro e ostinato -ostinato nel suo mestiere d’uomo- a strapparti all’incantesimo: la “tortura” non è nulla di inumano, è soltanto un crimine ignobile e lurido, commesso da uomini contro altri uomini, e che altri uomini ancora possono e debbono reprimere. L’inumano non esiste, se non negli incubi generati dalla paura. Basta il calmo coraggio di una vittima, la sua modestia, la sua lucidità, per liberarci dalla mistificazione. Alleg ha strappato la tortura alla notte che la ricopriva:; avviciniamoci, guardiamola alla luce.
Questi carnefici, prima di tutto, che cosa sono? Dei sadici? Degli arcangeli irritati? Dei signori della guerra con i loro terrificanti capricci? A creder loro, sarebbero una mescolanza di tutto questo. Ma Alleg, appunto, non li crede. Quel che risulta da quanto egli ci riferisce è che essi vorrebbero convincere se stessi e convincere la vittima di una loro piena sovranità: ora come superuomini che tengono dei semplici uomini in loro potere, ora come uomini forti e severi, incaricati di addomesticare la bestia più oscena, più feroce e più vile che ci sia, la bestia umana. S’indovina che non fanno tuttavia scelte sottili: l’essenziale è far sentire al prigioniero che non è della loro razza_ lo si spoglia, lo si imbavaglia, lo si beffeggia. Intanto, dei soldato vanno e vengono, pronunciando insulti e minacce con una disinvoltura che vorrebbe apparire terribile.
Ma Alleg, nudo, tremante di freddo, legato a una tavola ancor nera e viscida di vecchi vomiti, riduce tutte queste manovre alla loro miserabile verità: sono commedie recitate da imbecilli. Commedia, la violenza fascista delle loro parole, i il giuramento di “buttare all’aria la Repubblica”. Commedia, il discorso  dell’aiutante di campo del generale M., che termina con queste parole: “Non vi resta più che suicidarvi”. Commedie grossolane, sempre quelle, che ricominciano senza convinzione ogni notte, con ogni prigioniero, e che poi si smettono per mancanza di tempo. Perché questi orribili lavoratori sono sovraccarichi di lavoro e fatica: i prigionieri fanno la coda davanti alla tavola del supplizio, si legano, si slegano, si portano in giro le vittime da una camera di tortura all’altra. A guardare con gli occhi di Alleg questo immondo alveare ci si accorge che gli stessi torturatori sono soverchiati da ciò che fanno.
dell’aiutante di campo del generale M., che termina con queste parole: “Non vi resta più che suicidarvi”. Commedie grossolane, sempre quelle, che ricominciano senza convinzione ogni notte, con ogni prigioniero, e che poi si smettono per mancanza di tempo. Perché questi orribili lavoratori sono sovraccarichi di lavoro e fatica: i prigionieri fanno la coda davanti alla tavola del supplizio, si legano, si slegano, si portano in giro le vittime da una camera di tortura all’altra. A guardare con gli occhi di Alleg questo immondo alveare ci si accorge che gli stessi torturatori sono soverchiati da ciò che fanno.
Certo, sanno che atteggiarsi alla calma, bere birra, tranquilli e decisi, accanto a un corpo martirizzato, e poi d’un tratto balzano in piedi, corrono dappertutto, bestemmiano e urlano di rabbia: dei nevrotici che sarebbero delle vittime eccellenti, e alla prima sferzata confesserebbero.
Malvagi, rabbiosi, certo. Sadici? No, nemmeno sadici: hanno troppa fretta. E’ quella che li salva, del resto: resistono grazie alla velocità acquistata: debbono correre senza requie o crollare.
Eppure amano il lavoro ben fatto: se lo giudicano necessario, spingono la coscienza professionale fino ad uccidere. Ed ecco quello che colpisce, nella narrazione di Alleg: dietro questi chirurghi squallidi e sgomenti senti una inflessibilità che li supera, loro e i loro capi.
Sarebbe troppa fortuna, se questi delitti fossero l’opera di un pugno di pazzi. In verità è la tortura, che fa i carnefici. Dopo tutto, questi soldati non si erano arruolati in un corpo scelto per martirizzare il nemico vinto.
Alleg, in pochi tratti, ci descrive quelli che ha conosciuto, e questo basta a segnare le tappe delle metamorfosi.
Ci sono i più giovani, sbigottiti, incapaci di resistere, che mormorano “è orribile” quando la loro torcia illumina un suppliziato.  E poi ci sono i sotto-boia, che non mettono ancora mano alla tortura, ma sostengono e trasportano i prigionieri, alcuni già induriti e altri no, ma tutti già presi nell’ingranaggio, e tutti imperdonabili.
E poi ci sono i sotto-boia, che non mettono ancora mano alla tortura, ma sostengono e trasportano i prigionieri, alcuni già induriti e altri no, ma tutti già presi nell’ingranaggio, e tutti imperdonabili.
C’è un biondino del Nord con un viso così simpatico, che può parlare delle sedute di tortura che Alleg ha subito, “come di una partita di cui si ricorda con piacere, e che non prova disagio a congratularsi con la vittima come farebbe con un campione ciclista”. Qualche giorno dopo, Alleg lo ritroverà congestionato, sfigurato dall’odio, mentre percuote, su per una scala, un musulmano. E poi ci sono gli specialisti, i duri che fanno tutto il lavoro, che si compiacciono ai soprassalti, i duri che fanno tutto il lavoro, che si compiacciono ai soprassalti delle scosse elettriche, ma che non sopportano le grida. E infine i pazzi che corrono intorno come foglie morte nel turbine della loro propria violenza.
Nessuno di questi uomini ha una vita sua, nessuno resterà quello che è: non sono che i momenti di una trasformazione inesorabile. Tra i migliori e i peggiori v’è una sola differenza: i primi sono reclute, i secondi veterani. Tutti finiranno per andarsene e, se la guerra continua, altri li sostituiranno: biondini del Nord o piccoli bruni del Mezzogiorno, che faranno lo stesso tirocinio o ritroveranno la stessa violenza con lo stesso nervosismo.
In quest’affare gli individui non contano; una specie di odio errante e anonimo, un odio radicale dell’uomo s’accanisce a un tempo sui carnefici e sulle vitime per degradarli insieme, gli uni mediante gli altri. Quest’ odio è la tortura eretta a sistema, creatrice dei suoi stessi strumenti.
Quando questo vien detto, sia pur timidamente, sui banchi dell’Assemblea, la canea si scatena, e urla: “E’ un insulto all’esercito”. Ma una volta per tutte, questi cani ringhiosi ci dicano: che c’entra l’esercito? Nell’esercito ci sono dei torturatori, senza dubbio. La commissione inchiesta, nel suo rapporto pur indulgente, non lo ha nascosto. Ma questo non vuol dire che sia l’esercito a torturare.
Che insensatezza! Forse che i civili non conoscono il metodo? Basta lasciar fare alla polizia di Algeri. E poi ci vuole un capo-carnefice, l’Assemblea intera  l’ha designato: non è il generale S., e neppure il generale E., e neppure il generale M., di cui tuttavia Alleg fa il nome: è Lacoste, l’uomo dai pieni poteri.
l’ha designato: non è il generale S., e neppure il generale E., e neppure il generale M., di cui tuttavia Alleg fa il nome: è Lacoste, l’uomo dai pieni poteri.
Tutto si fa attraverso di lui e con lui, a Bona come a Orano: tutti gli uomini che sono morti di sofferenze e di orrore nell’immobile di El-Biar, nella villa S., sono morti per sua volontà. Non sono io che lo dico: sono i deputati, è il governo.
E del resto la cancrena si estende, ha attraversato il mare. Si è sparsa anche la voce che si pratica la tortura in certe prigioni civili del “territorio metropolitano”: non so se sia fondata, ma dev’essere stata raccolta anche dai poteri pubblici, visto che il procuratore, al processo di Ben Saddok, ha domandato solennemente all’accusato se avesse subito sevizie. Beninteso, la risposta era conosciuta in anticipo.
No, la tortura non è né civile né militare né specificatamente francese: è come una sifilide che devasta l’intera epoca. All’est come all’ovest ci sono carnefici. Non è passato tanto tempo da quando Farkas torturava gli ungheresi. I polacchi non nascondono che la loro polizia , prima di Poznan, torturava anch’essa volentieri; e su ciò che accadeva in URSS al tempo di Stalin abbiamo la testimonianza irrecusabile del rapporto Krusciov. Ieri si “interrogavano” così, nelle prigioni di Nasser, degli uomini politici che poi sono stati, con qualche cicatrice, elevati a cariche eminenti. L’elenco potrebbe continuare. Oggi, comunque, è il momento di Cipro e dell’Algeria; e Hitler, insomma, non era che un precursore.
Sconfessata – a volte, del resto, senza molta energia – ma sistematicamente applicata dietro la facciata della legalità democratica, la tortura può definirsi un’istituzione semiclandestina. Ha forse le stesse cause dappertutto? No, probabilmente. E poi poco importa: qui non si tratta di giudicare il nostro tempo; si tratta di guardare in faccia le cose nostre per cercar di capire che cosa è successo a noi, a noi francesi.
Sapete quel che si dice a volte per giustificare i carnefici: bisogna pur ridursi a torturare un uomo se dalla sua confessione possono dipendere centinaia di vite umane. E’ un bell’espediente da Tratuffe. Alleg, come Audin, non era un terrorista. Tanto è vero che è stato accusato di “attentato alla sicurezza dello Stato e di ricostruzione di una lega sciolta”.
Era per salvare delle vite umane che gli si bruciavano i capezzoli e i peli del pube? No, si voleva soltanto estorcergli l’indirizzo dell’amico che lo aveva ospitato. Se avesse parlato, si sarebbe messo un comunista di più sotto chiave: ecco tutto.
E poi si arresta a casaccio: qualsiasi musulmano è “interrogabile” a piacere: la maggior parte dei torturati non dicono nulla perché non hanno nulla da dire, a meno che non acconsentano, per non soffrire di più, a fare una falsa testimonianza o accusarsi gratuitamente di un delitto rimasto impunito, del quale diventa comodo accusarli. In quanto a quelli che potrebbero parlare, si sa bene che tacciono. Tutti, o quasi tutti.
Né Audin, né Alleg, né Guerroudji hanno disserrato i denti. “Ha comunque guadagnato una notte per dar tempo ai suoi amici di tagliare la corda”, constata uno dei carnefici dopo il primo interrogatorio di Alleg. E un ufficiale, qualche giorno più tardi: “Da dieci o da quindici anni sanno che se vengono presi non devono dire nulla. Non c’è niente da fare per togliere loro quest’idea della testa.” Forse volevan parlare soltanto dei comunisti; ma credono forse che i combattenti dell’ALN (l’Armata di Liberazione Nazionale) siano di un’altra tempra? Queste violenze non rendono: gli stessi tedeschi, nel 1944, avevano finito per convincersene; costano vite umane, e non ne salvano.
L’argomento, tuttavia, non è del tutto falso, e comunque ci illumina sulla funzione della tortura , istituzione clandestina o semiclandestina indissolubilmente legata alla clandestinità della resistenza o dell’opposizione.
In Algeria, il nostro esercito è schierato in tutto il territorio. Abbiamo per noi il numero, il denaro, le armi. Gli insorti non hanno nulla, salvo la fiducia e l’appoggio di una gran parte della popolazione. Siamo stati noi, nostro malgrado, a dare a questa guerra popolare attentati nelle città, imboscate nelle campagne; il FLN non ha scelto lui questa forma di attività, fa quello che può e basta.
Il rapporto fra le sue forme e le nostre lo costringe ad attaccarci di sorpresa: invisibili, inafferrabili, inattese, devono colpire e scomparire, per non essere sterminate. Di qui il nostro malessere: lottiamo contro un avversario segreto, una mano lancia una bomba in una strada, una fucilata ferisce un nostro soldato, si accorre: non c’è più nessuno. Più tardi, nei dintorni, si troveranno dei musulmani che non hanno visto niente. Tutto è legato: la guerra popolare, guerra dei poveri contro i ricchi, è caratterizzata dallo stretto vincolo delle unità insurrezionali con la popolazione. Per l’esercito regolare e o poteri civili, questo nugolo di miserabili diventa il nemico quotidiano, innumerevole. Le truppe d’occupazione si preoccupano del mutismo che esse hanno generato. Si indovina una inafferrabile volontà di silenzio, un segreto circolare, onnipresente. I ricchi si sentono braccati in mezzo ai poveri che tacciono. Imbarazzate dalla loro stessa potenza, le “forze dell’ordine” non possono opporre nulla alle guerriglie, se non i rastrellamenti e le spedizioni punitive, nulla da opporre al terrorismo, se non il terrore- Qualche cosa è nascosto: in qualsiasi luogo e da tutti.
Bisogna farli parlare.
 La tortura è una vana furia, nata dalla paura: si vuole strappare, ad una bocca, in mezzo alle grida e ai rigurgiti di sangue, il segreto di tutti. Inutile violenza: che la vittima parli o che muoia sotto le torture, l’innumerevole segreto è altrove, sempre altrove, fuori portata. Il carnefice si trasforma in Sisifo. Se applica la question dovrà sempre ricominciare.
La tortura è una vana furia, nata dalla paura: si vuole strappare, ad una bocca, in mezzo alle grida e ai rigurgiti di sangue, il segreto di tutti. Inutile violenza: che la vittima parli o che muoia sotto le torture, l’innumerevole segreto è altrove, sempre altrove, fuori portata. Il carnefice si trasforma in Sisifo. Se applica la question dovrà sempre ricominciare.
Ma nemmeno questi silenzi, queste paura, questi pericoli sempre invisibili e sempre presenti possono giustificare completamente l’accanimento dei carnefici, la loro volontà di ridurre all’abiezione le loro vittime, questo odio dell’uomo, infine, che si è impadronito di loro senza il loro consenso e li ha plasmati.
Uccidersi a vicenda, è la regola; ci si è sempre battuti per interessi collettivi e particolaristici. Ma nella tortura, questo strano match, la posta sembra essere totale: è per il titolo di uomo che il carnefice si misura col torturato, e tutto si svolge come se i due non potessero appartenere insieme alla specie umana. Scopo dell’interrogatorio non è soltanto quello di costringere un uomo a parlare, a tradire: bisogna che la vittima si auto qualifichi bestia umana attraverso le sue grida e la sua sottomissione: agli occhi di tutti e davanti a se stessa. Bisogna che il suo tradimento la spezzi e la tolga definitivamente di mezzo. Colui che cede all’interrogatorio, non soltanto è costretto a parlare, ma gli è stato imposto per sempre uno status: quello del sotto-uomo.
Questa radicalizzazione della posta è uno dei caratteri del nostro tempo. In nessuna epoca la volontà di essere liberi è stata più cosciente e più forte: in nessuna epoca l’oppressione è stata più violenta e meglio armata.
In Algeria le contraddizioni sono irriducibili: ognuno dei gruppi in conflitto esige l’esclusione radicale dell’altro. Abbiamo preso tutto ai musulmani e poi abbiamo proibito loro persino l’uso della loro lingua. Memmi, lo scrittore algerino, ha dimostrato come la colonizzazione si realizza attraverso l’annullamento dei colonizzati. Essi non possedevano più nulla, non erano più nessuno: abbiamo liquidato la loro civiltà rifiutando loro la nostra. Avevano chiesto l’integrazione, l’assimilazione e noi abbiamo risposto di no: grazie a quale miracolo si potrebbe mantenere il supersfruttamento coloniale se i colonizzati dovessero godere degli stessi diritti dei coloni? Sotto-alimentati, incolti, miserabili, il sistema li respingeva spietatamente ai confini del Sahara, ai limiti dell’umano; sotto la spinta demografica il loro tenore di vita si abbassava di anno in anno. Quando la disperazione li ha indotti alla rivolta, questi sotto-uomini non avevano altra scelta che morire o tentare di affermare la loro umanità contro di noi: hanno respinto i nostri valori, la nostra cultura, le nostre pretese superiorità, e in blocco hanno rivendicato il titolo di uomini e rifiutato la nazionalità francese.
Questa ribellione non si limitava a contestare il potere dei coloni. Essi hanno capito che era in causa la loro stessa esistenza. Per la maggior parte degli europei d’Algeria ci sono due verità complementari e inseparabili: i coloni sono degli uomini per diritto divino,  gli indigeni sono una sottospecie di uomini. E’ la traduzione mitica di un fatto preciso, poiché la ricchezza degli uni poggia sulla miseria degli altri.
gli indigeni sono una sottospecie di uomini. E’ la traduzione mitica di un fatto preciso, poiché la ricchezza degli uni poggia sulla miseria degli altri.
Così lo sfruttamento mette lo sfruttatore alla dipendenza dello sfruttato. E, su un altro piano, questa dipendenza è il nocciolo del razzismo, è la sua contraddizione profonda e la sua acida maledizione: essere uomo, per l’europeo di Algeri, vuol dire, innanzitutto, essere superiore al musulmano.
Ma se il musulmano si afferma a sua volta come uomo, come l’eguale del colono? Ebbene il colono è leso nel suo essere, si sente diminuito, svalutato: l’accesso dei bougnoules (termine dispregiativo per definire gli arabi) alle condizioni di uomini gli ripugna non soltanto perché ne vede le conseguenze economiche ma perché gli si annunzia il suo decadimento personale. Nella sua rabbia il colono sogna il genocidio. Ma è una pura utopia. Egli lo sa, conosce la propria dipendenza. Che cosa farebbe senza un sottoproletario indigeno, senza una manodopera in eccesso, senza la disoccupazione cronica che gli permette di imporre i salari? E poi, se i musulmani sono già degli uomini, tutto è perduto, non c’è nemmeno più bisogno di sterminarli. No: la cosa più urgente, se c’è ancora tempo, è di umiliarli, di stroncare l’orgoglio nel loro cuore, di abbassarli al livello della bestia.
Si lascerà vivere il corpo, ma si ucciderà lo spirito. Domare, addomesticare, castigare, ecco le parole che ossessionano il colono. Non c’è posto in Algeria per due specie umane. Tra l’una e l’altra bisogna scegliere.
Beninteso, non intendo dire che gli europei di Algeri abbiano inventato la tortura, e nemmeno che abbiano incitato le autorità civili e militari a praticarla. Al contrario: la tortura si è imposta da sé, è diventata una pratica prima ancora che ci se ne accorgesse. Ma l’odio per l’uomo che vi si manifesta, è l’espressione del razzismo. Poiché è proprio l’uomo che si vuol distruggere, con tutte le sue doti di uomo, il coraggio, la volontà, l’intelligenza, la fedeltà, quelle stesse doti che il colono rivendica per sé. Ma se l’europeo trascende sino a detestare la propria immagine, vuol dire che essa è rispecchiata da un arabo.
 Così, di queste due coppie indissolubilmente legate, il colono e il colonizzato, il carnefice e la sua vittima, la seconda è un’emancipazione della prima. I carnefici non sono coloni, né i coloni sono carnefici. Questi ultimi sono spesso giovanotti che vengono dalla Francia e hanno passato vent’anni della loro vita senza mai preoccuparsi del problema algerino. Ma laggiù l’odio è un campo di forze magnetiche che li ha attraversati, corrosi e asserviti.
Così, di queste due coppie indissolubilmente legate, il colono e il colonizzato, il carnefice e la sua vittima, la seconda è un’emancipazione della prima. I carnefici non sono coloni, né i coloni sono carnefici. Questi ultimi sono spesso giovanotti che vengono dalla Francia e hanno passato vent’anni della loro vita senza mai preoccuparsi del problema algerino. Ma laggiù l’odio è un campo di forze magnetiche che li ha attraversati, corrosi e asserviti.
La calma lucidità di Alleg ci permette di comprendere tutto ciò. Quand’anche non ci desse altro, bisognerebbe essergliene profondamente grati. Ma in realtà egli ha fatto molto di più: incutendo rispetto ai suoi carnefici ha fatto trionfare l’umanesimo delle vittime e dei colonizzati contro le violenze senza misura di certi militari, contro il razzismo dei coloni. E la parola “vittime” non vale qui a suscitare non so quale lacrimoso pietismo: in mezzo ai loro piccoli caid, fieri della loro giovinezza, della loro forza, del loro numero, Alleg è il solo “duro”, il solo veramente forte. Noi possiamo dire che ha pagato il prezzo più alto per il semplice diritto di rimanere un uomo fra gli uomini. Ma egli non vi pensa neppure. E’ per questo che tanto ci commuove questa semplice frase alla fine di un paragrafo: “Mi sentii tutt’a un tratto fiero e contento di non aver ceduto. Ero convinto che avrei resistito ancora se avessero ricominciato, che mi sarei battuto fino in fondo, che non avrei facilitato il loro compito suicidandomi.”
Si, un duro, che finisce per far paura agli arcangeli dell’ira.
Almeno in alcune delle loro parole, si intuisce che essi presentono e cercano di scongiurare una vaga e scandalosa rivelazione: quando è la vittima che trionfa, addio sovranità, addio diritto divino. Le ali degli arcangeli si fermano e i carnefici si chiedono perplessi: ma io saprei resistere se mi torturassero?
Il fatto è che, al momento della vittoria, un sistema di valori si è sostituito agli altro. Per poco gli stessi carnefici non sono presi dalla vertigine. Ma no: hanno la testa vuota, il lavoro li abbrutisce e credono appena a ciò che fanno.
Perché poi, del resto, turbare la coscienza dei carnefici?
Se qualcuno di loro muovesse obiezione, i loro capi lo sostituirebbero: ne troverebbero dieci per uno perduto. La testimonianza di Alleg infatti – ed è forse il suo maggiore merito – dissipa completamente le nostre illusioni: non basta punire o rieducare alcuni individui.
La guerra d’Algeria non può essere umanizzata. La tortura si è imposta da sé: è stata suggerita dalle circostanze, chiamata dall’odio razzista. In certa misura, come abbiamo visto, essa si trova al centro stesso del conflitto e forse ne esprime la verità più profonda. Se vogliamo mettere fine a queste immonde e lugubri crudeltà, salvare la Francia dalla vergogna e gli algerini dall’inferno, abbiamo un solo mezzo, sempre lo stesso, il solo che abbiamo mai avuto, il solo che avremo mai: aprire dei negoziati, fare la pace.
Jean-Paul Sartre
Sparano…
ECCO APPUNTO…TANTO PERCHE’ TRA POCHE ORE SONO DA QUELLE PARTI. Atene, 09:28
GRECIA: ATENE, STUDENTE FERITO A UNA MANO DA PROIETTILE
Mentre in tutta la Grecia continuano le proteste di piazza per la morte del quindicenne Alexis Grigoropoulos, ucciso il 6 dicembre scorso da un proiettile vagante sparato da un poliziotto, alla periferia occidentale di Atene un altro giovane e’ stato raggiunto da una pallottola, che lo ha ferito a una mano: stando a quanto riferito da fonti di polizia, l’episodio e’ accaduto ieri sera davanti a una scuola di Peristeri, municipalita’ sub-urbana della capitale ellenica, mentre lo studente stava conversando con alcuni compagni. Al momento si ignora che possa aver esploso il colpo di arma da fuoco. Le condizioni delle vittima non destano preoccupazione, ma la vicenda rischia peraltro di alimentare ulteriormente la tensione nel Paese.
 Nel frattempo è stato attaccato un parcheggio di proprietà della polizia speciale antisommossa e sono state date alle fiamme auto, pullman e jeep. Per le foto: http://lombardia.indymedia.org/node/11780
Nel frattempo è stato attaccato un parcheggio di proprietà della polizia speciale antisommossa e sono state date alle fiamme auto, pullman e jeep. Per le foto: http://lombardia.indymedia.org/node/11780
NON SPARATE SUI NOSTRI SOGNI
Se io non brucio
Se tu non bruci
Se noi non bruciamo
Come dal buio nascera’ la luce?
(Nazim Hikmet “Come Kerem”)
Non sparate sui nostri sogni
Lettera degli amici di Alexis
Siamo i vostri figli! I noti sconosciuti!
Vogliamo un mondo migliore!
Aiutateci. Non siamo terroristi, “incappucciati”, “i soliti ignoti”.
Sogniamo, non uccidete i nostri sogni.

REUTERS/John Kolesidis
Aiutateci. Non siamo terroristi, “incappucciati”, “i soliti ignoti”.
Sogniamo, non uccidete i nostri sogni.

REUTERS/John Kolesidis
Abbiamo l’entusiasmo, non uccidete il nostro entusiamo. Ricordatevi!
Siete stati giovani anche voi.
Adesso inseguite il denaro, vi interessate solo delle “vetrine”, siete ingrassati, avete perso i capelli, avete dimenticato!
Aspettavamo il vostro sostegno
Aspettavamo il vostro interesse per farci sentire orgogliosi di voi.
Invano!
Vivete una vita falsa, avete chinato la testa, vi siete piegati e aspettate il giorno in cui morirete.
Non immaginate, non vi innamorate, non create.
Solo vendete e comprate.
Cose e oggetti dappertutto.
Amore da nessuna parte, verità da nessuna parte.
Dove sono i genitori?
i ragazzi
Ps: non tirateci altri lacrimogeni, stiamo già piangendo
“Sallo”…che Sossi è fascista. Gasparazzo attualissimo
Roma, 22 set. (Adnkronos)—AZIONE SOCIALE: MARIO SOSSI, CON LA MUSSOLINI CONTRO L’ITALIA DI GHEDDAFI—
«Bisogna spostare il baricentro della Pdl più a destra». «Resto sempre nell’ambito del centrodestra. Azione sociale è un pezzo di Pdl. Ma si tratta di spostare un pochino il baricentro. Troppi errori e si vede». Lo afferma in un’intervista a «La Stampa» l’ex magistrato rapito dalle Br nell’aprile del ’74, Mario Sossi, che spiega così il suo passaggio al partito di Alessandra Mussolini. Ed il primo esempio di errori per Sossi è «la questione Gheddafi». «Lui manda gli immigrati e noi -sottolinea- lo riempiamo di soldi». Ma per Sossi, Gheddafi non è l’unico punto su cui non condivide le scelte. I punti per lui sono anche «L’effettività della pena che ancora non si riesce ad assicurare. La promessa di dare il voto agli extracomunitari. C’è quest’Europa che se non proprio atea, si avvia verso la scristianizzazione e nessuno che ne difenda le radici cristiani». «Io capisco che la politica -dice ancora- sia il frutto di compromessi ma qui ci vogliono dei paletti… dei valori…l c’è persino un esponente del centrodestra, a Genova, che propone le narcosale… E poi, dobbiamo lasciare a Violante la difesa di Salò?». (Rre/Col/Adnkronos) 22-SET-08 09:34 NNN

Ulrike Meinhof a Renate Riemeck
UNA MADRE DI SCHIAVI SUPPLICA LA FIGLIA
“Urike, tu sei diversa dalla foto segnaletica, una figlia di schiavi – tu stessa una schiava.
Come puoi essere capace di sparare al tuo oppressore?
Non lasciarti sedurre da chi non vuol esser più schiavo. Non puoi proteggerlo.
Voglio che resti una schiava – come me, io e te – abbiamo visto come i padroni hanno sgominato la rivolta degli schiavi, prima ancora che cominciasse.”
“O piccola, tu hai meritato qualcosa di meglio. Pensa che saresti potuta diventare.
Di sicuro saresti diventata una sorvegliante carceraria.
Non vedi quant’è forte il potere? Tutti gli schivi, gli ubbidiscono.
Persino coloro che si sono rivoltati e hanno vinto, metteranno ai piedi del potere la loro vittoria,
affinché possano essere ancora schiavi.
Gli schiavi odiano chi vuole essere libero. Non dovrebbero nemmeno aiutarti,
in modo che tu capisca una volta per tutte che la tua ribellione non ha senso.
Il tuo coraggio è spietato, perché ci costringe a svelare la nostra vigliaccheria.
Se preferisci morire poiuttosto che essere per sempre una schiava,
allora non hai comunque il diritto di toglierci la quiete.”
Ritrovata in un cestino dei rifiuti a Berlino,nel ’71, insieme ad alcuni documenti e munizioni.
 “Compagni, smettete di trincerarvi dietro le masse! Smettete di razionalizzare le vostre paure per la smisurata violenza del sistema come un problema di comunicazione! Smettete di spacciare la vostra perplessità per erudizione, la vostra impotenza per lucidità!
“Compagni, smettete di trincerarvi dietro le masse! Smettete di razionalizzare le vostre paure per la smisurata violenza del sistema come un problema di comunicazione! Smettete di spacciare la vostra perplessità per erudizione, la vostra impotenza per lucidità!Abbiate il coraggio di combattere, abbiate il coraggio di vincere!
Disintegrate e frantumate le forze dell’imperialismo!
L’obbligo di ogni rivoluzionario è di fare la rivoluzione!”Ulrike Meinhof, 31 maggio ’72, Aula IV dell’Università di Francoforte
Su Ulrike Meinhof, LEGGI QUI
Leggi la commissione di inchiesta sul suo assassinio QUI
“Per nessun motivo”
Lui si incamminò verso la cresta della collina, lassù doveva esserci il cippo, perché lassù c’era il grosso della gente, tanta e disposta come intorno a una grande disgrazia. Aveva anche la curiosità di vedere il cippo, l’aveva già sentito nominare un cippo, ma non sapeva immaginarsene la forma. Arrivò e lo vide, era una specie di enorme paracarro, piantato proprio sul bordo della strada e con sopra dei segni neri che non erano i chilometri e il nome del paese più vicino ma i nomi dei morti e la data della battaglia. Ettore sapeva che quei morti erano seppelliti altrove, eppure sentiva come se i loro cadaveri fossero murati in quella specie di paracarro e così fissava il cippo con grande speciale attenzione. E tremò, lì, di colpo, come se gli si fosse parato davanti un pericolo di morte così preciso ed avanzato che il terrore era già agonia e come sotto i piedi si sentisse aprirsi la terra della collina, pronta per il suo cadavere.
Mentre gli stava passando un po’, una voce cominciò a parlar forte dall’alto della collina, era l’esponente del Comitato di Liberazione che faceva il discorso.
Va bene che io non credo mai niente di quello che dicono questi uomini qui in queste circostanze qui, ma non voglio nemmeno correre il rischio di ascoltarlo. C’è un solo discorso che voglio ascoltare, e questo discorso me lo faccio io, c’è solo una lezione che voglio tenere a mente, e mi odio se penso che l’avevo già imparata bene e poi col tempo me la sono dimenticata. Non finire sottoterra. Per nessun motivo.
Non finire sottoterra. Né in galera.
tratto da “La Paga del sabato” di Beppe Fenoglio
Foto di Valentina Perniciaro, una lapide per ricordare l'eccidio di Gessopalena, Chieti.
“Avevo 20 anni. Non permetterò a nessuno di …
A PAUL NIZAN, ucciso nel 1940 da una pallottola tedesca durante la ritirata di Dunkerque. Saggista, narratore, pazzo viaggiatore
“Vivo, non ci fu un’ora che non rischiasse di perdersi; morto, corse un pericolo anche peggiore: per fargli pagare la sua chiaroveggenza una congiura di imbecilli ebbe la pretesa di farlo scomparire.
Da dodici anni apparteneva al Partito, quando, nel settembre del 1939, fece sapere che l’abbandonava: era la colpa inespiabile, era il peccato della disperazione che il Dio dei cristiani punisce con la dannazione.
I comunisti non credono all’Inferno: credono al nulla, e così fu deciso l’annientamento del compagno Nizan. Una pallottola esplosiva l’aveva colpito, nel frattempo, alla nuca, ma tale liquidazione non soddisfece nessuno: non bastava che avesse cessato di vivere, occorreva che non fosse esistito affatto.
La Virtù su, insieme col whisky, il nostro svago principale.
Nizan era un guastafeste: chiamava alle armi, all’odio, classe contro classe; con un nemico impaziente e mortale non esistono accomodamenti: uccidere o farsi uccidere, senza vie di mezzo. E senza dormire mai.
Pensavamo che, se fosse vissuto, avrebbe partecipato della nostra nuova sottigliezza, vale a dire, dei nostri compromessi. Che cosa aveva salvato la sua violenta purezza se non una pallottola perduta? Non c’è di che vantarsi. Ormai quel morto se la spassava allegramente nei suoi libri aveva scritto che un borghese francese a quarant’anni è una carcassa; e poi se l’era svignata, a trentacinque.
All’indomani del conflitto quella gioventù impazzì d’orgoglio e trovò il proprio piacere nel comportamento dell’obbedienza. Dopo cinque anni il loro avvenire si sgelava: avevano dei piani: la candida speranza di rinnovare la letteratura per mezzo della disperazione, di conoscere il fastidio di grandi viaggi intorno al mondo, l’insopportabile noia di guadagnare denaro e sedurre donne, oppure, più modestamente, di diventare farmacista o un dentista disperato e restarlo a lungo, molto a lungo, senz’altra preoccupazione che quella della condizione umana nella sua generalità. Che allegria: Nizan non aveva nulla da dire loro: parlava della condizione dell’uomo, molto delle cose sociali e delle nostre alienazioni: conosceva il terrore e il ringhio piuttosto che le dolcezze della disperazione; nei giovani borghesi che frequentava odiava il proprio riflesso e, fossero disperati o no, li trovava deprimenti.
Il loro rilassarsi, congelatosi, non è più che inerte vacuità. Fanno quel che occorre, modestamente, si guadagnano il pane, hanno la 403, una casa in campagna, una moglie e dei bambini. Ma, con uno stesso colpo d’ala, speranza e disperazione li hanno abbandonati. Questi ragazzi si preparavano a vivere, “partivano”, ma il loro treno si è fermato in aperta campagna: non andranno in nessun luogo, non faranno nulla.
Talvolta un ricordo confuso della loro splendida irrequietezza gli torna in mente ed allora si chiedono: “Ma in realtà, che cosa volevamo?” e non se ne ricordano.
Questi adattati soffrono di un’inadattabilità cronica e ne morranno: sono degli accattoni senza miseria, è inutile rimpinzarli. Li ricordo a vent’anni, così vivaci, così gai, impegnati a darci il cambio. Li osservo oggi, con quegli occhi corrosi dal cancro della stupefazione, e penso che non meritavano un simile servizio.
Ma noi non abbiamo più nulla da dire ai giovani; cinquant’anni di vita in questa provincia arretrata qual è divenuta la Francia ci hanno svilito. Abbiamo gridato, protestato…e poi alla fine eccoci qua: abbiamo accettato ogni cosa. Comunicare ai questi giovani sconosciuti la nostra saggezza e i bei frutti della nostra esperienza?
In conclusione, ragionieri o spacconi, teppisti o tecnici, lottano senza speranza e soli contro l’asfissia. E non illudetevi che coloro i quali scelgono la famiglia e un mestiere si rassegnino; non hanno fatto che rivolgere la propria violenza contro se stessi e infierire; ridotti all’impotenza dai padri, si sono storpiati da se stessi per risentimento; gli altri rompono tutto, colpiscono chiunque con qualunque cosa, con un coltello, con una catena di bicicletta; per sfuggire al proprio disagio farebbero saltare in aria tutto.Ma non salta nulla.
Giovane e violento, colpito da morte violenta, Nizan può uscire dalla fila e parlare della giovinezza ai nostri giovani : “AVEVO VENT’ANNI. NON PERMETTERO’ A NESSUNO DI DIRE CHE QUESTA E’ LA PIU’ BELLA ETA’ DELLA VITA”. Riconosceranno la loro stessa voce; egli potrà dire agli uni: state morendo di modestia, abbiate il coraggio di desiderare, siate insaziabili, scatenate le forze terribili che si fanno guerra e girano in tondo sotto la vostra pelle, non vergognatevi di volere la luna: ne abbiamo bisogno!
E agli altri: dirigete la vostra rabbia su coloro che l’hanno provocata, non cercate di sfuggire al vostro male, investigatene la cause e infrengetele.
Egli può dire tutto, perchè è un giovane mostro, un bel giovane mostro come loro, che divide il loro terrore di morire e il loro odio di vivere nel mondo che noi abbiamo fatto per loro. Era solo, diventò comunista, cessò di esserlo e morì solo, accanto a una finestra, sui gradini di una scala. Questa vita si spiega attraverso la sua intransigenza: si fece rivoluzionario per rivolta e quando la rivoluzione dovette cedere il passo alla guerra, ritrovò la sua violenta giovinezza e finì da ribelle.”
Jean-Paul Sartre, Marzo 1960
prima o poi…
E’ MORTO UN PARTIGIANO.
NE NASCONO ALTRI CENTO!
Ciao Carletto.
Mi piace ricordarti con questa foto. Mi piace ricordarti vivo, per le strade di quella città,
a pochi passi da me, a pochi passi da tutti noi.
Mi piace pensare che un giorno, prima o poi, ti vendicheremo!
“Noi viviamo stretti in un giuramento di ferro.
Per esso si va sulla croce e incontro ai proiettili.
Nelle nostre vene scorre sangue, non acqua.
Noi marciamo tra l’abbaiare dei revolver,
per incarnarci, morendo,
in navi,
in versi,
e in altre opere di lunga durata.”
Vladimir Majakovskij
SANGUE DEL NOSTRO SANGUE
7 luglio 1960 – 7 luglio 2008
A 48 anni dalla strage di REGGIO EMILIA.
“COMPAGNO SIA BEN CHIARO, CHE QUESTO SANGUE AMARE VERSATO A REGGIO EMILIA E’ SANGUE DEL NOSTRO SANGUE, NERVI DEI NOSTRI NERVI, COME FU QUELLO DEI FRATELLI CERVI”
“Mio babbo aveva 41 anni. E’ morto sui gradini della chiesa di San Francesco, dove cercava riparo. Molto cristianamente il parroco aveva sbarrato le porte” _Oldano Serri, figlio di Marino_
“A mio fratello il proiettile si è fermato sulla spina dorsale, causando una paralisi, ma non era questa la preoccupazione. La preoccupazione era il fatto che si era recisa un’arteria, e con le trasfusioni l’han tenuto vivo fino all’una dopo mezzanotte, cosciente, e noi eravamo lì, io e mio fratello, a darci il cambio al suo capezzale. Io non sono riuscito a dirgli niente. Lui mi ha detto Gianni, mi han mirato come a un uccellino, mi han voluto uccidere.
Ma se muoio, vendicatemi.” _Gianni Tondelli_
1) TONDELLI AFRO, anni 36, ferita da arma da fuoco alla base dell’emitorace sinistro, regione inferiore, deceduto nelle prime ore della notte.
2) FRANCHI OVIDIO, anni 19, ferita d’arma da fuoco penetrante nel cavo addominale, deceduto alle ore 18
3) FARIOLI LAURO, anni 22, due ferite d’arma da fuoco, una in regione ascellare sinistra, mortale, e la seconda nella coscia destra. Giunto cadavere in ospedale
4) SERRI MARINO, anni 40, ferita d’arma da fuoco in regione toracica, deceduto alle ore 18
5) REVERBERI EMILIO, anni 38, ferita penetrante d’arma da fuoco in regione medio frontale e in regione sopraccigliare destra con frattura esposta della volta cranica, deceduto alle ore 21.
Un nastro, registrato durante la sparatoria, raccoglie attimo per attimo le fasi più drammatiche della strage. Dura ventisette minuti, dalle diciassette meno un quarto, alle diciassette e dodici. Si sente distintamente una voce di comando ordinare: SPARATE NEL MEZZO! L’ordine è seguito da una fucileria intensissima. Tra le violente raffiche affiorano grida di aiuto e si odono voci continue gridare: VIGLIACCHI! ASSASSINI! , un’accusa ripetuta instancabilmente mentre gli uomini cadono.
Una lunga assordante sparatoria chiude la drammatica registrazione.
CON QUESTE MAN DA CALLI, NOI LA FAREM VENDETTA!
Okkio ai Koreani!
Hai capito i Koreani!
Dopo un bel po’ di ore di scontri tra polizia e lavoratori in sciopero,
i “tutori dell’ordine costituito” hanno alzato la bandiera bianca.
“Daje compà, famose ‘na dormita e poi ricominciamo!”
E così…..cordoni di protezione per chi dorme.
Poi si fa a scambio di posto: chi dormiva si cordona,
chi cordonava si sdraia a dormire.
ECCEZIONALE! Avrei pagato per assistere a questo.
PIU’ INCUBI PER LE FORZE DELL’ORDINE,
PIU’ PENNICHELLE STRADALI….
è che noi non siamo più capaci di farli faticare.
GRANDISSIMI I COMPAGNI KOREANI! GRANDISSSSSIMI!
ABBIAMO GLI OCCHI SEMPRE APERTI, NOI!
La strage quotidiana
Nella giornata di ieri ci sono stati 9 morti sul lavoro.
Questa mattina un’altra donna s’è aggiunta al lungo elenco.
Il genocidio perpetrato dai padroni non si ferma.
E noi si continua a morire sul posto di lavoro, a rimaner schiacciati,
asfissiati, incastrati, sommersi,
a volar giù dai ponteggi, a morire nelle stive, nelle cisterne,
nelle acciaierie, sotto le ruspe.
FERMIAMO QUESTO GENOCIDIO.
E lo si può fermare solo prendendo coscienza, ricominciando a lottare
su tutti i posti di lavoro, ricominciando ad avere potere nelle mani,
a sovvertire i rapporti di forza.
“senza approdo”
“Sono la figlia di Marina Petrella.
Vorrei raccontarvi qualcosa su mia madre. Vorrei provare a dirvi cosa rappresenta la negazione della ricostruzione di un essere umano. Dobbiamo parlare di ricostruzione, visto che Marina non è uscita dalla sua storia politica nello stesso modo in cui ci è entrata. E’ successo poco più di 25 anni fa, quando già il vento della lotta armata cominciava ad andare via, quando i rumori metallici della notte tuonavano sempre più vicino, dopo che alcuni, quello che poi sono stati chiamati “pentiti”, incominciavano a barattare delle riduzioni di pena in cambio di denuncie e delazioni, fu allora che la storia politica di mia madre è ricominciata a finire.
Erano i primi anni ’80. Dopo aver capito che le sue speranze di cambiare il mondo andavano incontro alla sconfitta e che l’impegno politico tenuto fino allora non poteva più continuare allo stesso modo, Marina decise di non fermare la sua vita, ma che dal suo percorso sarebbe potuta nascere una nuova storia.
Questa nuova storia è incominciata con me che ho scelto per nascere una calda giornata di agosto dentro una prigione speciale, in pieno articolo 90.
Solo chi ha vissuto quest’esperienza può capire l’immane volontà che serve per essere madre, dare al mondo e crescere una figlia tra le sbarre di un carcere. Solo chi è consapevole di questa prova può capire quanto questa scelta non sia una fuga nel personale, una soluzione egoista ma che sia la rappresentazione fisica di una pagina voltata. Questo è stato il suo modo per affermare che iniziava un nuovo percorso di vita, un diverso impegno sociale. Ed è anche grazie a questo nuovo stato di cose che otto anni dopo le è stato permesso di uscire dal carcere e di essere libera fino al verdetto della Cassazione del 1993.
Già a quell’epoca Marina non era più quel soggetto pericoloso dipinto dai media al momento del suo nuovo arresto. Ma l’Italia dimentica presto. Meglio, ricorda solo quel che vuole. Seleziona la memoria.
La Francia di Mitterand cercando di favorire una pacificazione del conflitto italiano degli anni ’70 ha accolto numerosi ex attivisti di quel periodo. I governi di sinistra come di destra hanno rispettato questo asilo di fatto. A noi, figli di quei rifugiati, è stato permesso di crescere, di vivere, di avere anche nuovi fratelli e sorelle. L’esilio c’è stato malgrado le contraddizioni, malgrado le incertezze di una vita difficile, precaria in attesa di un asilo. Un asilo che esprimeva una speranza di una vita nuova.
Dal nulla di un “fine pena mai” che Marina aspettava in Italia è nata nel 1997 mia sorella. Una bambina francese che ora vede quel paese che le ha dato una nazionalità ricacciare sua madre nel pozzo del carcere a vita.
Da quel 1993 quindici anni sono passati. Quindici anni quando un treno ci ha portati alla Gare de Lyon. Quindici anni da quando i nostri passi si sono mischiati a quelli dei nuovi migranti d’inizio secolo.
Anche speranzosi di una vita che non fosse la galera della miseria. Perchè questo “pezzo” di tempo, che ha permesso di cambiare il loro impegno politico in un impegno sociale, non è più che legittimo per chiedere asilo? Perchè non è ora di girare la pagina di questa storia, per permettere a noi nuove generazioni un vero futuro e consentire a quelle persone come mia madre di vivere la seconda chance che gli è stata data?
A venticinque anni di distanza dai fatti imputati, quindici anni dopo l’esilio, un nuovo primo ministro francese ha deciso che bisognava rimangiarsi la parola data da tutti i suoi predecessori.
Il governo francese ha deciso di estradare mia madre, di cancellare la sua vita in Francia e di rinchiuderla non solo in un carcere ma di fare del passato la sua prigione. La Francia ha deciso tutto questo cedendo al populismo penale, all’ossessione sicuritaria ad una voglia di vendetta infinita che ha perso il significato della speranza. Il primo ministro ha deciso che la vita di mia madre doveva fermarsi.
Ma quindici anni di esilio di fatto creano dei diritti e noi non lasceremo la Francia deresponsabilizzarsi dalla sua storia e cultura.
______ELISA NOVELLI PETRELLA_____ [da “Liberazione” del 11-06-2008]
Per ascoltare la corrispondenza registrata oggi ai microfoni di Radio Onda Rossa con Elisa:
“Le parole degli Stati sono come le foglie morte che si lasciano trascinare dalla direzione del vento. Non più parole date ma parole vuote. Questo deve aver pensato Marina quando si è vista notificare il decreto nella matricola dal carcere di Fresnes. […]Un paese che ha dato forma ad un singolare paradosso: non ha conservato la memoria degli anni ’70 ma è stata incapace di oblio. Alla memoria storica svuotata dei fatti sociali ha sostituito la memoria giudiziaria, all’oblio penale ha sovrapposto l’oblio dei fatti sociali. […] Alla fine la zattera dei rifugiati, riparo precario d’esistenze sospese, è rimasta senza approdo davanti al porto della sua Itaca immaginaria. ____PAOLO PERSICHETTI___ [Liberazione, 11 giugno 2008] Ad Elisa tutto il mio cuore, A Marina solo un urlo di libertà, che sappia scalfire quelle mura!


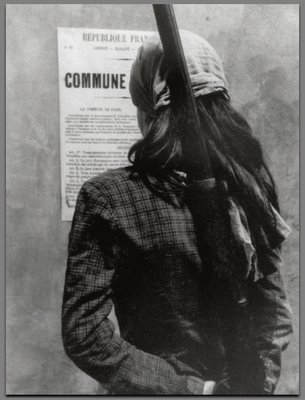









































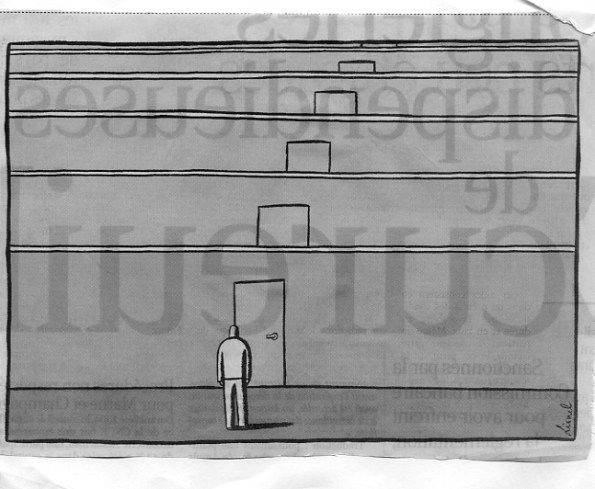
































Commenti recenti