Nel 1943, in via Lauriston, erano dei francesi a gridare d’angoscia e di dolore.
La Francia intera li udiva. L’esito della guerra non era certo, e non si voleva neppure pensare al futuro; ma una sola cosa ci pareva comunque impossibile: che si sarebbero fatti urlare altri uomini, un giorno, in nostro nome.

Henri Alleg
Ma impossibile non è francese: nel 1958, ad Algeri, si tortura abitualmente, sistematicamente; tutti lo sanno, da Lacoste ai contadini dell’Aveyron. Nessuno ne parla, o quasi: fili di voce si estinguono, nel silenzio. La Francia non era più muta di oggi sotto l’occupazione; ma aveva almeno la scusa di essere imbavagliata. All’estero, il caso nostro è già giudicato: la Francia continua a degradarsi: dal ’39 secondo alcuni, dal ’18 secondo altri.
Io non credo però così facilmente alla degradazione di un popolo; credo ai suoi marasmi e alle sue ottusità. Durante la guerra, quando la radio inglese o la stampa clandestina ci parlavano dei massacri di Ouradour, guardavamo i soldati tedeschi che passeggiavano per le vie con aria innocua, e ci capitava di osservare tra noi: “Eppure sono uomini che ci rassomigliano: come possono fare quello che fanno?” Eravamo fieri di noi, perché riuscivamo a non capirli.
Oggi sappiamo che non c’è nulla da comprendere; tutto si è compiuto insensibilmente, con abbandoni impercettibili; quando abbiamo levato il capo, abbiamo visto nello specchio un volto sconosciuto, odioso: il nostro. Atterriti dallo stupore, i francesi scoprono questa evidenza terribile: se niente vale a proteggere una nazione contro se stessa -né il suo passato, né le sue fedeltà, né le sue proprie leggi,- se bastano quindici anni per cambiare le vittime in carnefici, allora chi decide è l’occasione; basta l’occasione a trasformare la vittima in carnefice: qualsiasi uomo, in qualsiasi momento.
Felici quelli che sono morti senza aver mai dovuto domandarsi: “Se mi strappano le unghie, parlerò?” Ma più felici quelli che non sono stati costretti, usciti appena dall’infanzia, a porsi l‘altra domanda: “Se i miei amici, i miei compagni d’armi, i miei capi strappano le unghie a un nemico dinanzi ai miei occhi, cosa farò?”
Che sanno di loro stessi questi giovani messi con le spalle al muro dalle circostanze? Essi indovinano che qualsiasi decisione possano prendere qui, sembrerà loro astratta e vuota nel momento decisivo; che tutto il loro essere sarà rimesso in gioco da situazioni imprevedibili; e che le loro decisioni per la Francia, per se stessi, dovranno prenderle laggiù, da soli. Essi partono. Altri ritornano, dopo aver sperimentato la propria impotenza, serbando nella maggior parte dei casi un silenzio pieno di rancore. Nasce la paura: la paura degli altri e di se stessi, e dilaga in ogni ambiente. La vittima e il boia si confondono nella nostra stessa immagine. Poiché, nei casi estremi, l’unica maniera di rifiutare una delle due parti consiste nell’accettare l’altra.
Una tale scelta non si impone -almeno non ancora- ai francesi in Francia. Ma proprio queste indeterminatezza ci pesa: noi siamo la ferita e il coltello: l’orrore di questo e il terrore di quella si bilanciano e si rafforzano reciprocamente. I ricordi riaffiorano.  Quindici anni or sono i migliori della nostra Resistenza avevano paura di non resistere alla sofferenza, più che della sofferenza stessa. Essi dicevano :” Quando tace, la vittima salva ogni cosa; ma quando parla, nessuno ha diritto di giudicarla, neppure colui che non ha parlato: essa s’accoppia col suo carnefice, diventa la sua femmina, e questa coppia allacciata sprofonda nella notte dell’abiezione”. L’abiezione ritorna.
Quindici anni or sono i migliori della nostra Resistenza avevano paura di non resistere alla sofferenza, più che della sofferenza stessa. Essi dicevano :” Quando tace, la vittima salva ogni cosa; ma quando parla, nessuno ha diritto di giudicarla, neppure colui che non ha parlato: essa s’accoppia col suo carnefice, diventa la sua femmina, e questa coppia allacciata sprofonda nella notte dell’abiezione”. L’abiezione ritorna.
A El-Biar, essa ritorna ogni notte. In Francia è la fuliggine dei nostri cuori. Ecco, una propaganda sussurrata insinua appunto che “tutti parlano”; e così la tortura si giustifica con l’umana ignoranza: ciascuno di noi essendo un traditore potenziale, il boia che è in ciascuno di noi trova giustificazione. Tanto più che la gloria della Francia lo esige, come voci suadenti insinuano ogni giorno. Un buon patriota non può avere che buona coscienza. Solo un disfattista può averla cattiva.
Allora, lo sbigottimento diviene disperazione: se il patriottismo deve precipitarci all’abiezione, se nessuna sorveglianza, mai, ha impedito alle nazioni e all’umanità tutta di perdersi in una follia disumana, allora, a che scopo tormentarci per divenire o rimanere degli uomini? Essere disumani è la nostra verità.
Ma se di vero non c’è altro che il terrore, terrorizzare o essere terrorizzati, a che scopo vivere e restare patrioti?
Questi pensieri sono stati seminati in noi con la violenza. Nella loro oscurità e nella loro falsità, discendono tutti da questa premessa: l’uomo è inumano. Il loro obiettivo è convincerci della nostra impotenza, e ci riusciranno, finché non li guarderemo in faccia. Ma bisogna che all’estero si sappia che il nostro silenzio non significa consenso. Esso deriva da angosce provocate, esasperate, sapientemente dirette. Lo sapevo da tempo, ma aspettavo la prova decisiva.
Essa è venuta.
 Quindi giorni fa, presso le Editions de Minuit, usciva un libro: La Tortura.
Quindi giorni fa, presso le Editions de Minuit, usciva un libro: La Tortura.
Il suo autore, Henri Alleg, tuttore detenuto in una prigione di Algeri, racconta senza commenti inutili, con precisione ammirevole, gli “interrogatori” che ha subito. I carnefici, come gli avevano promesso, lo hanno “curato”: “telefono da campo”, supplizio dell’acqua come al tempo della Brinvilliers, ma coi perfezionamenti tecnici del nostro tempo, supplizio del fuoco, della sete, etc.
E’ un libro che sconsigliamo alle anime tenere.
Finora, solo qualche richiamato alle armi e soprattutto qualche sacerdote avevano osato portare testimonianze. Avevano vissuto in mezzo ai torturatori, loro e nostri fratelli. Delle vittime, per lo più. Non conoscevano che le urla, le ferite, le sofferenze; additavano i segni del sadismo su brandelli di carne. Ma che cosa ci distingueva da questi sadici? Nulla, dal momento che tacevamo.
La nostra indignazione poteva anche parerci sincera: ma avremmo saputo provarla vivendo laggiù, o non ci saremmo piuttosto abbandonati a una cupa rassegnazione, a un universale disgusto? Per mio conto, leggevo talvolta per dovere e magari pubblicavo, ma detestandomi, quei racconti, che ci mettevano spietatamente in causa, e che non ci lasciavano speranza.
Con La Tortura, tutto cambia. Alleg ci risparmia vergogna e disperazione, perché è una vittima e ha “vinto” la tortura.  C’è un sinistro umorismo, in questo rovesciamento di posizioni; lo hanno martirizzato in nome nostro, e noi, grazie a lui, ritroviamo un poco della nostra fierezza: siamo fieri che sia un francese. I lettori si incarnano in lui con passione, l’accompagnano sino al passo estremo della sofferenza. Con lui, soli e nudi, lottano e resistono. Sarebbero questi lettori, saremmo noi capaci davvero di tanto? Questo è un altro affare. Quello che conta è che la vittima ci libera facendoci scoprire, come lo scopre lei stessa, che abbiamo la possibilità e il dovere di sopportare tutto.
C’è un sinistro umorismo, in questo rovesciamento di posizioni; lo hanno martirizzato in nome nostro, e noi, grazie a lui, ritroviamo un poco della nostra fierezza: siamo fieri che sia un francese. I lettori si incarnano in lui con passione, l’accompagnano sino al passo estremo della sofferenza. Con lui, soli e nudi, lottano e resistono. Sarebbero questi lettori, saremmo noi capaci davvero di tanto? Questo è un altro affare. Quello che conta è che la vittima ci libera facendoci scoprire, come lo scopre lei stessa, che abbiamo la possibilità e il dovere di sopportare tutto.
Eravamo come affascinati dalla vertigine dell’inumano, ma basta che un uomo duro e ostinato -ostinato nel suo mestiere d’uomo- a strapparti all’incantesimo: la “tortura” non è nulla di inumano, è soltanto un crimine ignobile e lurido, commesso da uomini contro altri uomini, e che altri uomini ancora possono e debbono reprimere. L’inumano non esiste, se non negli incubi generati dalla paura. Basta il calmo coraggio di una vittima, la sua modestia, la sua lucidità, per liberarci dalla mistificazione. Alleg ha strappato la tortura alla notte che la ricopriva:; avviciniamoci, guardiamola alla luce.
Questi carnefici, prima di tutto, che cosa sono? Dei sadici? Degli arcangeli irritati? Dei signori della guerra con i loro terrificanti capricci? A creder loro, sarebbero una mescolanza di tutto questo. Ma Alleg, appunto, non li crede. Quel che risulta da quanto egli ci riferisce è che essi vorrebbero convincere se stessi e convincere la vittima di una loro piena sovranità: ora come superuomini che tengono dei semplici uomini in loro potere, ora come uomini forti e severi, incaricati di addomesticare la bestia più oscena, più feroce e più vile che ci sia, la bestia umana. S’indovina che non fanno tuttavia scelte sottili: l’essenziale è far sentire al prigioniero che non è della loro razza_ lo si spoglia, lo si imbavaglia, lo si beffeggia. Intanto, dei soldato vanno e vengono, pronunciando insulti e minacce con una disinvoltura che vorrebbe apparire terribile.
Ma Alleg, nudo, tremante di freddo, legato a una tavola ancor nera e viscida di vecchi vomiti, riduce tutte queste manovre alla loro miserabile verità: sono commedie recitate da imbecilli. Commedia, la violenza fascista delle loro parole, i il giuramento di “buttare all’aria la Repubblica”. Commedia, il discorso  dell’aiutante di campo del generale M., che termina con queste parole: “Non vi resta più che suicidarvi”. Commedie grossolane, sempre quelle, che ricominciano senza convinzione ogni notte, con ogni prigioniero, e che poi si smettono per mancanza di tempo. Perché questi orribili lavoratori sono sovraccarichi di lavoro e fatica: i prigionieri fanno la coda davanti alla tavola del supplizio, si legano, si slegano, si portano in giro le vittime da una camera di tortura all’altra. A guardare con gli occhi di Alleg questo immondo alveare ci si accorge che gli stessi torturatori sono soverchiati da ciò che fanno.
dell’aiutante di campo del generale M., che termina con queste parole: “Non vi resta più che suicidarvi”. Commedie grossolane, sempre quelle, che ricominciano senza convinzione ogni notte, con ogni prigioniero, e che poi si smettono per mancanza di tempo. Perché questi orribili lavoratori sono sovraccarichi di lavoro e fatica: i prigionieri fanno la coda davanti alla tavola del supplizio, si legano, si slegano, si portano in giro le vittime da una camera di tortura all’altra. A guardare con gli occhi di Alleg questo immondo alveare ci si accorge che gli stessi torturatori sono soverchiati da ciò che fanno.
Certo, sanno che atteggiarsi alla calma, bere birra, tranquilli e decisi, accanto a un corpo martirizzato, e poi d’un tratto balzano in piedi, corrono dappertutto, bestemmiano e urlano di rabbia: dei nevrotici che sarebbero delle vittime eccellenti, e alla prima sferzata confesserebbero.
Malvagi, rabbiosi, certo. Sadici? No, nemmeno sadici: hanno troppa fretta. E’ quella che li salva, del resto: resistono grazie alla velocità acquistata: debbono correre senza requie o crollare.
Eppure amano il lavoro ben fatto: se lo giudicano necessario, spingono la coscienza professionale fino ad uccidere. Ed ecco quello che colpisce, nella narrazione di Alleg: dietro questi chirurghi squallidi e sgomenti senti una inflessibilità che li supera, loro e i loro capi.
Sarebbe troppa fortuna, se questi delitti fossero l’opera di un pugno di pazzi. In verità è la tortura, che fa i carnefici. Dopo tutto, questi soldati non si erano arruolati in un corpo scelto per martirizzare il nemico vinto.
Alleg, in pochi tratti, ci descrive quelli che ha conosciuto, e questo basta a segnare le tappe delle metamorfosi.
Ci sono i più giovani, sbigottiti, incapaci di resistere, che mormorano “è orribile” quando la loro torcia illumina un suppliziato.  E poi ci sono i sotto-boia, che non mettono ancora mano alla tortura, ma sostengono e trasportano i prigionieri, alcuni già induriti e altri no, ma tutti già presi nell’ingranaggio, e tutti imperdonabili.
E poi ci sono i sotto-boia, che non mettono ancora mano alla tortura, ma sostengono e trasportano i prigionieri, alcuni già induriti e altri no, ma tutti già presi nell’ingranaggio, e tutti imperdonabili.
C’è un biondino del Nord con un viso così simpatico, che può parlare delle sedute di tortura che Alleg ha subito, “come di una partita di cui si ricorda con piacere, e che non prova disagio a congratularsi con la vittima come farebbe con un campione ciclista”. Qualche giorno dopo, Alleg lo ritroverà congestionato, sfigurato dall’odio, mentre percuote, su per una scala, un musulmano. E poi ci sono gli specialisti, i duri che fanno tutto il lavoro, che si compiacciono ai soprassalti, i duri che fanno tutto il lavoro, che si compiacciono ai soprassalti delle scosse elettriche, ma che non sopportano le grida. E infine i pazzi che corrono intorno come foglie morte nel turbine della loro propria violenza.
Nessuno di questi uomini ha una vita sua, nessuno resterà quello che è: non sono che i momenti di una trasformazione inesorabile. Tra i migliori e i peggiori v’è una sola differenza: i primi sono reclute, i secondi veterani. Tutti finiranno per andarsene e, se la guerra continua, altri li sostituiranno: biondini del Nord o piccoli bruni del Mezzogiorno, che faranno lo stesso tirocinio o ritroveranno la stessa violenza con lo stesso nervosismo.
In quest’affare gli individui non contano; una specie di odio errante e anonimo, un odio radicale dell’uomo s’accanisce a un tempo sui carnefici e sulle vitime per degradarli insieme, gli uni mediante gli altri. Quest’ odio è la tortura eretta a sistema, creatrice dei suoi stessi strumenti.
Quando questo vien detto, sia pur timidamente, sui banchi dell’Assemblea, la canea si scatena, e urla: “E’ un insulto all’esercito”. Ma una volta per tutte, questi cani ringhiosi ci dicano: che c’entra l’esercito? Nell’esercito ci sono dei torturatori, senza dubbio. La commissione inchiesta, nel suo rapporto pur indulgente, non lo ha nascosto. Ma questo non vuol dire che sia l’esercito a torturare.
Che insensatezza! Forse che i civili non conoscono il metodo? Basta lasciar fare alla polizia di Algeri. E poi ci vuole un capo-carnefice, l’Assemblea intera  l’ha designato: non è il generale S., e neppure il generale E., e neppure il generale M., di cui tuttavia Alleg fa il nome: è Lacoste, l’uomo dai pieni poteri.
l’ha designato: non è il generale S., e neppure il generale E., e neppure il generale M., di cui tuttavia Alleg fa il nome: è Lacoste, l’uomo dai pieni poteri.
Tutto si fa attraverso di lui e con lui, a Bona come a Orano: tutti gli uomini che sono morti di sofferenze e di orrore nell’immobile di El-Biar, nella villa S., sono morti per sua volontà. Non sono io che lo dico: sono i deputati, è il governo.
E del resto la cancrena si estende, ha attraversato il mare. Si è sparsa anche la voce che si pratica la tortura in certe prigioni civili del “territorio metropolitano”: non so se sia fondata, ma dev’essere stata raccolta anche dai poteri pubblici, visto che il procuratore, al processo di Ben Saddok, ha domandato solennemente all’accusato se avesse subito sevizie. Beninteso, la risposta era conosciuta in anticipo.
No, la tortura non è né civile né militare né specificatamente francese: è come una sifilide che devasta l’intera epoca. All’est come all’ovest ci sono carnefici. Non è passato tanto tempo da quando Farkas torturava gli ungheresi. I polacchi non nascondono che la loro polizia , prima di Poznan, torturava anch’essa volentieri; e su ciò che accadeva in URSS al tempo di Stalin abbiamo la testimonianza irrecusabile del rapporto Krusciov. Ieri si “interrogavano” così, nelle prigioni di Nasser, degli uomini politici che poi sono stati, con qualche cicatrice, elevati a cariche eminenti. L’elenco potrebbe continuare. Oggi, comunque, è il momento di Cipro e dell’Algeria; e Hitler, insomma, non era che un precursore.
Sconfessata – a volte, del resto, senza molta energia – ma sistematicamente applicata dietro la facciata della legalità democratica, la tortura può definirsi un’istituzione semiclandestina. Ha forse le stesse cause dappertutto? No, probabilmente. E poi poco importa: qui non si tratta di giudicare il nostro tempo; si tratta di guardare in faccia le cose nostre per cercar di capire che cosa è successo a noi, a noi francesi.
Sapete quel che si dice a volte per giustificare i carnefici: bisogna pur ridursi a torturare un uomo se dalla sua confessione possono dipendere centinaia di vite umane. E’ un bell’espediente da Tratuffe. Alleg, come Audin, non era un terrorista. Tanto è vero che è stato accusato di “attentato alla sicurezza dello Stato e di ricostruzione di una lega sciolta”.
Era per salvare delle vite umane che gli si bruciavano i capezzoli e i peli del pube? No, si voleva soltanto estorcergli l’indirizzo dell’amico che lo aveva ospitato. Se avesse parlato, si sarebbe messo un comunista di più sotto chiave: ecco tutto.
E poi si arresta a casaccio: qualsiasi musulmano è “interrogabile” a piacere: la maggior parte dei torturati non dicono nulla perché non hanno nulla da dire, a meno che non acconsentano, per non soffrire di più, a fare una falsa testimonianza o accusarsi gratuitamente di un delitto rimasto impunito, del quale diventa comodo accusarli. In quanto a quelli che potrebbero parlare, si sa bene che tacciono. Tutti, o quasi tutti.
Né Audin, né Alleg, né Guerroudji hanno disserrato i denti. “Ha comunque guadagnato una notte per dar tempo ai suoi amici di tagliare la corda”, constata uno dei carnefici dopo il primo interrogatorio di Alleg. E un ufficiale, qualche giorno più tardi: “Da dieci o da quindici anni sanno che se vengono presi non devono dire nulla. Non c’è niente da fare per togliere loro quest’idea della testa.” Forse volevan parlare soltanto dei comunisti; ma credono forse che i combattenti dell’ALN (l’Armata di Liberazione Nazionale) siano di un’altra tempra? Queste violenze non rendono: gli stessi tedeschi, nel 1944, avevano finito per convincersene; costano vite umane, e non ne salvano.
L’argomento, tuttavia, non è del tutto falso, e comunque ci illumina sulla funzione della tortura , istituzione clandestina o semiclandestina indissolubilmente legata alla clandestinità della resistenza o dell’opposizione.
In Algeria, il nostro esercito è schierato in tutto il territorio. Abbiamo per noi il numero, il denaro, le armi. Gli insorti non hanno nulla, salvo la fiducia e l’appoggio di una gran parte della popolazione. Siamo stati noi, nostro malgrado, a dare a questa guerra popolare attentati nelle città, imboscate nelle campagne; il FLN non ha scelto lui questa forma di attività, fa quello che può e basta.
Il rapporto fra le sue forme e le nostre lo costringe ad attaccarci di sorpresa: invisibili, inafferrabili, inattese, devono colpire e scomparire, per non essere sterminate. Di qui il nostro malessere: lottiamo contro un avversario segreto, una mano lancia una bomba in una strada, una fucilata ferisce un nostro soldato, si accorre: non c’è più nessuno. Più tardi, nei dintorni, si troveranno dei musulmani che non hanno visto niente. Tutto è legato: la guerra popolare, guerra dei poveri contro i ricchi, è caratterizzata dallo stretto vincolo delle unità insurrezionali con la popolazione. Per l’esercito regolare e o poteri civili, questo nugolo di miserabili diventa il nemico quotidiano, innumerevole. Le truppe d’occupazione si preoccupano del mutismo che esse hanno generato. Si indovina una inafferrabile volontà di silenzio, un segreto circolare, onnipresente. I ricchi si sentono braccati in mezzo ai poveri che tacciono. Imbarazzate dalla loro stessa potenza, le “forze dell’ordine” non possono opporre nulla alle guerriglie, se non i rastrellamenti e le spedizioni punitive, nulla da opporre al terrorismo, se non il terrore- Qualche cosa è nascosto: in qualsiasi luogo e da tutti.
Bisogna farli parlare.
 La tortura è una vana furia, nata dalla paura: si vuole strappare, ad una bocca, in mezzo alle grida e ai rigurgiti di sangue, il segreto di tutti. Inutile violenza: che la vittima parli o che muoia sotto le torture, l’innumerevole segreto è altrove, sempre altrove, fuori portata. Il carnefice si trasforma in Sisifo. Se applica la question dovrà sempre ricominciare.
La tortura è una vana furia, nata dalla paura: si vuole strappare, ad una bocca, in mezzo alle grida e ai rigurgiti di sangue, il segreto di tutti. Inutile violenza: che la vittima parli o che muoia sotto le torture, l’innumerevole segreto è altrove, sempre altrove, fuori portata. Il carnefice si trasforma in Sisifo. Se applica la question dovrà sempre ricominciare.
Ma nemmeno questi silenzi, queste paura, questi pericoli sempre invisibili e sempre presenti possono giustificare completamente l’accanimento dei carnefici, la loro volontà di ridurre all’abiezione le loro vittime, questo odio dell’uomo, infine, che si è impadronito di loro senza il loro consenso e li ha plasmati.
Uccidersi a vicenda, è la regola; ci si è sempre battuti per interessi collettivi e particolaristici. Ma nella tortura, questo strano match, la posta sembra essere totale: è per il titolo di uomo che il carnefice si misura col torturato, e tutto si svolge come se i due non potessero appartenere insieme alla specie umana. Scopo dell’interrogatorio non è soltanto quello di costringere un uomo a parlare, a tradire: bisogna che la vittima si auto qualifichi bestia umana attraverso le sue grida e la sua sottomissione: agli occhi di tutti e davanti a se stessa. Bisogna che il suo tradimento la spezzi e la tolga definitivamente di mezzo. Colui che cede all’interrogatorio, non soltanto è costretto a parlare, ma gli è stato imposto per sempre uno status: quello del sotto-uomo.
Questa radicalizzazione della posta è uno dei caratteri del nostro tempo. In nessuna epoca la volontà di essere liberi è stata più cosciente e più forte: in nessuna epoca l’oppressione è stata più violenta e meglio armata.
In Algeria le contraddizioni sono irriducibili: ognuno dei gruppi in conflitto esige l’esclusione radicale dell’altro. Abbiamo preso tutto ai musulmani e poi abbiamo proibito loro persino l’uso della loro lingua. Memmi, lo scrittore algerino, ha dimostrato come la colonizzazione si realizza attraverso l’annullamento dei colonizzati. Essi non possedevano più nulla, non erano più nessuno: abbiamo liquidato la loro civiltà rifiutando loro la nostra. Avevano chiesto l’integrazione, l’assimilazione e noi abbiamo risposto di no: grazie a quale miracolo si potrebbe mantenere il supersfruttamento coloniale se i colonizzati dovessero godere degli stessi diritti dei coloni? Sotto-alimentati, incolti, miserabili, il sistema li respingeva spietatamente ai confini del Sahara, ai limiti dell’umano; sotto la spinta demografica il loro tenore di vita si abbassava di anno in anno. Quando la disperazione li ha indotti alla rivolta, questi sotto-uomini non avevano altra scelta che morire o tentare di affermare la loro umanità contro di noi: hanno respinto i nostri valori, la nostra cultura, le nostre pretese superiorità, e in blocco hanno rivendicato il titolo di uomini e rifiutato la nazionalità francese.
Questa ribellione non si limitava a contestare il potere dei coloni. Essi hanno capito che era in causa la loro stessa esistenza. Per la maggior parte degli europei d’Algeria ci sono due verità complementari e inseparabili: i coloni sono degli uomini per diritto divino,  gli indigeni sono una sottospecie di uomini. E’ la traduzione mitica di un fatto preciso, poiché la ricchezza degli uni poggia sulla miseria degli altri.
gli indigeni sono una sottospecie di uomini. E’ la traduzione mitica di un fatto preciso, poiché la ricchezza degli uni poggia sulla miseria degli altri.
Così lo sfruttamento mette lo sfruttatore alla dipendenza dello sfruttato. E, su un altro piano, questa dipendenza è il nocciolo del razzismo, è la sua contraddizione profonda e la sua acida maledizione: essere uomo, per l’europeo di Algeri, vuol dire, innanzitutto, essere superiore al musulmano.
Ma se il musulmano si afferma a sua volta come uomo, come l’eguale del colono? Ebbene il colono è leso nel suo essere, si sente diminuito, svalutato: l’accesso dei bougnoules (termine dispregiativo per definire gli arabi) alle condizioni di uomini gli ripugna non soltanto perché ne vede le conseguenze economiche ma perché gli si annunzia il suo decadimento personale. Nella sua rabbia il colono sogna il genocidio. Ma è una pura utopia. Egli lo sa, conosce la propria dipendenza. Che cosa farebbe senza un sottoproletario indigeno, senza una manodopera in eccesso, senza la disoccupazione cronica che gli permette di imporre i salari? E poi, se i musulmani sono già degli uomini, tutto è perduto, non c’è nemmeno più bisogno di sterminarli. No: la cosa più urgente, se c’è ancora tempo, è di umiliarli, di stroncare l’orgoglio nel loro cuore, di abbassarli al livello della bestia.
Si lascerà vivere il corpo, ma si ucciderà lo spirito. Domare, addomesticare, castigare, ecco le parole che ossessionano il colono. Non c’è posto in Algeria per due specie umane. Tra l’una e l’altra bisogna scegliere.
Beninteso, non intendo dire che gli europei di Algeri abbiano inventato la tortura, e nemmeno che abbiano incitato le autorità civili e militari a praticarla. Al contrario: la tortura si è imposta da sé, è diventata una pratica prima ancora che ci se ne accorgesse. Ma l’odio per l’uomo che vi si manifesta, è l’espressione del razzismo. Poiché è proprio l’uomo che si vuol distruggere, con tutte le sue doti di uomo, il coraggio, la volontà, l’intelligenza, la fedeltà, quelle stesse doti che il colono rivendica per sé. Ma se l’europeo trascende sino a detestare la propria immagine, vuol dire che essa è rispecchiata da un arabo.
 Così, di queste due coppie indissolubilmente legate, il colono e il colonizzato, il carnefice e la sua vittima, la seconda è un’emancipazione della prima. I carnefici non sono coloni, né i coloni sono carnefici. Questi ultimi sono spesso giovanotti che vengono dalla Francia e hanno passato vent’anni della loro vita senza mai preoccuparsi del problema algerino. Ma laggiù l’odio è un campo di forze magnetiche che li ha attraversati, corrosi e asserviti.
Così, di queste due coppie indissolubilmente legate, il colono e il colonizzato, il carnefice e la sua vittima, la seconda è un’emancipazione della prima. I carnefici non sono coloni, né i coloni sono carnefici. Questi ultimi sono spesso giovanotti che vengono dalla Francia e hanno passato vent’anni della loro vita senza mai preoccuparsi del problema algerino. Ma laggiù l’odio è un campo di forze magnetiche che li ha attraversati, corrosi e asserviti.
La calma lucidità di Alleg ci permette di comprendere tutto ciò. Quand’anche non ci desse altro, bisognerebbe essergliene profondamente grati. Ma in realtà egli ha fatto molto di più: incutendo rispetto ai suoi carnefici ha fatto trionfare l’umanesimo delle vittime e dei colonizzati contro le violenze senza misura di certi militari, contro il razzismo dei coloni. E la parola “vittime” non vale qui a suscitare non so quale lacrimoso pietismo: in mezzo ai loro piccoli caid, fieri della loro giovinezza, della loro forza, del loro numero, Alleg è il solo “duro”, il solo veramente forte. Noi possiamo dire che ha pagato il prezzo più alto per il semplice diritto di rimanere un uomo fra gli uomini. Ma egli non vi pensa neppure. E’ per questo che tanto ci commuove questa semplice frase alla fine di un paragrafo: “Mi sentii tutt’a un tratto fiero e contento di non aver ceduto. Ero convinto che avrei resistito ancora se avessero ricominciato, che mi sarei battuto fino in fondo, che non avrei facilitato il loro compito suicidandomi.”
Si, un duro, che finisce per far paura agli arcangeli dell’ira.
Almeno in alcune delle loro parole, si intuisce che essi presentono e cercano di scongiurare una vaga e scandalosa rivelazione: quando è la vittima che trionfa, addio sovranità, addio diritto divino. Le ali degli arcangeli si fermano e i carnefici si chiedono perplessi: ma io saprei resistere se mi torturassero?
Il fatto è che, al momento della vittoria, un sistema di valori si è sostituito agli altro. Per poco gli stessi carnefici non sono presi dalla vertigine. Ma no: hanno la testa vuota, il lavoro li abbrutisce e credono appena a ciò che fanno.
Perché poi, del resto, turbare la coscienza dei carnefici?
Se qualcuno di loro muovesse obiezione, i loro capi lo sostituirebbero: ne troverebbero dieci per uno perduto. La testimonianza di Alleg infatti – ed è forse il suo maggiore merito – dissipa completamente le nostre illusioni: non basta punire o rieducare alcuni individui.
La guerra d’Algeria non può essere umanizzata. La tortura si è imposta da sé: è stata suggerita dalle circostanze, chiamata dall’odio razzista. In certa misura, come abbiamo visto, essa si trova al centro stesso del conflitto e forse ne esprime la verità più profonda. Se vogliamo mettere fine a queste immonde e lugubri crudeltà, salvare la Francia dalla vergogna e gli algerini dall’inferno, abbiamo un solo mezzo, sempre lo stesso, il solo che abbiamo mai avuto, il solo che avremo mai: aprire dei negoziati, fare la pace.
Jean-Paul Sartre






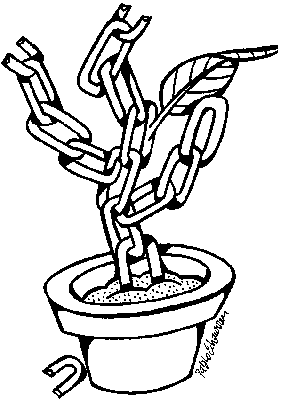

 colpevoli solo di lottare per avere il diritto di vivere, e che per questo occupavano da 14 mesi i locali della Bourse du travail di Parigi, vuol dire che questa sinistra non ha più nulla da dire. È morta. È un cadavere putrefatto. Una sinistra che è solo apparato. Che pensa solo ai suoi «beni». È successo mercoledì scorso verso le 12.30, quando una cinquantina di uomini col cranio rasato, il volto coperto, gli occhi protetti da occhialini da piscina e una fascia rossa al braccio, sono entrati con la forza nei locali della camera del lavoro vicino place de la Republique, e armati di bastoni hanno cosparso di gas lacrimogeno, inseguito e pestato i presenti, trascinandoli verso l’esterno (il grosso degli occupanti era impegnato a manifestare davanti alla prefettura). I testimoni raccontano di aver assistito a scene d’intensa violenza. «Era previsto e l’abbiamo fatto!», dichiara soddisfatto uno dei picchiatori. Increduli e scioccati, i circa 800 sans papiers carichi di fagotti e materassi fanno molta fatica a credere che la violenta aggressione abbia come origine proprio la Cgt, per altro spalleggiata dall’arrivo di decine di furgoni e centinaia di uomini della polizia schierati in assetto antisommossa. All’inizio molti passanti e commercianti avevano temuto un’aggressione lepenista. «Dopo aver tentato per mesi di negoziare una soluzione abbiamo deciso di mettere fine all’occupazione», si è giustificato Patrick Picard, segretario generale dell’Unione dipartimentale di Parigi. Da tempo il sindacato intratteneva relazioni molto tese con gli occupanti, in massima parte lavoratori di ditte di pulizie. Questi avevano deciso di riunirsi in un collettivo autonomo, il coordinamento sans papiers 75, rivendicando una regolarizzazione generale e non dei soli aderenti al sindacato.
colpevoli solo di lottare per avere il diritto di vivere, e che per questo occupavano da 14 mesi i locali della Bourse du travail di Parigi, vuol dire che questa sinistra non ha più nulla da dire. È morta. È un cadavere putrefatto. Una sinistra che è solo apparato. Che pensa solo ai suoi «beni». È successo mercoledì scorso verso le 12.30, quando una cinquantina di uomini col cranio rasato, il volto coperto, gli occhi protetti da occhialini da piscina e una fascia rossa al braccio, sono entrati con la forza nei locali della camera del lavoro vicino place de la Republique, e armati di bastoni hanno cosparso di gas lacrimogeno, inseguito e pestato i presenti, trascinandoli verso l’esterno (il grosso degli occupanti era impegnato a manifestare davanti alla prefettura). I testimoni raccontano di aver assistito a scene d’intensa violenza. «Era previsto e l’abbiamo fatto!», dichiara soddisfatto uno dei picchiatori. Increduli e scioccati, i circa 800 sans papiers carichi di fagotti e materassi fanno molta fatica a credere che la violenta aggressione abbia come origine proprio la Cgt, per altro spalleggiata dall’arrivo di decine di furgoni e centinaia di uomini della polizia schierati in assetto antisommossa. All’inizio molti passanti e commercianti avevano temuto un’aggressione lepenista. «Dopo aver tentato per mesi di negoziare una soluzione abbiamo deciso di mettere fine all’occupazione», si è giustificato Patrick Picard, segretario generale dell’Unione dipartimentale di Parigi. Da tempo il sindacato intratteneva relazioni molto tese con gli occupanti, in massima parte lavoratori di ditte di pulizie. Questi avevano deciso di riunirsi in un collettivo autonomo, il coordinamento sans papiers 75, rivendicando una regolarizzazione generale e non dei soli aderenti al sindacato.











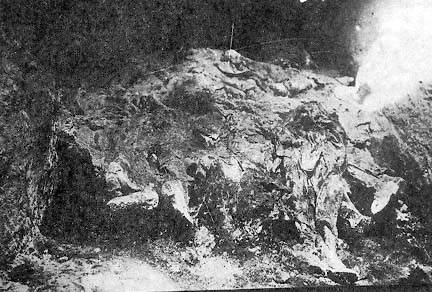



















 A Verona la giunta comunale ha istituito gli «assistenti civici», ad Udine la Lega ha annunciato la creazione di ronde entro il mese. A Milano come a Napoli agiscono da tempo i City angels e i Blue berets. A Torino e Ferrara giovani di An sono scesi in strada, mentre a Trieste Fiamma tricolore sta organizzando ronde intitolate alla memoria di Ettore Muti. A Bologna ci sono state iniziative episodiche di An, Forza nuova e Lega. A Forlì la Lega ha creato delle «ronde civiche». A Roma invece è molto attiva la Destra di Storace che ha sguinsagliato i propri militanti e annunciato la nascita di «ronde rosa» nel quartiere dell’Eur. Il più delle volte si tratta d’effetti d’annuncio, scimmiottamenti mediatici con pettorine colorate di fronte a tv e fotografi, ma la tendenza a strutturare “squadrette”, camuffando un rinnovato squadrismo sotto le vesti delle milizie cittadine volontarie, è ormai avviata, al punto che anche La Russa, il ministro della Difesa che inizialmente aveva dato voce alle perplessità dell’arma dei carabinieri, ora si è detto favorevole. Anche lui prevede che i civili possano far parte dei cosiddetti «pattuglioni», ovvero una militarizzazione del territorio allargato non solo alla presenza di polizia e carabinieri, ma all’esercito, che già sorveglia i semafori, e alla polizia penitenziaria, guardia di finanza, forestale (e perché no anche ai guardiacaccia e guardiapesca?). Un’Italia, insomma, che assomigli sempre più al piazzale di una caserma con adunate e alzabandiera mattutini.
A Verona la giunta comunale ha istituito gli «assistenti civici», ad Udine la Lega ha annunciato la creazione di ronde entro il mese. A Milano come a Napoli agiscono da tempo i City angels e i Blue berets. A Torino e Ferrara giovani di An sono scesi in strada, mentre a Trieste Fiamma tricolore sta organizzando ronde intitolate alla memoria di Ettore Muti. A Bologna ci sono state iniziative episodiche di An, Forza nuova e Lega. A Forlì la Lega ha creato delle «ronde civiche». A Roma invece è molto attiva la Destra di Storace che ha sguinsagliato i propri militanti e annunciato la nascita di «ronde rosa» nel quartiere dell’Eur. Il più delle volte si tratta d’effetti d’annuncio, scimmiottamenti mediatici con pettorine colorate di fronte a tv e fotografi, ma la tendenza a strutturare “squadrette”, camuffando un rinnovato squadrismo sotto le vesti delle milizie cittadine volontarie, è ormai avviata, al punto che anche La Russa, il ministro della Difesa che inizialmente aveva dato voce alle perplessità dell’arma dei carabinieri, ora si è detto favorevole. Anche lui prevede che i civili possano far parte dei cosiddetti «pattuglioni», ovvero una militarizzazione del territorio allargato non solo alla presenza di polizia e carabinieri, ma all’esercito, che già sorveglia i semafori, e alla polizia penitenziaria, guardia di finanza, forestale (e perché no anche ai guardiacaccia e guardiapesca?). Un’Italia, insomma, che assomigli sempre più al piazzale di una caserma con adunate e alzabandiera mattutini.

 per non dimenticare il genocidio, la patria e la resistenza.
per non dimenticare il genocidio, la patria e la resistenza. 

 Questi «onorevoli politici», a 25 mila euro al mese e vitalizio assicurato, hanno intasato le agenzie di compiaciute e sarcastiche dichiarazioni sul mancato riconoscimento della pensione Inps a Renato Curcio (l’ex fondatore delle Br che da anni ha terminato di scontare la condanna). Pure alcuni familiari delle vittime si sono lasciati trascinare in questo stupidario. Cosa era successo? Curcio si trovava a Pesaro, centro sociale Oltreconfine. Stava presentando uno degli ultimi libri della sua casa editrice, Sensibili alle foglie. Un po’ scherzosamente un giornalista gli ha chiesto se era prossimo alla pensione e lui ha risposto che nonostante avesse lavorato una vita in carcere, l’Inps non gli ha riconosciuto alcun diritto alla pensione perché gli istituti di pena dove è stato recluso non hanno mai versato i contributi o questi erano bassissimi. Insomma una truffa bella e buona. Ha poi aggiunto che non può avere diritto nemmeno alla pensione sociale perché la moglie percepisce un reddito troppo alto. Tutto qui. Nessuna protesta, nessuna lamentela. Solo una breve considerazione, per giunta sollecitata, di una persona che fa il suo lavoro senza chiedere nulla a nessuno. La pensione, come sanno tutti quelli che lavorano, non è certo una gentile concessione dello Stato, un regalo o un premio del Padrone, ma il dovuto che il lavoratore vede ritirare ogni mese dal suo stipendio, debitamente rivalutato secondo indici stabiliti per legge. Si chiama sistema per “ripartizione”. È roba sua insomma, prestata alle casse previdenziali che in questo modo sostengono quel po’ di welfare ancora in piedi. Anche le polemiche più inutili e strumentali possono servire. Questa vicenda apre uno scorcio sul mondo opaco delle carceri, sulla fragilità dei diritti dei detenuti che lavorano. La disavventura accaduta a Curcio non è un fatto isolato. Il carcere ha bisogno dei suoi detenuti perché sia autosufficiente e si riproduca ogni giorno, affinché le aree comuni della prigione, corridoi, uffici, passeggi, laboratori, matricola, caserma, siano sempre pulite e le cucine sfornino una colazione e due pasti al dì, i guasti elettrici, idraulici vengano subito riparati. Negli istituti di pena ci sono anche officine, tipografie, falegnamerie, rilegatorie, che servono a fabbricare suppellettili per altre carceri, blindati, cancelli, mobilio per i tribunali e i ministeri, registri, formulari per gli uffici. Le prigioni non potrebbero funzionare senza i carcerati. Pochi lo sanno, i più non arrivano nemmeno ad immaginarlo, ma il carcere vive del lavoro dei suoi ospiti rinchiusi. Non potrebbe farne a meno.
Questi «onorevoli politici», a 25 mila euro al mese e vitalizio assicurato, hanno intasato le agenzie di compiaciute e sarcastiche dichiarazioni sul mancato riconoscimento della pensione Inps a Renato Curcio (l’ex fondatore delle Br che da anni ha terminato di scontare la condanna). Pure alcuni familiari delle vittime si sono lasciati trascinare in questo stupidario. Cosa era successo? Curcio si trovava a Pesaro, centro sociale Oltreconfine. Stava presentando uno degli ultimi libri della sua casa editrice, Sensibili alle foglie. Un po’ scherzosamente un giornalista gli ha chiesto se era prossimo alla pensione e lui ha risposto che nonostante avesse lavorato una vita in carcere, l’Inps non gli ha riconosciuto alcun diritto alla pensione perché gli istituti di pena dove è stato recluso non hanno mai versato i contributi o questi erano bassissimi. Insomma una truffa bella e buona. Ha poi aggiunto che non può avere diritto nemmeno alla pensione sociale perché la moglie percepisce un reddito troppo alto. Tutto qui. Nessuna protesta, nessuna lamentela. Solo una breve considerazione, per giunta sollecitata, di una persona che fa il suo lavoro senza chiedere nulla a nessuno. La pensione, come sanno tutti quelli che lavorano, non è certo una gentile concessione dello Stato, un regalo o un premio del Padrone, ma il dovuto che il lavoratore vede ritirare ogni mese dal suo stipendio, debitamente rivalutato secondo indici stabiliti per legge. Si chiama sistema per “ripartizione”. È roba sua insomma, prestata alle casse previdenziali che in questo modo sostengono quel po’ di welfare ancora in piedi. Anche le polemiche più inutili e strumentali possono servire. Questa vicenda apre uno scorcio sul mondo opaco delle carceri, sulla fragilità dei diritti dei detenuti che lavorano. La disavventura accaduta a Curcio non è un fatto isolato. Il carcere ha bisogno dei suoi detenuti perché sia autosufficiente e si riproduca ogni giorno, affinché le aree comuni della prigione, corridoi, uffici, passeggi, laboratori, matricola, caserma, siano sempre pulite e le cucine sfornino una colazione e due pasti al dì, i guasti elettrici, idraulici vengano subito riparati. Negli istituti di pena ci sono anche officine, tipografie, falegnamerie, rilegatorie, che servono a fabbricare suppellettili per altre carceri, blindati, cancelli, mobilio per i tribunali e i ministeri, registri, formulari per gli uffici. Le prigioni non potrebbero funzionare senza i carcerati. Pochi lo sanno, i più non arrivano nemmeno ad immaginarlo, ma il carcere vive del lavoro dei suoi ospiti rinchiusi. Non potrebbe farne a meno.  Diventerebbe ancora più antieconomico se dovessero essere assunti degli esterni, senza contare i problemi della sicurezza. Il miglior modo per metter a terra un carcere, infatti, è lo sciopero dei «lavoranti». Impresa ardua, riuscita in pochi casi. Ma quando i lavoranti si fermano, la direzione negozia subito. Proprio per questo il lavoro è una risorsa strategica del governo carcerario, gestito con oculato clientelismo e paternalismo. Non solo il lavoro dei detenuti è sotto tutela costituzionale ma esistono normative che ne regolano modalità e diritti. L’articolo 20 della legge penitenziaria stabilisce che «il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato», organizzazione e metodi «devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale». La durata delle prestazioni lavorative «non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale». Ed è in ragione di questa normativa che negli ultimi anni i detenuti hanno avviato delle vertenze di fronte alla magistratura del lavoro. Con la sentenza n. 158 del 2001, la Corte Costituzionale ha ribadito il diritto alle ferie e la loro remunerazione in caso di mancato usufrutto. Allo stesso modo l’associazione Papillon, grazie ad una sentenza pilota del 1993, ha ottenuto l’equiparazione delle mercedi (salario) al contratto collettivo nazionale del comparto corrispondente alla mansione lavorativa svolta. Altre battaglie sono state realizzate per il riconoscimento dell’assegno di disoccupazione. Il carcere è un grande cantiere sempre in funzione, sarebbe ora che i sindacati (Cobas e Cgil) vi aprissero degli sportelli per formare sindacalmente i detenuti e creare osservatori sui diritti del lavoro.
Diventerebbe ancora più antieconomico se dovessero essere assunti degli esterni, senza contare i problemi della sicurezza. Il miglior modo per metter a terra un carcere, infatti, è lo sciopero dei «lavoranti». Impresa ardua, riuscita in pochi casi. Ma quando i lavoranti si fermano, la direzione negozia subito. Proprio per questo il lavoro è una risorsa strategica del governo carcerario, gestito con oculato clientelismo e paternalismo. Non solo il lavoro dei detenuti è sotto tutela costituzionale ma esistono normative che ne regolano modalità e diritti. L’articolo 20 della legge penitenziaria stabilisce che «il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato», organizzazione e metodi «devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale». La durata delle prestazioni lavorative «non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale». Ed è in ragione di questa normativa che negli ultimi anni i detenuti hanno avviato delle vertenze di fronte alla magistratura del lavoro. Con la sentenza n. 158 del 2001, la Corte Costituzionale ha ribadito il diritto alle ferie e la loro remunerazione in caso di mancato usufrutto. Allo stesso modo l’associazione Papillon, grazie ad una sentenza pilota del 1993, ha ottenuto l’equiparazione delle mercedi (salario) al contratto collettivo nazionale del comparto corrispondente alla mansione lavorativa svolta. Altre battaglie sono state realizzate per il riconoscimento dell’assegno di disoccupazione. Il carcere è un grande cantiere sempre in funzione, sarebbe ora che i sindacati (Cobas e Cgil) vi aprissero degli sportelli per formare sindacalmente i detenuti e creare osservatori sui diritti del lavoro.
 questo timore oggi è tirannico.
questo timore oggi è tirannico.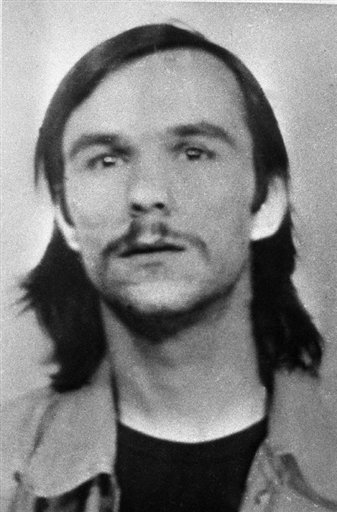
 Di sicuro, signor Presidente, in 13 anni di galera mi ha strappato alle cose più semplici. Alla vita. All’amore. Non mi ricordo neanche più dell’infinita dolcezza delle cosce di una donna.
Di sicuro, signor Presidente, in 13 anni di galera mi ha strappato alle cose più semplici. Alla vita. All’amore. Non mi ricordo neanche più dell’infinita dolcezza delle cosce di una donna.





 Lungo il corso Akademias, questo fiume cresce, si espande, tracima. In strada c’è praticamente tutta l’università. Ma non solo: sono tornati, nonostante le botte prese il giorno prima insieme agli insegnanti davanti al Parlamento, i liceali. E sono tornati in forze. Molte scuole sono già state occupate la sera prima dello sciopero. Poi, una partecipazione molto meno determinabile, ma non meno eloquente. Le tribù dei circuiti autogestionari, certo. E, certo, gli anarchici: trasversali ai settori sociali mobilitati e con un radicamento storico e riconosciuto. Ma soprattutto una composizione vastissima, di precariato intellettuale, “colto”, “competente”, l’intellettualità di massa ateniese intorno ai trent’anni. Una quantità di giovani donne e di giovani uomini, anche loro con la faccia del “ritorno in strada”: stavolta, da una parabola più recente d’impegno e di esperienze sociali, che riguarda più direttamente la congiuntura in cui s’inquadra questa rivolta perché è stata quella delle lotte dei tre lustri trascorsi contro le politiche neoliberiste, giunte al saldo fallimentare della crisi globale. E perché è stata una parabola di autodeterminazione, di educazione all’autogestione e a mille nuove declinazioni attive, culturalmente forti, dell’antifascismo.
Lungo il corso Akademias, questo fiume cresce, si espande, tracima. In strada c’è praticamente tutta l’università. Ma non solo: sono tornati, nonostante le botte prese il giorno prima insieme agli insegnanti davanti al Parlamento, i liceali. E sono tornati in forze. Molte scuole sono già state occupate la sera prima dello sciopero. Poi, una partecipazione molto meno determinabile, ma non meno eloquente. Le tribù dei circuiti autogestionari, certo. E, certo, gli anarchici: trasversali ai settori sociali mobilitati e con un radicamento storico e riconosciuto. Ma soprattutto una composizione vastissima, di precariato intellettuale, “colto”, “competente”, l’intellettualità di massa ateniese intorno ai trent’anni. Una quantità di giovani donne e di giovani uomini, anche loro con la faccia del “ritorno in strada”: stavolta, da una parabola più recente d’impegno e di esperienze sociali, che riguarda più direttamente la congiuntura in cui s’inquadra questa rivolta perché è stata quella delle lotte dei tre lustri trascorsi contro le politiche neoliberiste, giunte al saldo fallimentare della crisi globale. E perché è stata una parabola di autodeterminazione, di educazione all’autogestione e a mille nuove declinazioni attive, culturalmente forti, dell’antifascismo. Per tornare ad essere separato e poi a riunirsi di nuovo, a forza di controassalti, altre due, tre volte. E’ un assedio, di massa. Sino a quando non compare da parte della polizia la tattica “genovese”: partono le cariche in piazza ma vengono chiuse anche tutte le laterali “di sfogo” su corso Venizelou, da cui il corteo deve tornare in zona Omonia e Politecnico. E anche da quelle laterali partono cariche: prima da una, poi da altre due, infine da tutte. Il fiume è frantumato. Ma, incredibilmente, aggredito da ogni parte, gasato all’inverosimile, ogni pezzo resiste. Le cariche sono contenute e respinte, una per una. Puoi vedere ragazze “neo-romantic” combattere per il controllo della strada come insorgenti esperte. E puoi vedere ragazzini 13enni, delle medie, scagliarsi ad ondate insieme agli “okupa” veterani sui manipoli di anti-riot. Alla fine, vincono tutti loro: la polizia si trova ad un bivio, decidere per il massacro di massa o la ritirata. Passa la seconda. Troppe le telecamere, sicuramente. Ma troppa anche la sorpresa di episodi come quello animato dagli avventori, normali signore e signori, del café di fronte al Panepistemio, su Venizelou: gli squadroni antisommossa rodeano all’inseguimento dei ragazzi armati di pietre e loro si alzano come un sol uomo dai tavoli, ripresi dalle troupe televisive, per unirsi al grido di sempre. “Dolofoni”: assassini. Gridano “andatevene”, “vergognatevi”, “i ragazzi hanno ragione”. Davvero troppo.
Per tornare ad essere separato e poi a riunirsi di nuovo, a forza di controassalti, altre due, tre volte. E’ un assedio, di massa. Sino a quando non compare da parte della polizia la tattica “genovese”: partono le cariche in piazza ma vengono chiuse anche tutte le laterali “di sfogo” su corso Venizelou, da cui il corteo deve tornare in zona Omonia e Politecnico. E anche da quelle laterali partono cariche: prima da una, poi da altre due, infine da tutte. Il fiume è frantumato. Ma, incredibilmente, aggredito da ogni parte, gasato all’inverosimile, ogni pezzo resiste. Le cariche sono contenute e respinte, una per una. Puoi vedere ragazze “neo-romantic” combattere per il controllo della strada come insorgenti esperte. E puoi vedere ragazzini 13enni, delle medie, scagliarsi ad ondate insieme agli “okupa” veterani sui manipoli di anti-riot. Alla fine, vincono tutti loro: la polizia si trova ad un bivio, decidere per il massacro di massa o la ritirata. Passa la seconda. Troppe le telecamere, sicuramente. Ma troppa anche la sorpresa di episodi come quello animato dagli avventori, normali signore e signori, del café di fronte al Panepistemio, su Venizelou: gli squadroni antisommossa rodeano all’inseguimento dei ragazzi armati di pietre e loro si alzano come un sol uomo dai tavoli, ripresi dalle troupe televisive, per unirsi al grido di sempre. “Dolofoni”: assassini. Gridano “andatevene”, “vergognatevi”, “i ragazzi hanno ragione”. Davvero troppo. L’assemblea è l’epifania definitiva, però. Perché è come ritrovarsi allucinati in un clima da “Trecento”, solo moltiplicato per molte volte, fatto maschile e femminile e alternativo, anziché fascisteggiante. Un clima rivoluzionario, si direbbe: perché si interviene come uno s’è sempre immaginato si intervenisse ai Consigli rivoluzionari in tempo di guerra civile, o al Comitato alle Barricate della Comune di Parigi. E’, in effetti, l’intonazione d’un consiglio di guerra. Queste e questi, in verità, combattono. E hanno deciso di battere anzitutto la paura: l’hanno fatta fuori del tutto, anzi in un tutt’uno con il limite. Sono belli e belle, d’una bellezza eroica, davvero senza retorica, d’eroismo di fatto, integrale, anche nello scandire e nel gestire. Li guardi bene in faccia, uno per uno, una per una, e sono identici spiccicati, sorelle e fratelli gemelli di quelle e quelli che hai visto in Onda in Italia. Sono pragmatici anche i loro discorsi, infatti. Solo che il pragmatismo sta sulle barricate. Certo che è nichilista: parlano esplicitando l’annichilimento di ogni orizzonte, in un mondo di merda, che fa da cornice alla loro ribellione. Sono esplosi nella sola cosa che possono e vogliono mettere a valore, adesso: la comunanza dell’indignazione. Non si danno limiti perché è il potere ad averli oltrepassati: questo è il segno dell’assassinio di Stato di Alexis.
L’assemblea è l’epifania definitiva, però. Perché è come ritrovarsi allucinati in un clima da “Trecento”, solo moltiplicato per molte volte, fatto maschile e femminile e alternativo, anziché fascisteggiante. Un clima rivoluzionario, si direbbe: perché si interviene come uno s’è sempre immaginato si intervenisse ai Consigli rivoluzionari in tempo di guerra civile, o al Comitato alle Barricate della Comune di Parigi. E’, in effetti, l’intonazione d’un consiglio di guerra. Queste e questi, in verità, combattono. E hanno deciso di battere anzitutto la paura: l’hanno fatta fuori del tutto, anzi in un tutt’uno con il limite. Sono belli e belle, d’una bellezza eroica, davvero senza retorica, d’eroismo di fatto, integrale, anche nello scandire e nel gestire. Li guardi bene in faccia, uno per uno, una per una, e sono identici spiccicati, sorelle e fratelli gemelli di quelle e quelli che hai visto in Onda in Italia. Sono pragmatici anche i loro discorsi, infatti. Solo che il pragmatismo sta sulle barricate. Certo che è nichilista: parlano esplicitando l’annichilimento di ogni orizzonte, in un mondo di merda, che fa da cornice alla loro ribellione. Sono esplosi nella sola cosa che possono e vogliono mettere a valore, adesso: la comunanza dell’indignazione. Non si danno limiti perché è il potere ad averli oltrepassati: questo è il segno dell’assassinio di Stato di Alexis.




 o dissociarsi. Ex militante della Rote armee fraktion (Raf), Klar uscirà dal carcere il 3 gennaio 2009 al maturare del ventiseiesimo anno di detenzione (forse anche prima, se le riduzioni di pena legate alla buona condotta lo consentiranno), 7 dei quali passati in totale isolamento. Klar aveva ottenuto la possibilità di uscire in permesso già dalla primavera scorsa. In realtà la parola fine potrà dirsi soltanto dopo la liberazione di Birgit Hogefeld, arrestata nel 1993, ed unica a restare ancora detenuta dopo la liberazione condizionale concessa a Klar. Esponente dell’ultima fase della storia politico-militare della Raf (la cosiddetta “terza generazione”, definizione che però viene rigettata dai membri del gruppo autodiscioltosi nel 1998, i quali hanno sempre messo l’accento sull’unità del percorso della loro organizzazione), la Hogefeld è liberabile a partire dal 2011.
o dissociarsi. Ex militante della Rote armee fraktion (Raf), Klar uscirà dal carcere il 3 gennaio 2009 al maturare del ventiseiesimo anno di detenzione (forse anche prima, se le riduzioni di pena legate alla buona condotta lo consentiranno), 7 dei quali passati in totale isolamento. Klar aveva ottenuto la possibilità di uscire in permesso già dalla primavera scorsa. In realtà la parola fine potrà dirsi soltanto dopo la liberazione di Birgit Hogefeld, arrestata nel 1993, ed unica a restare ancora detenuta dopo la liberazione condizionale concessa a Klar. Esponente dell’ultima fase della storia politico-militare della Raf (la cosiddetta “terza generazione”, definizione che però viene rigettata dai membri del gruppo autodiscioltosi nel 1998, i quali hanno sempre messo l’accento sull’unità del percorso della loro organizzazione), la Hogefeld è liberabile a partire dal 2011. conferenza su Luxenburg-Liebknecht, tenutasi a Berlino nel gennaio dello stesso anno, nel quale Klar auspicava una società futura senza capitalismo. Campagna mediatica che chiedeva una esplicita dichiarazione di pentimento come condizione necessaria alla scarcerazione. Tuttavia ciò non ha impedito che nell’agosto successivo fosse concessa la liberazione condizionale anche a Eva Haule, dopo 21 anni di carcere. Incassato il rifiuto della grazia, Klar ha continuato a difendere il proprio diritto di tacere (da intendersi come il rifiuto di sottomettersi a dichiarazioni pubbliche di pentimento) e non fare mercanteggiamenti per uscire. Il 15 agosto 2008 è sopraggiunta una importante decisione della Corte federale che ha chiarito come il diritto al silenzio sia compatibile con terrorlistel’ammissione ai benefici di legge. Questa sentenza ha così definitivamente sbloccato la situazione.
conferenza su Luxenburg-Liebknecht, tenutasi a Berlino nel gennaio dello stesso anno, nel quale Klar auspicava una società futura senza capitalismo. Campagna mediatica che chiedeva una esplicita dichiarazione di pentimento come condizione necessaria alla scarcerazione. Tuttavia ciò non ha impedito che nell’agosto successivo fosse concessa la liberazione condizionale anche a Eva Haule, dopo 21 anni di carcere. Incassato il rifiuto della grazia, Klar ha continuato a difendere il proprio diritto di tacere (da intendersi come il rifiuto di sottomettersi a dichiarazioni pubbliche di pentimento) e non fare mercanteggiamenti per uscire. Il 15 agosto 2008 è sopraggiunta una importante decisione della Corte federale che ha chiarito come il diritto al silenzio sia compatibile con terrorlistel’ammissione ai benefici di legge. Questa sentenza ha così definitivamente sbloccato la situazione.












 Sarei proprio voluta esserci…perchè l’idea che se la sono data a gambe in questo modo rocambolesco mi mette proprio di buon umore. Poi proprio a Koln, una città che ho visto con i miei occhi come convive con le tante etnie rifugiate. Una città che mi ha accolto per un mese, avvolta da migranti kurdi, e che ha dimostrato ogni momento la piena tolleranza, l’amichevole convivenza, l’ospitalità che ha stupito anche me.
Sarei proprio voluta esserci…perchè l’idea che se la sono data a gambe in questo modo rocambolesco mi mette proprio di buon umore. Poi proprio a Koln, una città che ho visto con i miei occhi come convive con le tante etnie rifugiate. Una città che mi ha accolto per un mese, avvolta da migranti kurdi, e che ha dimostrato ogni momento la piena tolleranza, l’amichevole convivenza, l’ospitalità che ha stupito anche me. . Per evitare le contestazioni degli anti-fascisti (ne sono attesi 50 mila domani nella piazza del mercato), ha deciso all’insaputa di tutti di tenere la ‘conferenza stampa internazionale’ cinque chilometri più a sud. La nuova sede avrebbe dovuto essere la circoscrizione di Roedenkirchen, sulle sponde del Reno. Qui si sono radunati tutti, soprattutto una manciata di militanti antifascisti che, precedendo persino i giornalisti della Ard, il canale nazionale tedesco, della Zeit e vari altri, li hanno accolti con slogan e fischietti, minacciando di aggredirli fisicamente. La fuga, a quanto racconta l’unico giornalista che ha assistito alla scena, il corrispondente locale della Tageszeitung, Pascale Beucker, è stata precipitosa. La decina di politici e attivisti di Pro-Koeln ha in fretta e furia lasciato Rodenkirchen per salire su un battello sul Reno e dirigersi verso il porto fluviale di Nihl, sei chilometri più a nord. Beucker è l’unico ad aver assistito agli insulti e alla sassaiola degli antifascisti, che ha costretto quelli di Pro-Koeln a mollare gli ormeggi più in fretta che potevano.
. Per evitare le contestazioni degli anti-fascisti (ne sono attesi 50 mila domani nella piazza del mercato), ha deciso all’insaputa di tutti di tenere la ‘conferenza stampa internazionale’ cinque chilometri più a sud. La nuova sede avrebbe dovuto essere la circoscrizione di Roedenkirchen, sulle sponde del Reno. Qui si sono radunati tutti, soprattutto una manciata di militanti antifascisti che, precedendo persino i giornalisti della Ard, il canale nazionale tedesco, della Zeit e vari altri, li hanno accolti con slogan e fischietti, minacciando di aggredirli fisicamente. La fuga, a quanto racconta l’unico giornalista che ha assistito alla scena, il corrispondente locale della Tageszeitung, Pascale Beucker, è stata precipitosa. La decina di politici e attivisti di Pro-Koeln ha in fretta e furia lasciato Rodenkirchen per salire su un battello sul Reno e dirigersi verso il porto fluviale di Nihl, sei chilometri più a nord. Beucker è l’unico ad aver assistito agli insulti e alla sassaiola degli antifascisti, che ha costretto quelli di Pro-Koeln a mollare gli ormeggi più in fretta che potevano.




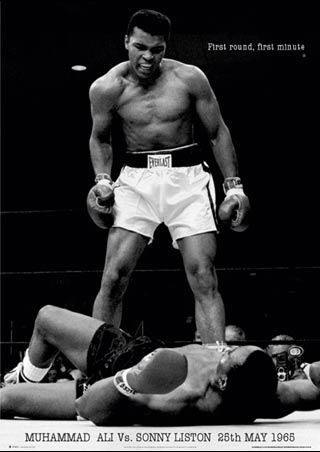




























Commenti recenti